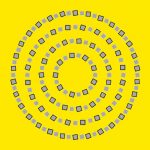Nel Pensiero selvaggio Claude Lévi-Strauss non parla più di primitivi. Tutto ciò diventa possibile nel momento in cui si compie un decentramento della cultura europea. La cultura europea viene scardinata (Derrida, La struttura, il segno e il gioco – 1966), viene scacciata dal suo posto e costretta a non considerarsi più come cultura di riferimento. Questo avvenimento non riguarda la filosofia o la cultura. Non si tratta di un cambiamento di idee, di un rivolgimento nel pensiero, di una riconsiderazione delle posizioni, per così dire, teoriche. Questo avvenimento – che riguarda anche le scienze e la cultura in generale – è un avvenimento politico ed economico. Corrisponde ad un cambiamento di vasta portata nella geografia politica.
Le virgolette che cingono il primitivo segnalano appunto questo decentramento. Col tempo le virgolette si impongono anche nell’uso quotidiano per segnalare questo avvenimento.
I primitivi sono considerati tali rispetto ad un centro che, sincronicamente e diacronicamente, gerarchizza le posizioni: livello primitivo di un esemplare evoluto e istanza periferica di un centro regolatore. Quando l’Europa cessa di essere il centro del mondo, anche l’idea stessa di centro viene revocata. Se il centro è dappertutto, non ha più alcun senso parlare di primitivi. Nell’attesa di nuovi nomi, meglio parlare di “primitivi”, anziché di primitivi.
Se col tempo anche le virgolette cominciano a suscitare qualche sospetto, ciò è dovuto al fatto che il centro ha continuato a funzionare nonostante le virgolette, le quali, a questo punto, non possono non apparire per quello che sono, una sorta di ipocrisia, oppure, più correttamente, un supplemento di centro.
Al confronto con i civilizzati i primitivi sono sempre apparsi come meno evoluti, meno acculturati, meno informati, meno capaci di rapportarsi all’ambiente e di comprenderlo, più semplici, più rozzi, eccetera.
I primitivi erano studiati come si studiavano le carte d’archivio, come documenti di una innocenza perduta. Ci volle tempo per capire che i documenti non erano quel lascito neutro che si credeva fossero. Quando quel tempo arrivò, le certezze in essi riposte vacillarono e si infransero.
Spesso e volentieri, dice Lévi-Strauss, per dimostrare l’inettitudine degli indigeni ci si è compiaciti di citare i casi di quei “primitivi” incapaci, nei loro idiomi, di astrazione. Che l’argomento fosse tendenzioso è dimostrato dai casi contrari, nei quali i termini generali prevalgono sugli appellativi specifici. Queste evidenze non erano affatto sufficienti a impedire di affermare la povertà intellettuale dei selvaggi. Anche in tempi recenti, dice Lévi-Strauss (siamo negli anni Sessanta del Novecento – Il pensiero selvaggio, 1962), c’è chi è convinto che l’indigeno conosca esclusivamente in funzione dei suoi bisogni organici. Non bisogna dunque stupirsi se anche Malinowski sosteneva che l’interesse dei primitivi per le piante e gli animali totemici veniva loro ispirato dai brontolii dello stomaco.
Secondo quanto riportato dall’etnologo Speck, gli indiani d’America del Nord-ovest avevano elaborato una vera e propria erpetologia, con termini diversi per ciascun genere di rettili. Mentre i prodotti naturali utilizzati dai popoli siberiani per scopi medicinali, e il valore specifico loro attribuito, erano definiti con una precisione che dimostra tutta la cura, l’acume, l’attenzione per i particolari e la preoccupazione delle distinzioni che avevano dovuto usare gli osservatori e i teorici nelle società di questo tipo: ragni e vermi bianchi inghiottiti (sterilità); grasso di scarabeo nero (idrofobia); blatta schiacciata, fiele di gallina (ascessi ed ernia); vermi rossi macerati (reumatismo); fiele di luccio (malattie degli occhi); lasca, granchi inghiottiti vivi (epilessia e altre malattie); contatto del becco di picchio, sangue di picchio, insufflazione nasale di polvere di picchio mummificato, uovo ingollato dell’uccello koulcha (contro il mal di denti, scrofola, malattie di equini e tubercolosi), sangue di pernice, sudore equino (ernie e verruche), eccetera.
Qualcuno, dice Lévi-Strauss, obietterà che una simile scienza non può avere una grande efficacia sul piano pratico. Appunto! Il suo obiettivo, dice Lévi-Strauss, non è di tipo pratico. Essa risponde ad esigenze intellettuali. Il vero problema non consiste nel sapere se il picchio cura il mal di denti, ma se è possibile far andar d’accordo il picchio e il dente dell’uomo, per introdurre, attraverso questi accostamenti di cose e di esseri, un principio d’ordine dell’universo.
Un criterio ordinativo, qualunque esso sia, ha sempre un valore rispetto all’assenza di ogni ordinamento. L’esigenza d’ordine, dice Lévi-Strauss, sta alla base del cosiddetto pensiero primitivo, ma solo in quanto sta alla base di ogni pensiero (su questo assunto, che scivola senza attrito, bisognerà tornare).
La magia non si distingue dalla scienza se non per un diverso principio ordinativo. E se la scienza dispone gli elementi trattati dalla magia in un ordine diverso, ciò non vuol dire né che la magia sia priva di significato, né che la scienza abbia una valenza superiore alla magia. Si tratta di ordini differenti. Per esempio, dice Lévi-Strauss, la sola Intuizione ci indurrebbe a includere in uno stesso gruppo la cipolla, l’aglio, il cavolo, il ravizzone, il ravanello e la senape, benché la Botanica separi le liliacee dalla crucifere. La Chimica convalida la testimonianza della Sensibilità e prova che queste famiglie tra loro estranee si collegano su un altro piano: contengono zolfo. Dunque, non bisogna considerare il pensiero selvaggio – la magia, ad esempio – come una forma timida e balbettante di scienza, riducendo così il pensiero magico a un momento o a una tappa dell’evoluzione tecnica e scientifica, perché con ciò ci si priverebbe di ogni possibilità di comprenderlo. La sensibilità che mette insieme cipolle e cavoli e che trova l’ordine nello zolfo non è meno razionale della scienza botanica che li divide perché cerca l’ordine nelle foglie disposte a croce o in altro modo. L’ordine sensibile non rappresenta lo stadio primitivo di quello botanico.
Qual è dunque la differenza tra l’ordine scientifico e l’ordine magico?
Al giorno d’oggi, dice Lévi-Strauss, sopravvive una forma di attività che, sul piano tecnico, permette di renderci conto abbastanza bene delle caratteristiche, sul piano speculativo, del sistema di pensiero selvaggio. Questa forma è il bricolage.
II
Il bricoleur, dice Lévi-Strauss (Il pensiero selvaggio) è capace di eseguire un gran numero di compiti differenziati, ma, diversamente dall’architetto, non li subordina al possesso di materie prime e di arnesi, concepiti e procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto: il suo universo strumentale è chiuso, e, per lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di cui dispone, cioè ad un insieme via via «finito» di arnesi e di materiali, peraltro eterocliti, dato che la composizione di questo insieme non è in rapporto con il progetto del momento, né d’altronde con nessun progetto in particolare, ma è il risultato contingente di tutte le occasioni che si sono presentate di rinnovare o di arricchire lo stock o di conservarlo con i residui di costruzioni e di distruzioni antecedenti. L’insieme dei mezzi del bricoleur non è dunque definibile in base a un progetto (la qual cosa presupporrebbe, almeno in teoria, l’esistenza di tanti complessi strumentali quanti sono i generi di progetto, come accade all’architetto); esso si definisce solo in base alla sua strumentalità, cioè, detto in altre parole e adoperando lo stesso linguaggio del bricoleur, perché gli elementi sono raccolti o conservati in virtù del principio che possono sempre servire.
L’architetto subordina al progetto la fornitura degli strumenti e della materia prima. Ha preventivamente costruito l’oggetto nella sua testa prima di costruirlo effettivamente. Alla fine del processo lavorativo emergerà un risultato che era già presente al suo inizio nell’idea, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui soltanto un cambiamento di forma dell’elemento naturale; egli realizza nell’elemento naturale, allo stesso tempo, il proprio scopo, da lui ben conosciuto, che determina come legge il modo del suo operare, e al quale deve subordinare la sua volontà. E questa subordinazione non è un atto isolato. Oltre lo sforzo degli organi che lavorano, è necessaria, per tutta la durata del lavoro, la volontà conforme allo scopo, ossia il lavoro stesso, l’oggetto del lavoro e i mezzi del lavoro (Marx, Capitale, I,5).
Ciò che distingue l’architetto dal bricoleur è il progetto.
Il progetto non è trovato dall’architetto bello e pronto tra le cose che possono servire, non è un materiale o un arnese che la storia non si è ancora incaricata di far scomparire e che è pronto all’uso. Il progetto è il sistema con il quale si definiscono uno scopo e una procedura, e gli strumenti e le materie prime per realizzarlo. Al di fuori del progetto né gli strumenti né le materie prime possono essere definiti tali. Il senso che essi acquistano (in quanto strumenti e materie prime) lo acquistano nei limiti del progetto. Gli elementi usati dall’architetto hanno un ancoraggio assoluto ad un punto centrale che gli fornisce senso, cioè il progetto. Al contrario, gli elementi di cui fa uso il bricoleur non hanno un ancoraggio esclusivo. Sono mobili. Possono essere ricomposti in infinite combinazioni. Possono servire a scopi diversi. Possono essere adattati a molti contesti. Due tappi di acqua Lete, alcuni bicchieri di plastica usati, una spillatrice e della colla, oppure un listello di legno, un cordoncino di stoffa, due viti, un cesto di vimini, delle scatole di biscotti, possono essere usati per costruire un pupazzo, possono significare Babbo Natale. Non sono vincolati ad alcun progetto, non hanno un centro che li fissa ad una significazione definitiva, sono mobili, ricomponibili, riusabili. Presi da soli non sono niente, nemmeno scarti. Diventano scarti, spazzatura, quando lì si struttura come cumulo ingombrante. L’ingombro non è una proprietà di ogni singolo pezzo. È l’insieme ad essere ingombrante. Solo l’insieme fa la spazzatura. Ricombinati in un altro ordine gli stessi elementi formano un pupazzo. Non si può certamente negare che le due strutture (spazzatura e pupazzo) abbiano ciascuna un senso ben preciso, una razionalità facilmente riconoscibile. Non ha alcun senso dire che la spazzatura è meno razionale del pupazzo, oppure che la spazzatura è uno stadio primitivo del pupazzo. Nemmeno ha senso dire che l’insieme degli elementi accumulati perché possono servire sia lo stadio primitivo del pupazzo o della spazzatura. Gli elementi 1) accumulati perché possono servire, 2) la spazzatura e 3) il pupazzo, formano tre serie distinte, tutte e tre legittime.
La differenza che passa tra la scienza e la magia è una differenza di struttura. Si tratta di due strutture, entrambe razionali, che dispongono gli elementi in ordini differenti, questi due ordini non sono gerarchizzabili. In più, l’ancoraggio assoluto degli elementi della serie disposta dall’architetto è tale solo nella struttura disposta dal progetto. Ma il progetto può benissimo apparire come un ordine seriale disposto da un blicoleur. Anzi, il progetto è sicuramente il prodotto di un bricoleur, altrimenti l’architetto, secondo la sua intenzione, avrebbe dovuto costruire da sé la totalità del suo linguaggio, sintassi e lessico. Ma, inteso in questo senso (cioè come egli si intende), l’architetto è un mito. Un soggetto che fosse l’origine assoluta del proprio discorso e lo costruisse «tutto d’un pezzo», dice Derrida (La struttura, il segno e il gioco), sarebbe il creatore del verbo, il verbo in persona. L’idea di un architetto che avrebbe rotto con ogni tipo di bricoleur è dunque un’idea teologica; e poiché Lévi-Strauss dice che il bricolage è mitopoietico, c’è da credere che l’architetto sia un mito prodotto dal bricoleur.
Gli elementi della serie non sono mai incardinabili in un ordine definitivo, e non lo sono perché manca un centro fisso. A questo punto il bricoleur fa apparire il lavoro dell’architetto, e ogni ricerca scientifica di un principio centrale e fondamentale, come il proposito di un mitomane. Se non c’è alcun principio, alcun fondamento e alcun centro di ancoraggio assoluti, cosa distingue la scienza dalla magia, l’oroscopo dalla statistica, il malocchio o lo scongiuro dalla medicina, il vaccino dalla tisana, la preveggenza dall’epidemiologia?
Niente.
L’oroscopo stabilisce delle relazioni tra la configurazione degli astri, il luogo di nascita e il momento della nascita, e da ciò ricava delle previsioni in modo del tutto razionale.
Tuttavia, aggiunge Derrida, nel momento in cui si viene ad ammettere che ogni discorso finito è vincolato a un certo bricolage, che l’architetto o lo scienziato sono anch’essi delle specie di bricoleurs, ne consegue che l’idea stessa di bricoleur diventa precaria, svanisce la differenza nella quale essa assumeva un senso.
Se fin qui tutto questo discorso ha potuto camminare sulla proprie gambe, se ha potuto funzionare, nonostante l’abolizione della differenza tra architetto e bricoleur, differenza grazie alla quale ha potuto strutturarsi, significa che esso si è appoggiato a qualche altra differenza. Il tentativo di Lévi-Strauss di superare la differenza tra primitivo e civilizzato, tentativo che si è misurato con la differenza tra mito e scienza, tra bricoleur e architetto, non ha potuto avanzare se non istallandosi in un’altra differenza. E ciò perché, dice Derrida, ogni tentativo di superare la gerarchizzazione, qualsiasi gerarchizzazione, non fa che reintrodurre, sotto altre vesti, quella stessa gerarchia della quale ci si voleva sbarazzare. Non c’è verso di liberarsi con la critica della gerarchia, senza rinunciare con ciò alla critica stessa. Non si può rinunciare alla complicità metafisica, dice Derrida, senza rinunciare nello stesso tempo al lavoro critico che si rivolge contro di essa. Non ha alcun senso – dice Derrida – non servirsi dei concetti della metafisica per far crollare la metafisica; non disponiamo di alcun altro linguaggio – di alcuna sintassi e di alcun lessico – che sia estraneo a questa storia; non possiamo enunciare nessuna proposizione distruttrice che non abbia già dovuto insinuarsi nella forma, nella logica e nei postulati impliciti a quello stesso che essa vorrebbe contestare. In più, siccome i concetti non sono affatto elementi, atomi, dato che sono assunti in una sintassi e in un sistema, ogni assunzione determinata reintroduce in essi per intero la metafisica.
Arrivati a questo punto non si tratta di alzare bandiera bianca, e riconoscere l’impossibilità di sottrarsi alla gerarchia, di sottrarsi a quel centro in cui siamo situati sin dalla nascita e che non ci lascia andare nemmeno quando tentiamo con ogni mezzo di sfuggirgli, che ci trattiene con ancora maggior forza, proprio quando tentiamo di sottrarci ad esso.
Intanto, dice Derrida, se è pur vero che è impossibile sfuggire alla presa del centro, e che questa impossibilità non è una contingenza storica, non è qualcosa che, così come è nata, può cessare, ma è una necessità irriducibile; se è pur vero che nessuno vi può sfuggire, e che se nessuno porta la responsabilità di cedervi, sia pure in misura minima, ciò non significa che tutti i modi di cedere siano di uguale pertinenza. E in ogni caso rimane da chiedersi se la differenza a partire dalla quale un sistema si struttura non sia sovra-determinata da un differimento sfuggente al calcolo della differenza.
Sia come sia, lo sforzo ammirevole di Lévi-Strauss consiste nel ribaltare tutte le precauzioni critiche a proposito della scienza e del mito sul suo proprio stesso discorso. Non potendosi più appoggiare su niente, avendo messo in discussione ogni riferimento ad un centro, a un soggetto, a un punto privilegiato, a un’origine o a un’archia assoluta, non può che pensarsi e operare come opera il bricoleur, rinunciando al discorso scientifico e filosofico.
Rinunciando all’episteme – dice Derrida – la quale ha per esigenza assoluta, anzi che è l’esigenza assoluta di risalire alla sorgente, al centro, al fondamento, al principio, ecc., in opposizione al discorso epistemico, il discorso strutturalista sui miti, il discorso mito-logico, deve essere esso stesso, mito-morfo. Deve avere la forma di ciò di cui parla. È qui che il bricolage etnografico assume deliberatamente la sua funzione mitopoietica. Ma nello stesso tempo, quest’ultima fa apparire come mitologica, cioè come un’illusione storica, l’esigenza epistemologica o filosofica del centro.
Nondimeno, dice Derrida, anche se si accetta la necessità del gesto di Lévi-Strauss, non è possibile ignorarne i rischi. Se la mito-logica è mito-morfa, questo significa che tutti i discorsi sul mito si equivalgono? Bisognerà dunque abbandonare ogni esigenza epistemologica che permetta di distinguere tra diverse qualità di discorsi sul mito?
La risposta a questa domanda non è semplice. Nella Grammatologia, un testo quasi sistematico che Derrida stava scrivendo negli stessi mesi (1966) in cui tiene alla John Hopkins di Baltimora la famosa conferenza su La struttura, il segno e il gioco, per una risposta a questa domanda rimanda spesso a Nascita della Geometria di Husserl.
III
Se è impossibile sfuggire alla presa del centro, e ognuno vi cede a modo proprio, qual è il modo in cui ha dovuto cedervi Lévi-Strauss?
L’obiettivo di Lévi-Strauss, evidente soprattutto in Tristi tropici, dice Derrida (Grammatologia, 170) era di mostrare su cosa si basa e cosa permette lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Siccome questo sfruttamento per Lévi-Strauss si basa sulla tecnica, allora l’impegno che egli assunse fu di fondare una teoria marxista della tecnica. Lévi-Strauss espresse questa intenzione in una lettera del 1955 (anno di pubblicazione di Tristi tropici) alla Nouvelle Critique.
In questa lettera dice che nel libro, oltre ad aver formulato una ipotesi marxista sull’origine della tecnica (in verità della scrittura), ha proposto due studi che sono tentativi di interpretazione delle sovrastrutture indigene fondata sul materialismo dialettico.
Derrida è molto duro. Accusa Lévi-Strauss di aver impresso al marxismo una svolta pauperista, pacifista, terzomondista, persino buddista, eccetera, e di averlo distolto dal suo rigore e dalla sua tematica proprie.
Tristi Tropici avrà un grande impatto in Francia e all’estero. La giuria del premio Goncourt si scusò di non avergli potuto assegnare il suo prestigioso premio, perché il libro non è un romanzo. E se sin dagli anni Cinquanta del Novecento una buona fetta della sinistra occidentale si riposizionerà su tematiche quali il pacifismo, l’esotismo, l’esoterismo, il buddismo – per indicare i temi più soft -, oppure farà arretrare lo sfruttamento e persino di capitalismo al tempo di Noè, ciò non fu solo merito di Lévi-Strauss, vi concorsero altri fattori, per esempio la Scuola di Francoforte. Questo arretramento tolse al marxismo – in quanto teoria del plusvalore – il suo terreno proprio, annacquandolo in una teoria più generale dello sfruttamento, che trovò nella tecnica, e soprattutto nella perdita dell’innocenza della comunità (primitiva), i suoi temi portanti. Persino il tema del comunismo venne inteso, se non come ripristino di questo stato adamitico, perlomeno come abolizione di tutto ciò che si frappone tra l’uomo e l’uomo, impedendo un contatto vero, puro, sincero, innocente. Il comunismo diventò una teoria dell’innocenza – dell’innocenza perduta e dell’innocenza da ritrovare. Fra la teoria marxista che libera l’uomo dalle sue prime catene – si legge in Tristi tropici – e la critica buddista che completa la liberazione, non c’è né opposizione né contraddizione. Fanno tutte e due la stessa cosa a un livello diverso.
Criticando Lévi-Strauss, Derrida cerca di riportare il marxismo sul terreno più consono.
L’argomento che permette a Lévi-Strauss di riposizionare il marxismo sul versante del pauperismo e dell’innocenza comunitarista può essere riassunto come segue. Ad uno stadio di immediatezza subentra uno stadio di mediazione. La mediazione interpone tra uomo e uomo uno strumento tecnico esteriore, questo strumento permette la gerarchizzazione e lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo.
Questo tema non è nuovo. È uno tema antico. Lévi-Strauss ne ritrova la matrice perfetta in Rousseau, che assume come suo riferimento principale. Rousseau è il vero fondatore dell’etnologia – dice Lévi-Strauss – nel secondo Discorso pone risolutamente il problema dei rapporti tra la natura e la cultura. Questo argomento della immediatezza contro la mediazione è stato schematizzato e banalizzato in diversi ambiti. È stato usato per sostenere la democrazia diretta vs la delega, il sindacalismo di base vs il funzionario sindacale, la scambio diretto vs scambio mercificato, la transazione tra pari vs la transazione monetaria, il Km0 vs i mercati generali, la Medicina alternativa vs la Scienza medica, la Tisana vs l’Aspirina, Andare a piedi vs la macchina – la lista è lunghissima – i fagioli secchi vs i fagioli in scatola, le scarpe camper vs le adidas, la biro vs il tablet, il libro di carta vs il kindle, il referendum vs il parlamento, il click vs la scheda elettorale, lo spinello vs l’estasi, eccetera. È evidente che una revoca di questo argomento permette di cestinare tutte le attuali e possibili sue applicazioni.
A farsi carico di questa revoca è stato Derrida.
IV
Lévi-Strauss prende di mira lo strumento tecnico per antonomasia, la scrittura, e mostra come e perché si debba costruire un sistema di difesa contro la sua violenza.
Perché e in cosa la scrittura è violenta?
Lévi-Strauss, dice Derrida, ha scritto poche pagine sulla scrittura, molto belle e fatte per stupire, enunciando l’anatema che l’Occidente ostinatamente ha ripetuto dal Fedro al Corso di linguistica generale.
Alcune di queste pagine riguardano la sua esperienza con i Nambikwara, una banda di indigeni nomadi, si legge in Tristi tropici, che sono tra i più primitivi che si possano incontrare nel mondo, distribuiti su un territorio grande come la Francia. È dubbio, scrive Lévi-Strauss, che i Nambikwara sappiano scrivere, e sembra che non abbiano nomi propri. Ciò è confermato dell’esperienza di altri Occidentali che si erano avventurati nella giungla per installare una linea telegrafica.
Questa incapacità di scrivere, dice Derrida, è pensata da Lévi-Strauss nell’ordine etico-politico, come una innocenza e una non-violenza, interrotte dall’effrazione occidentale e da una «Lezione di scrittura» che lo stesso Lévi-Strauss terrà ai Nambikwara.
Prima di affrontare direttamente questa Lezione di scrittura, e dunque la violenza impartita agli indigeni dall’etnologo Occidentale, Derrida ci tiene a raccontare un episodio accaduto prima della Lezione.
Un giorno, per caso, Lévi-Strauss scopre che i Nambikwara hanno, invece, nomi propri, e che questi nomi sono tenuti nascosti, non vengono usati, non vengono pronunciati, e che, anzi, pronunciarli costituisce un atto ostile.
Ora, si chiede Derrida, come è possibile rifiutare la pratica di scrittura in generale ad una società (ai Nambikwara nella fattispecie) capace di obliterare il proprio, cioè ad una società violenta. Che la società sia violenta è confermato dallo svelamento dei nomi propri. Bisogna forse considerare, dice Derrida, che la violenza, al contrario di ciò che crede Lévi-Strauss, non sopraggiunga d’un tratto, a partire da un’innocenza originale la cui nudità sarebbe sorpresa, nel momento in cui il segreto dei nomi sedicenti propri è violato. Infatti, continua Derrida, prima della diffusione dei nomi propri come atto ostile, c’è una violenza ancora precedente, che consiste proprio nel nominare. Nominare, dare i nomi che sarà eventualmente proibito pronunciare, è la violenza originaria del linguaggio che consiste nell’iscrivere in una differenza, nel classificare, nel sospendere il vocativo assoluto. Pensare l’unico nel sistema, iscriverlo (in senso lato), questo è il gesto di una violenza precedente (di un’archi-violenza e di un’archi-scrittura) che si esplicita nella perdita del proprio, della prossimità assoluta, della presenza a sé. Una perdita, continua Derrida, di ciò che non ha mai avuto luogo, di una presenza a sé che non è stata mai data, ma sognata e sempre più sdoppiata, ripetuta, incapace di apparire altrimenti che nella propri sparizione. Non c’è alcun proprio e alcuna proprietà del proprio prima dell’iscrizione. L’iscrizione precede il proprio, il sentimento di sé, il sé, il presso di sé, l’a casa propria. E siccome l’iscrizione, come ribadisce lo stesso Lévi-Strauss in molti luoghi (nel Pensiero Selvaggio, ad esempio), non è formata da atomi, ma è assunta in una sintassi e in un sistema, dunque il senso del proprio emerge in un sistema differenziale, in un sistema di effrazione reciproca, verrebbe da dire di violenza originaria, se non fosse che qui l’origine è un sogno o una possibilità che si struttura a partire dalla differenza, ovvero dallo sdoppiamento, e non il contrario.
È a partire da questa archi-violenza, interdetta e dunque confermata da una seconda violenza riparatrice, protettrice, che istituisce la «morale», che prescrive di nascondere la scrittura, di cancellare e di obliterare il se-dicente nome proprio che già divideva il proprio; è a partire da questa archi-violenza, dice Derrida, che una terza violenza può eventualmente sorgere o non sorgere (possibilità empirica) in ciò che si chiama correntemente il male, la guerra, l’indiscrezione, la violazione: che consistono nel rivelare per effrazione il nome se-dicente proprio, cioè la violenza originaria che ha strappato il proprio dalla sua proprietà e dalla sua appropriatezza. Terza violenza di riflessione, si potrebbe dire, che denuda la non-identità nativa, la classificazione come snaturamento del proprio, e l’identità come momento astratto del concetto. È a questo livello terziario, quello della coscienza empirica, che si dovrebbe probabilmente situare il concetto comune di violenza (il sistema della legge morale e della trasgressione). È a questo livello che è iscritta la scena dei nomi propri; e più tardi la lezione di scrittura. Lévi-Strauss, invece, arretra la scena della Lezione e della rivelazione dei nomi ad una violenza prima, violenza che verrebbe a turbare uno stato di innocenza primitiva, di prossimità selvatica.
Dunque, ricapitolando, c’è una prima violenza che consiste nel dare i nomi, alla quale segue una seconda violenza riparatrice, protettrice, che istituisce la «morale», e che consiste nell’interdire, nell’obliterare il se-dicente nome proprio (se-dicente, appunto perché, per funzionare come nome proprio, ogni nome deve essere un nome comune, un nome comunicabile, e dunque improprio; se un nome vuole essere proprio deve essere improprio – legge apriori dei nomi). A questa seconda violenza può fare seguito una terza violenza che consiste in ciò che comunemente si chiama il male, la guerra, l’indiscrezione, al violazione; violenza che consiste nel rivelare il se-dicente nome proprio, nel rivelare cioè la violenza originaria che ha strappato il proprio dalla sua proprietà e dalla sua appropriatezza. Una terza violenza, dice Derrida, che denuda la non-identità nativa, la classificazione come snaturamento del proprio, e l’identità come momento astratto del concetto.
Questa terza violenza, dice Derrida, è complessa nella sua struttura, in quanto rinvia agli altri due strati di violenza: l’archi-violenza e la violenza della Legge (la violenza morale che oblitera il nome, che vieta la pronuncia del nome, in quando la sua pronuncia svelerebbe il segreto del nome proprio, cioè che esso non è proprio). Questa terza violenza, dice Derrida (162), rivela infatti la prima nominazione che era già una espropriazione [perché nell’atto stesso di nominare poneva il proprio nell’improprio, poneva il nome proprio ponendolo come nome comune, come nome noto – posto che un nome ignoto non è un nome], ma che denuda anche ciò che da allora fa funzione di proprio, il se-dicente proprio, sostituto del proprio differito, percepito dalla coscienza sociale e morale come il proprio, il sigillo che rassicura dell’identità di sé, il segreto.
Questa terza violenza, in un gesto unico, 1) rivela il proprio come im-proprio (come ex-proprio), e 2) denuda il segreto grazie al quale qualcosa come un nome proprio (il se-dicente nome proprio) può funzionare come sostituto, come supplente di un proprio differito – di un proprio che non è mai stato proprio.
La terza violenza, la violenza empirica, guerra nel senso corrente, sopraggiungerebbe, secondo Lévi-Strauss, su un terreno di innocenza, in uno stato di cultura (se così si può chiamare) la cui bontà naturale non si sarebbe ancora degradata. La violenza arriverebbe dall’esterno, e come nel caso della guerra dei nomi, a portarla sarebbe l’etnologo, il quale arriverebbe a disturbare l’ordine e la pace naturale, la complicità che legherebbe pacificamente la buona società e se stessa e nel suo gioco.
È l’etnologo che viola uno spazio vergine. La sua semplice presenza, come voyeur, è una violazione.
Non si può certo dire che la violazione dei Nomi Propri venga ad intaccare con la guerra uno stato primitivo di innocenza. Come ha mostrato Derrida la violazione rappresenta un terzo livello di violenza, il quale si innesta su altri due livelli, senza i quali non sarebbe possibile. Dunque, non è l’etnologo a portare la violenza presso i primitivi. La violenza non arriva dall’eterno, essa è già presente, prim’ancora dell’intervento dell’etnologo.
Non c’è alcuna innocenza prima della scienza e della rivelazione dei nomi.
Viene il sospetto, dice Derrida, che la critica dell’etnocentrismo, tema così caro all’autore dei Tristi tropici, abbia il più delle volte solo la funzione di costituire l’altro a modello della bontà originale e naturale, di accusarsi e di umiliarsi, di esibire il proprio essere inaccettabile in uno specchio contro-etnocentrico. Questa umiltà di chi si sa «inaccettabile», questo rimorso che produce l’etnografia, Rousseau li avrebbe insegnati all’etnologo moderno. In più, dice Derrida, i popoli non-europei non vengono studiati solo come indice di una buona natura nascosta, di un suolo nativo ricoperto, di un «grado zero» in rapporto al quale si potrebbe disegnare la struttura, il divenire e soprattutto la degradazione della nostra società e della nostra cultura. Come sempre, questa archeologia è anche una teleologia e una escatologia; sogno di una presenza piena e immediata che chiude la storia, trasparenza e indivisione di una parousia, soppressione della contraddizione e della differenza.
V
I miei maestri, dice Lévi-Strauss, sono stati Marx e Freud (e Rousseau, ovviamente – il fondatore dell’etnologia).
Accordare Marx e Freud con Rousseau è difficile – dice Derrida. Difficile è far digerire a Marx e Freud l’idea di una innocenza primitiva, di una incantevole soddisfazione animale, di una gentilezza immensa degli indigeni, di una commovente e più vera tenerezza umana, di quel grado zero della civiltà che Lévi-Strauss deve supporre per poter far partire la scena della Lezione di scrittura, che è la scena dell’etnocentrismo e dello dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Questo grado zero della civiltà regge tutto il discorso di Lévi-Strauss. Solo una comunità innocente, dice Derrida, solo una comunità di dimensioni ridotte (tema rousseauiano), solo una micro-società di non violenza e di immunità in cui tutti i membri possono facilmente tenersi a portata d’allocuzione immediata e trasparente, cristallina, pienamente presente a sé nella sua parola viva, solo una simile comunità può subire, come la sorpresa di un’aggressione che viene dal di fuori, l’insinuazione della scrittura, l’infiltrazione della sua astuzia e della sua perfidia. Solo una simile comunità può importare dallo straniero lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo.
Non si tratta più di chiedere se sia possibile conciliare Rousseau e Marx – dice Derrida. Si tratta adesso di chiedersi se è sufficiente parlare di sovrastruttura e denunciare uno sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo per conferire a quest’ipotesi una pertinenza marxista. Si tratta di capire se, con questa operazione, non si stia voltando il rigore originale della critica marxista verso una critica più generica della miseria, della violenza, dello sfruttamento, ecc., e per esempio, dice ancora Derida, del buddismo.
Oltre questa precauzione, dice Derrida, bisogna assumerne un’altra. Bisogna verificare come, all’interno di questo discorso di Lévi-Strauss, agisce un etnocentrismo anti-tecnologico. Un etnocentrismo profondo che privilegia il momento della scrittura fonetica, il momento di una presunta innocenza e immediatezza, momento che verrebbe interrotto da una effrazione esterna, e da una mediazione operata dalla grafia. Un etnocentrismo che si pensa al contrario come anti-etnocentrismo nella coscienza del progressismo liberatore. Separando radicalmente la lingua dalla scrittura, mettendo quest’ultima in basso e di fuori, credendo almeno di poterlo fare, dandosi l’illusione di liberare la linguistica da ogni passaggio attraverso la testimonianza scritta, si pensa effettivamente di restituire lo statuto di lingua autentica, di linguaggio umano e pienamente significante, a tutte le lingue praticate dai popoli che si continua tuttavia a chiamare «popoli senza scrittura». Continuando a definire (con gesto etnocentrico) questi popoli nel loro rapporto alla scrittura.
Si ammette la differenza rigorosa tra linguaggio e scrittura – differenza che deve essere dimostrata; si ammette l’esteriorità rigorosa dell’uno rispetto all’altra, il che permette di mantenere la distinzione tra popoli che dispongono della scrittura e popoli senza scrittura. Se la differenza tra linguaggio e scrittura non regge, come non regge, allora tutto il discorso si sbriciola, tutte le differenze devono essere revocate. E invece, dice Derrida, Lévi-Strauss non sospetta mai del valore di una simile distinzione. Il che gli permette soprattutto di considerare il passaggio dalla parola alla scrittura come un salto, come il superamento istantaneo di una linea di discontinuità: passaggio da un linguaggio pienamente orale, purificato da ogni scrittura – cioè puro, innocente – ad un linguaggio che si aggiunge la propria «rappresentazione» grafica come in significante accessorio di nuovo tipo, che apre una tecnica d’oppressione. Lévi-Strauss, dice Derrida, aveva bisogno di questo concetto «epigenetista» della scrittura perché il tema del male e dello sfruttamento che sopraggiunge con la grafia fosse proprio il tema di una sorpresa e di un accidente che rende affetta dal di fuori la purezza di un linguaggio innocente. Rendendolo affetto come per caso.
A questo punto, conclude Derrida, l’etnocentrismo tradizionale che, ispirandosi al modello della scrittura fonetica, separa con l’accetta la scrittura dalla parola, è dunque trattato e pensato come anti-etnocentrismo. Esso sostiene un’accusa etico-politica: la sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo è il fatto delle culture scriventi di tipo occidentale. Da questa accusa sono salvate le comunità della parola innocente e non oppressa.
Derrida accusa Lévi-Strauss di etnocentrismo, un etnocentrismo di seconda grado, che si innesta su un etnocentrismo di primo grado. Al primo grado c’è la partizione tra primitivi e civilizzati, dove i primitivi rappresenterebbero uno stadio meno evoluto dei civilizzati. Lévi-Strauss contesta e demolisce questo etnocentrismo. Non c’è modo di sostenere la differenza gerarchica tra primitivi e civilizzati. Si tratta di sistemi razionali che sono sullo stesso piano. Non si può certo negare la razionalità ai sistemi primitivi. Essi sono dotati della stessa razionalità delle società civilizzata, e la usano con cognizione di causa, allo stesso modo delle società civilizzate. Dunque, non c’è alcuna differenza di grado, ci sono differenze tra una struttura e un’altra, ma queste differenze non sono gerarchizzabili. Non c’è alcun criterio che permetta una gerarchizzazione. Spostandosi su un altro piano, quello della tecnica, Lévi-Strauss individua un criterio che permette, se non di gerarchizzare le società, perlomeno di differenziarle in modo radicale. La tecnica è il male, in quanto violerebbe una prossimità e una intimità alle quali è estranea ogni tipo di violenza. Siccome le società primitive non conoscono la tecnica, dunque esse sono prive di violenza, sono innocenti. Mentre le società civilizzate conoscono la tecnica e dunque sperimentano la sua violenza. Nel momento in cui i civilizzati portano la tecnica presso le società primitive, queste perdono la loro innocenza , la loro intimità violata, la loro prossimità violentata e definitivamente persa. Da qui la tristezza e la malinconia dell’etnologo, il quale piange la perdita dell’innocenza e di un amore selvaggio col prossimo che corrispondono alla cacciata dal paradiso.
Derrida non nega la violenza della tecnica, anzi, estende la scrittura, e dunque anche la violenza, alla parola. Se è vero, come effettivamente credo, chiede Derrida (180), che la scrittura non si pensa fuori della violenza intersoggettiva, esiste qualcosa, foss’anche la scienza, che vi sfugga radicalmente? Esiste una conoscenza e soprattutto un linguaggio, scientifico o meno, che si possa dire estraneo sia alla scrittura che alla violenza? Se si risponde negativamente, come faccio io, dice Derrida, l’uso di questo concetto di violenza per discernere il carattere specifico della scrittura non è pertinente. Oppure, dice Derrida, se si deve legare la violenza alla scrittura, la scrittura appare molto prima della scrittura in senso stretto: già nella différance o archi-scrittura che apre la parola stessa. Tutta questa struttura di differenziazione appare dal momento in cui è possibile differire la presenza, cioè la spesa o la consumazione, e organizzare la produzione, cioè la riserva in generale. Ciò si produce molto prima dell’apparizione della scrittura in senso stretto, ma è vero, e non lo si può trascurare, che l’apparizione di certi sistemi di scrittura, tre o quattromila anni fa, è un salto straordinario nella storia della vita.
A questo primo svarione di Lévi-Strauss ne segue un altro, che consiste nell’iscrivere la scena della scrittura e della conseguente gerarchizzazione in un quadro marxista di sfruttamento.
È noto che, dice Derrida, il potere della scrittura nelle mani di un piccolo numero, di una casta o di una classe, è sempre stato contemporaneo alla gerarchizzazione, alla differenza politica, la quale è, a un tempo, distinzione di gruppi, di classi e di livello di potere economico-tecnico-politico, e delega dell’autorità, potenza differita, abbandonata ad un organo di capitalizzazione.
Lévi-Strauss, dice Derrida, non fa alcuna differenza tra gerarchizzazione e dominio, tra autorità politica e sfruttamento. La nota che domina queste riflessomi è quella di un anarchismo che confonde deliberatamente la legge e l’oppressione. L’idea di legge e di diritto positivo, che sono difficili da pensare nella loro formalità, nella generalità che nessuno ha il permesso di ignorare, prima della possibilità della scrittura, è determinata da Lévi-Strauss come costituzione e asservimento. Il potere politico non può essere che detentore di una potenza ingiusta. Tesi classica e coerente, ma qui avanzata come ovvia, senza che venga avviato il minimo dialogo critico coi sostenitori dell’altra tesi, secondo la quale la generalità della legge è al contrario la condizione della libertà nella città.
Lévi-Strauss ha in testa l’immagine di una comunità immediatamente presente a se stessa, senza différance, comunità della parola nella quale tutti i membri sono a portata d’allocuzione. Perciò la missione dell’etnologo implica un significato etico: individuare sul terreno i «livelli di autenticità». Il criterio dell’autenticità è la relazione di «vicinato» nelle piccole comunità dove «tutti conoscono tutti». Il modello di questa piccola comunità a struttura cristallina, interamente presente a sé, riunita nel proprio vicinato, è certamente rousseauiano. Rousseau mostra che la distanza sociale, la dispersione del vicinato è la condizione dell’oppressione, dell’arbitrio, del vizio. I governi dell’oppressione fanno tutti il medesimo gesto: rompere la presenza, la compresenza dei cittadini, l’unanimità del «popolo radunato», creare una situazione di dispersione, tenere i soggetti separati, incapaci di sentirsi insieme nello spazio di una sola e medesima parola, di un solo e medesimo scambio persuasivo. Presenza a sé, prossimità trasparente nel faccia a faccia dei volti e nell’immediatezza portata dalla voce, questa determinazione dell’autenticità sociale è dunque classica – dice Derrida; rousseauiana, ma già erede del platonismo, essa comunica con la pretesa anarchica e libertaria contro la Legge, i Poteri e lo Stato in generale, ed anche col sogno dei socialismi utopistici del XIX secolo, in modo molto preciso con quello del fourierismo. Nel suo atelier, nel suo laboratorio da bricoleur, l’etnologo, dice Derrida, dispone anche di questo sogno, come di un pezzo o di uno strumento tra gli altri. Stava lì, perché sarebbe potuto servire, magari miscelato con un po’ di Marx e un po’ di Freud e addizionato con buddismo, senza disdegnare una goccia di marxismo volgare e di materialismo dialettico. La sola debolezza di tutto sto intruglio, come ricetta del bricoleur, dice Derrida, è di non potersi giustificare da parte a parte nel proprio discorso. E se è pur vero che l’idea di un architetto che rompe con ogni bricolage deriva dalla teologia creazionista, è anche vero che solo una simile teologia può accreditare una differenza essenziale e rigorosa tra l’architetto e il bricoleur. Ma il fatto che l’architetto sia sempre una specie del bricoleur, non deve distruggere ogni critica del bricolage, anzi. Critica in che senso? Anzitutto, se la differenza tra bricoleur e architetto è al suo fondo teologica, il concetto stesso di bricolage implica uno scadimento e una finitezza accidentali.