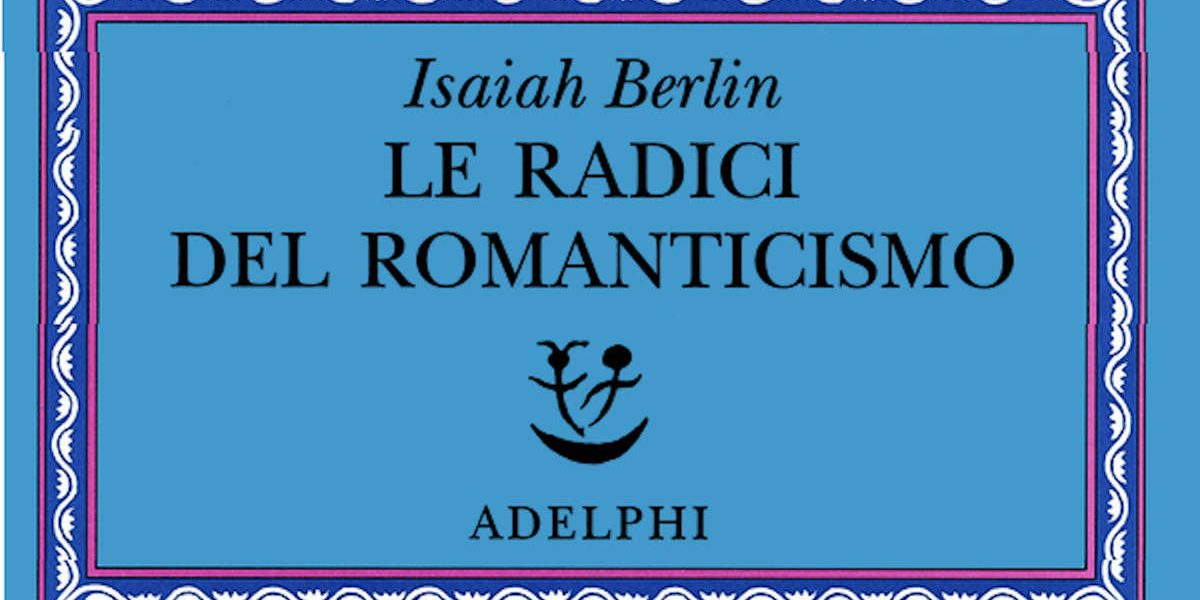Nel 1756 Johann Georg Hamann, concittadino e amico di Kant, si reca a Londra per una missione segreta. La ditta Berens (Isaiah Berlin, Il mago del Nord) gli affida una missione la cui esatta natura è a tutt’oggi un mistero. Il compito di Hamann sarebbe stato quello di proporre agli inglesi un eventuale distacco dell’area baltica «tedesca» dall’Impero russo e la nascita di uno Stato autonomo o semiautonomo. La missione si conclude con un nulla di fatto.
A Londra Hamann abita in casa di un insegnante di musica, inizia a suonare il liuto e si vota a una vita di terribile dissipazione. Dopo solo 10 mesi accumula debiti per 300 sterline, versa in uno stato di prostrazione, miseria e solitudine. Poi lascia la casa del musicista e si trasferisce in una modesta pensione, dove, da buon pietista, il 13 marzo 1758 inizia a rileggere le Bibbia. Annota i suoi progressi spirituali giorno per giorno.
Tornato in Germania rifiuta l’invito di Kant di scrivere un manuale di fisica a quattro mani, e nel 1767 accetta un posto di funzionario all’Amministrazione generale delle imposte e dei dazi.
Nel Settecento, la Prussia di Federico il Grande, è, tra tutte le provincie tedesche, la più progressista. La burocrazia di Berlino deve raggiungere il livello di quella francese. Esperti stranieri, soprattutto francesi, vengono invitati alla corte di Potsdam e messi al lavoro. La lingua della corte è il francese.
Ai francesi (Voltaire, Maupertuis e La Mettrie, solo per citare i più famosi), dice Berlin, vengono assegnati gli incarichi intellettuali di maggior prestigio. Sono messi a capo degli uffici amministrativi dello Stato, con grave onta di tutti i veri prussiani (specie nella zona orientale del paese, roccaforte del tradizionalismo), che brontolano, ma obbediscono.
È questo il mondo in cui il giovane Hamann è invitato a recitare la sua parte, e nel quale si incardina senza troppo resistere.
Ma un viaggio a Londra, soprattutto la conoscenza di Hume, cambiano ogni cosa. Dopo Londra, Hamann diviene il più estremo e implacabile nemico dell’Illuminismo e, in particolare, di tutte le forme di razionalismo del suo tempo. Diviene il capostipite di tutta la schiatta degli irrazionalisti europei, stendendo la sua ombra da Herder a Nietzsche e oltre.
I nemici principali di Hamann, dice Berlin, diventano Kant e Helvétius. Accusa Kant di un «antico e freddo pregiudizio a favore della matematica» di un «odio gnostico per la materia» e di un «amore mistico per la forma». Invece, Helvétius, molto letto in Germania, è il predicatore di un piatto eudemonismo (Glückseligkeitslehre) che è una sciagura per la Germania.
Gli illuministi sono affetti da una totale incapacità di vedere la vita interiore dell’uomo e i suoi abissi, di cui scrissero Agostino e Pascal, Dante e Lutero. Lato oscuro dell’animo umano che Helvétius e i suoi amici liquidano a buon mercato come un’aberrazione irragionevole da lasciare alle cure di un medico competente o di un «ingegnere delle anime».
Nel 1773, dice Berlin, appare un volume intitolato Betrachtung über Religion di C.T. Damm, un vecchio teologo wolffiano, assai rispettato dal pubblico colto di Berlino. Damm denuncia l’uso della lettera «h» in molte parole tedesche dove gli sembra superflua: per esempio tra due sillabe o dopo una consonante.
Hamann, dice Berlin, pubblica una replica intitolata «Nuova apologia della lettera h». Si tratta di una testo sorprendente, dove viene presentata una tesi grammatologica ante litteram e una proposta semiologica che avrebbe tanto giovato alle scienze positive, per esempio all’economia, solo se fosse stata oggetto dell’attenzione che merita.
La lettera «h», dice Berlin, l’iniziale del suo nome di battesimo, è molto cara a Hamann. Ma secondo Damm la «h» è muta e oziosa e, quel che forse è peggio, può insegnare ai bambini la fede cieca, privandoli del senso critico. La lingua dovrebbe essere razionalizzata; dovrebbe essere resa savia, pratica e libera da ogni elemento arbitrario.
Per Hamann, dice Berlin, tutto ciò è impossibile. Una lingua perfettamente logica è una chimera. Non è possibile eliminare dalla vita tutti gli elementi «arbitrari» e non-logici, perché ciò la appiattirebbe e la prosciugherebbe. La lettera «h», dice Berlin, questa lettera parassita, inutile, fastidiosa, incarna per Hamann l’elemento imprevedibile della realtà, il tocco di fantasia nel governo divino del mondo.
Siamo in presenza di uno slancio protoromantico nel quale non bisogna affrettarsi a leggere un elogio dell’oscuro, dell’osceno, del torbido, del folle, eccetera. Si tratta, invece, di vederci una proposta seriamente argomentata sulla impossibilità di una traduzione trasparente – sulla possibilità stessa della traduzione. Un tema che è al centro della grammatologia.
Il libello di Hamann, dice Berlin, avvia una diatriba contro un universo sterilizzato e senza vita e in un elogio dell’irregolarità e della bellezza dell’irrazionale. La ragione è una cosa «miserabile, cieca e nuda». «La vostra vita» dice la lettera «h» rivolgendosi a Damm e ai suoi compari «è quel che sono anch’io, un respiro [ein Hauch]».
Il libello, continua Berlin, è il primo ordigno scagliato contro la macchina bellica dei Lumi. Le idee vissute fino ad allora soltanto in piccole comunità religiose appartate e isolate dal mondo divengono armi temibili da usare nella pubblica arena. È il primo grande colpo sferrato dall’individualismo romantico contro il razionalismo e il totalitarismo.
Questa originale polemica passa in secondo piano rispetto alla Teoria del linguaggio di Hamann. La sua tesi, dice Berlin, è la seguente: credere che esista un processo chiamato pensiero o ragionamento, insediato come una facoltà autonoma in qualche parte del cervello o della mente, e credere che l’uomo possa articolare questa facoltà a suo piacere per mezzo di simboli inventati allo scopo (o ricevuti già pronti), o viceversa mediante idee non verbalizzate e non simboliche e dunque in forma non empirica, senza immagini, suoni, dati visivi, è un’illusione priva di senso, ed è tuttavia proprio ciò che gli uomini hanno a lungo creduto e forse continuano in gran parte a credere.
Non siamo lontani dalla grammatologia.
Hamann, dice Berlin, è uno dei primi pensatori ad affermare con chiarezza che il pensiero è l’uso di simboli, che un pensiero non simbolico, cioè un pensiero senza simboli né immagini – visive o uditive, o magari miste, o ancora provenienti da altri organi di senso, cinestetiche o olfattive (sebbene ciò sia meno probabile nell’uomo come lo conosciamo) –, è un concetto incomprensibile
[Nella nota 7 Berlin racconta un aneddoto interessante su Keynes che riporto qui integralmente: l’economista Keynes, alla domanda se pensasse per parole o per immagini, ha risposto: «Penso in pensieri». La battuta è divertente, ma, dal punto di vista di Hamann, priva di senso.]
Per Hamann, dice Berlin, pensare, in tutte le numerose accezioni del termine, significa impiegare immagini, segni grafici, suoni, allo scopo di denotare oggetti: cose, persone, eventi, fatti. Quali simboli vengano usati per denotare gli oggetti è un’altra questione: alcuni potranno derivare da radici inconsce e da cause biologiche e fisiologiche, altri da un’invenzione artificiale, come le parole di nuovo conio, la terminologia tecnica e così via. Ma in ogni caso il pensiero (o il linguaggio) è l’uso di simboli. Vico aveva detto qualcosa di molto simile, ma Hamann, dice Berlin, non lo aveva letto.
La tesi cartesiana, dice, secondo cui ci sarebbero delle idee chiare e distinte, contemplabili da una specie di occhio interiore – tesi comune a tutti i razionalisti –, idee allo stato puro, indipendenti dalle parole e traducibili a piacere in una qualsiasi di esse: questa è la principale menzogna che occorre eliminare.
Le cose stanno diversamente. Il linguaggio è ciò con cui pensiamo, non ciò in cui traduciamo i pensieri.
Il significato, dice, coincide con le parole, e tutte le traduzioni sono infedeli. Alcune frasi potranno assomigliarsi o avere significati simili, ma una frase non potrà mai essere sostituita con un’altra, poiché il legame tra le parole e il senso è organico, indissolubile, unico.
Le parole sono i veicoli viventi del senso.
Questo, dice, è il motivo per cui Kant, il quale crede di parlare delle categorie e dei concetti della ragione, sta parlando in realtà delle forme del linguaggio: una sostanza fluida, mercuriale, che muta non solo da una cultura all’altra, ma anche da un individuo all’altro, col mutare degli atteggiamenti, delle professioni, degli umori. L’idea di poter catalogare, una volta per tutte, le leggi eterne e immutabili di qualcosa che chiamiamo pensiero, che sarebbero traducibili a piacere in qualsiasi linguaggio o simbolismo – come un nucleo granitico di cui il linguaggio sarebbe il mero rivestimento esterno, quasi una guaina artificiale –, è il più fatale di tutti gli equivoci.
Non esistono pensiero o conoscenza che non siano simbolici – dice Berlin. Tutti i pensatori che hanno considerato il linguaggio concreto come una sorgente di errori smascherabili con mezzi non verbali, e che hanno creduto possibile l’invenzione di un nuovo linguaggio più adeguato a trasmettere la verità – tutti coloro, in altre parole, che non hanno usato il linguaggio come strumento di autocritica, ma hanno tentato, in un certo senso, di aggirarlo (come ad esempio Leibniz, o certi filosofi moderni come Russell, malgrado la sua sensibilità per la parola) –, sono impegnati per Hamann in un’impresa senza senso, che ignora la sostanza del problema.
Se ci fosse una struttura metafisica oggettiva, direttamente percepibile, o ci fosse la garanzia che le nostre idee o il nostro linguaggio corrispondano, in qualche misteriosa maniera, a tale struttura oggettiva, si potrebbe supporre che la filosofia, o grazie a una intuizione metafisica diretta o attraverso la mediazione delle idee e del linguaggio e, tramite questi, ai fatti (che sono coincidenti), fornisca un metodo per conoscere e giudicare la realtà. Ma per Hamann, dice Berlin, questa è una concezione completamente errata, sebbene consacrata dal tempo, ed è anzi proprio quella su cui poggia l’intero razionalismo europeo. L’idea di una corrispondenza, per cui ci sarebbero, da un lato, un mondo oggettivo, e dall’altro l’uomo e i suoi strumenti – il linguaggio, le idee e così via – tesi verso questa realtà oggettiva, è una falsa immagine. C’è solo un flusso di sensazioni, interne ed esterne, i colori, i gusti, le immagini, i suoni, i profumi, l’amore e l’odio, la pena, la pietà, lo sdegno, il timore, l’adorazione, la speranza, il rimorso, la rabbia, il conflitto; e soprattutto la fede, la speranza e l’amore verso gli altri esseri umani o il Creatore e Padre del mondo e degli uomini, a Dio Onnipotente.
La lingua, per Hamann, è un idioletto, comprensibile solo a chi la produce e la usa. Manca un soffio [ein Hauch], anzi, manca un Hack, per una piena grammatologia. Quall’Hack che Freud cerca disperatamente nell’Interpretazione, ma senza riuscirci.
Sia come sia, bisogna mettere in chiaro un primo punto. Non ci sono pensieri che, in un secondo momento, vengono espressi con un linguaggio. Non c’è un’intimità distinta o distinguibile dal linguaggio. Il pensiero è simbolico. Il pensiero (il significato) e il segno (il significante) sono attaccati l’uno all’altro in modo inestricabile, tanto che un segno diverso, per esempio quello di un’altra lingua, o lo stesso segno, ma usato da una persone differente, si lascerebbero dietro un resto, o, comunque, non restituirebbero lo stesso voler-dire. [L’economia non ha mai provato seriamente a misurarsi con questo primo assunto grammatologico]. Il linguaggio non è [non è] un mezzo per esprimere idee preconcette. Le idee non precedono il mezzo. Tutta la polemica contro la strumentalità, polemica spesso condotta in nome del romanticismo, deve essere messa da parte.
In secondo luogo, bisogna riconoscere che, una volta ammessa l’impossibilità di una traduzione trasparente, una sorta di trasformazione da un idioma all’altro, da un idioletto all’altro, è sempre all’opera, e che quest’opera è tanto necessaria, quanto incontrollabile.