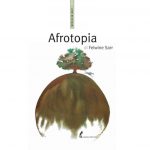I
Eduardo Rózsa-Flores è la Controfigura. Mentre la figura, una delle tante, è Alberto.
Alberto non vive una vita eroica, fa l’insegnante. È iscritto a un sindacato, cerca di non rimanere solo, cerca di risolvere i conflitti minuti presenti nelle relazioni affettive. Niente a che vedere con gli scontri armati e le guerre vere e proprie. Ma si tratta pur sempre di conflitti, di spinte violente che impongono cambiamenti alla società.
Alberto non è più uno di quelli che all’università indicevano le assemblee, che scrivevano i volantini e attaccavano i tatzebao. Non è un Protagonista. Spesso gli capita di accodarsi e cantare la messa, ma non è una controfigura. Vorrebbe impegnarsi di più, vorrebbe studiare di più, vorrebbe imparare le lingue, toccare con mano i documenti, parlare faccia a faccia con i protagonisti, ma deve rimandare a quando andrà in pensione (di vecchiaia). Adesso ci sono le bollette, ci sono i figli, c’è la famiglia e un lavoro precario, ci sono le mail e le scansioni, i videoclip, i repositiry, eccetera.
La Contro figura, invece, non lavora, non ha mai dovuto lavorare per vivere, non ha mai fatto una fila alla posta, non ha vegliato un bambino con la febbre, non ha mai scalato i punti Fragola, forse non ha mai nemmeno preso una multa. Parla 4 o più lingue, è uno scrittore, un regista e un attore, è un giornalista a tempo perso, è anche una spia e un criminale di guerra. È tutto quello che un piccolo borghese si aspetta di diventare, quando l’investimento nel suo gran tour sponsorizzato darà i suoi frutti e gli consentirà di accede a quelle professioni che hanno a che fare con i diritti umani, la critica teatrale, la rubrica letteraria, la beneficenza, le ONG, l’attivismo politico, la Bellezza o la Verità, i libri (ma quelli di carta), l’arte o il giornalismo d’inchiesta, il brivido.
Alberto, invece, per molti anni fuori corso all’Università di Bologna, dopo la laurea è entrato nell’antipurgatorio dei concorsi, delle borse di studio, dei lavori precari. Ha venduto due o tre enciclopedie porta a porta, ha provato a lavorare una notte da facchino, ha dato qualche lezione privata, ha scritto tesine a pagamento, ha fatto il baby-sitter per amici dei genitori, il commesso di cartolibreria, il ciapa purb per due-tre mesi. Nella casa ereditata dal nonno ha smembrato la testi di laurea, ne ha ricavato qualche saggio per riveste letterarie. Ma non ha ingranato per davvero.
Per scrivere bisogna avere tempo libero. Per scrivere la storia di Eduardo – ma è poi una storia? – bisogna conoscere le lingue. Non è sufficiente l’interesse per la verità, bisogna saperla tradurre, la verità. E non è facile. Perché i documenti sono monumenti. Perché il passato non passa mai per davvero. E tutto ricomincia sempre di nuovo, la memoria si riordina a partire dall’avvenire, e nemmeno i morti sono al sicuro, eccetera. Tutte cose che si conoscono, e che Alberto ha ascoltato fino alla noia nei corridoi dell’Università di Bologna.
Sia come sia, per la pazienza filologica e per lo scetticismo ci sarà tempo. Ora, dice Alberto, posso solo sedere a questa sedia, in questo studiolo ricavato nel soggiorno, approfittare del sonno dei bambini per cercare i documenti in internet, e importunare più di un amico per farmeli tradurre, e, alle strette, servirmi di google translate. Non importa rischiare di tradurre in modo errato un sottotitolo. Una traduzione approssimativa va bene, finché non finisce sulla carta stampata, più difficile da alterare.
La carta avrebbe una virtù testamentaria negata al transistor.
II
Non muovo il culo dalla sedia – dice Alberto. Batto sulla tastiera John Sweeney e Paulo Badin, e trovo un documento fornito da Slobodan Praljak. È un documento che si direbbe autentico: la copia digitale di un testo battuto a macchina, con minuscole cancellature e correzioni. Un documento scritto per informare o per dissimulare; un’informativa scritta nell’autunno 1992 da un funzionario del Ministero dell’interno della neonata Repubblica di Croazia.
Nel documento che fornisce il generale Praljak, dice Alberto, si legge la seguente lista.
La lista trascritta da Alberto è riportata nel libro di Lollini con un font diverso da quello del corpo del libro, tale da indurre il lettore a credere, ma è una finzione, si capisce, che il testo riprodotto – fotocopiato? – sia esattamente uguale a quello del cosiddetto originale. Qui non è il caso di aprire una parentesi su realtà e finzione, su dove inizi il biografico, eccetera, e nemmeno dove inizi o dove finisca, e se finisca, il testo, eccetera, perché anche queste sono questioni che Alberto ha ascoltato sino alla nausea nei corridoi di Lettere e Filosofia quando Giorgio Citazionista sciorinava i patronimici dei membri della Yale school.
Nel documento cosiddetto originale la lettera elle del nome «Paolo» è difforme, stampata male. Cambio il formato digitale, dice Alberto, e riesco a ingrandire l’immagine. Il carattere è sbavato, in parte sovrapposto alla lettera seguente. Sembra aggiunto a penna. Nel cognome, invece, la elle di «Baldin» è stata scritta senza esitare.
Mi sono fatta un’idea della difformità, dice la moglie Luisa. Credo di avere una spiegazione di tipo tecnico-meccanico. Secondo me, l’estensore della lettera all’inizio ha scritto «Paoo». Lo si capisce perché le due «oo» sono molto vicine. Poi ha armeggiato con la macchina da scrivere e ha piazzato la elle troppo a sinistra. Ma così il nome sembra «Pado» e non «Paolo». Corregge l’errore con il cancellino. L’operazione riesce solo in parte perché rimane l’ombra della elle cancellata. Infine ribatte la lettera un po’ a destra e ottiene il testo corretto, più intelligibile del precedente.
Forse ho trovato il vero nome del colpevole – dice Alberto. Se, seguendo questo uomo di carta, trovassimo l’uomo di carne, potremmo fargli un paio di domande. Potrebbe ricordare, piangere, sgravare la coscienza; potrebbe dirci la verità, una piccola verità tardiva nella grande menzogna della guerra.
Se la carta mente, e forse più del cip, meglio ascoltare la voce diretta del protagonista.
Non c’è bisogno di tirare in ballo il lapsus, il trauma, il rimosso, eccetera, oppure ricordare che la lingua funziona come un inconscio, ma un inconscio che non è predicato di un soggetto, che non è uno strumento o un mezzo, e non si lascia trascinare nella rissa servo-padrone, eccetera. Tutte questioni e temi che Alberto ha ascoltato dalla voce dei professori e riletto sui libri di testo e nei manuali quando era studente all’Università, quando nelle biblioteche si trovava ancora qualche copia della Struttura assente di Eco e di Contra dogmaticos di Luciano Nanni. Non c’è bisogna di dire che anche la memoria viva mente, e più del cip e della carta, e che, dunque, bisogna intendere bene le parole, e, all’occorrenza, tradurle o correggerle, costringerle.
Paulo Badin, alias Paolo Baldin, è il sicario pentito di cui scrive John Sweeney nell’inchiesta Chi ha ucciso Paul Jenks? (Observer, Ottobre 1992).
Alberto invia una mail a Sweeney per informarlo della scoperta.
Credi sia importante che il nome non corrisponda? – gli chiede. Com’era il suo aspetto? Sapresti riconoscerlo?
Ho incontrato PB nel 1994, 22 anni fa – risponde Sweeney. Immagino di poterlo riconoscere. Era tosto, asciutto, di taglia media, biondo, stempiato nel 92.
Il suo Paulo Badin, dice Alberto, era tosto, asciutto, taglia media, biondo, stempiato. Scrive di averlo incontrato nel 1994. Senz’altro si confonde, perché poi scrive «92». Gli chiedo con un messaggio breve, se è un lapsus. Nel 1994, a primavera, ha intervistato Eduardo. Chi tace acconsente.
Dove non ci sono nemmeno monumenti, bisogna far parlare il silenzio. Ma il silenzio non è il grado zero dell’archivio, come Foucault ha creduto e sperato che fosse, eccetera.
Comunque sia, la carta sembra più difficile da falsificare.
III
La memoria viva, per esempio quella di Francis, è selettiva. Nonostante conosca bene la storia d’Italia, quando passa dalla stazione di Bologna, qualche Dio gli impone una cecità parziale. Ricorda che una volta è sceso dal treno. Ma non ricorda di aver visto la lapide e lo squarcio simbolico in sala d’aspetto, o l’orologio fermo che ricorda la strage. E va bene così – dice Alberto. Mica tutti quelli che passano dalla stazione, o anche dalla sala d’aspetto, vedendo, capiscono. Non vede il muro dove hanno fucilato i partigiani, dove ci sono ancora le loro foto che ci guardano. Non vede che lì accanto c’è la lapide per la strage del 2 agosto. E va bene anche questo. Ottantacinque morti, ma lui non ne parla. Lo so, lo so, dice Alberto, si può replicare che l’autore non è obbligato a riprodurre nel romanzo ogni particolare della nostra realtà. Decide di non parlare di certi attentati. Però il narratore dovrebbe conoscerli. È il suo lavoro. Francis si occupa di Islam politico-radicale, è una spia. Va bene, ha dormito male, non può ricordarsi tutto, ma passa dalla stazione di Bologna. Dio bono!
Forse la strage del 2 agosto per lui è roba vecchia. Era troppo giovane nel 1980. Ma come impiegato della difesa francese si occupa di attentati. E la bomba a Bologna non era una questione di politica interna. È piuttosto irritante questo agente segreto francese che non sa nulla di Bologna, la città da cui è decollato l’aereo che è stato abbattuto a Ustica, da un caccia della Nato, forse da un caccia francese.
Il racconto di Francis non è verosimile. A un racconto non si chiede di essere vero. Ma perlomeno di essere credibile. Si possono raccontare anche balle, inventare l’inverosimile, ma questo inverosimile, dice Alberto, deve essere verosimile.
Ma quello di Francis è un racconto (un recit)?
Anche qui, dopo decenni di decostruzione, è difficile raccapezzarsi. E, di diritto, la distinzione tra vero e verosimile, tra autore e attore, tra firma, evento, testo e contesto, o tra significante e referente, eccetera, non ha alcun punto di ancoraggio assoluto, eccetera. E tutto ciò Alberto lo sa bene, per averlo sentito dire nella sala studio al numero 36 di via Zamboni.
Poi c’è la memoria viva, con le sue lacune, le interferenze, la selettività e tutto il resto.
Un giorno Alberto esce da una pizzeria d’asporto dimenticando di passare alla cassa.
Non so perché l’ho fatto – dice. Forse già pregustavo il cibo, forse rimuginavo qualcos’altro. Per la prima volta me ne sono andato senza pagare. Un atto mancato, per me piuttosto insolito, che alla pizza seguente mi è stato rammentato con cortesia, in forma di dubbio, da un cameriere albanese padrone del lessico, della grammatica e finanche dei registri della lingua italiana.
Il passato dura a lungo. E anche una parola insignificante, buttata a inizio frase quasi a casaccio e dimenticata, viene arruolata dalle parole successive in un processo di significazione a cui non era destinata. Ma anche tutto ciò, lo scarto tra significazione e valore di cui Saussure parla nel Corso, eccetera, Alberto lo avrà ascoltato più volte, ma senza troppa convinzione, quando a parlarne era Paolo Fabbri.
Chiedo scusa – dice Alberto. Rimarrà la macchia di un atto mancato.
Tutto si riordina a partire dal futuro. Certo. Non ci sono foto o lapidi o pietre, carte, cip, neuroni, partigiani che non possano essere tradotti, macchiati, sbianchettati, cancellati definitivamente. La traduzione non avviene solo da una lingua all’altra, ma anche nella stessa lingua. Non esiste memoria assoluta – per fortuna.
Nonostante una traduzione interminabile, e la cancellazione, è noto che il passato vanta una debole forza sull’avvenire. Come è noto che agli ebrei era vietato investigare il futuro, eccetera; che questo divieto li liberava dal fascino della previsione a cui si sottomettono quelli che cercano compulsivamente di tradurre monumenti in documenti, credendo con ciò di arrestare il giorno, quando in verità lavorano per arrestare l’avvenire.
Non per questo, il futuro diventerà necessariamente un tempo omogeneo e vuoto. Poiché ogni secondo, in esso, è la piccola porta da cui può entrare lo straniero, anche se questo straniero, parlando la stessa lingua, senza accento – ma è mai possibile? -, non sarà riconosciuto come straniero. E non c’è bisogno di ricordare Blanchot, il Rabbino e il Messia alle porte di Roma, o le amicizie disastrose, eccetera, perché per anni Giorgio Citatutto ce l’ha menata con questo aneddoto.
Chiedo perdono – dice Alberto. Non ho fatto nulla per evitare la tua morte. Eppure sapevo. Dentro di me, seppellite sotto strati di memorie, c’erano le informazioni per evitare quello che poi è avvenuto – l’impensabile. Era sufficiente scomporre e ricomporre i Ricordi. Anagrammatica mnestica, in cui l’inconscio è potenza e la realtà una delle sue tante attualizzazioni. Ma non siamo nella cabala, o nello studio della professoressa X in via Zamboni 34, eccetera. Siamo alle prese con una macchia che non si cancella, o, se si fa cancellare, lascia uno spazio bianco, traccia di una traccia, che parla in modo ancora più ossessivo.
V
Anche per lavorare all’università con contratti stagionali ci vuole un minuscolo appartamento comprato e ristrutturare attingendo alla riserva di accumulazione originaria. E non c’è bisogno di rivendicare alcuna ascendenza, perché qui non ci sono guerre di razza e stronzate varie, somministrate dieci pagine alla volte in dispense fotocopiate dal Prof Marchetti in seminari semi-clandestini – clandestini per modo di dire – durante i grandi baccanali al tempo in cui i liceali, promossi universitari, combattevano in difesa di un’istituzione che sapevano li avrebbe cooptati; e non c’è bisogno di dire che l’accumulazione originaria si origina ogni giorno, impastando lavoro morto con lavoro vivo, e che l’idea stessa di origine è scossa dal materialismo storico; non c’è bisogno di aggiungere altro, in quanto Alberto, originario di Cosenza, avrà avuto il tempo, quando era in visita ai parenti a Spezzano Albanese e a Santa Sofia d’Epiro, di seguire il prof. Mazzetti ad Arcavacata.
Non sei in Inghilterra a studiare la lingua, ospite di una famiglia. Qui – ma qui dove? – la tua terra e il tuo sangue sono lontani. Studi per diventare un altro. Hai deciso che dopo la laurea vivrai dove si parla una lingua straniera, dove nessuno ti conosce, dove il tuo accento non potrà tradirti, dove le storie hanno un termine breve, e finiscono prima di una resa dei conti. Dove non c’è memoria. Dove puoi essere uguale a tutti gli altri: essere nessuno.
Beato illuminismo!
Finché bazzicavi Castiglione Cosentino, Luzzi, Rose, San Marco Argentano, Montalto Uffugo, parlare la lingua madre ti appariva, per cosi dire, naturale. Ma quando salivi a Vaccarizzo o ad Acri, la lingua madre non ti aiutava più, e la lingua del padre ti suonava incomprensibile, come quella di Pasquale, Antonio, Carmelo e Vincenzo, i compagni delle elementari. Dove a parlare erano prima di tutto le mani.
Una volta Antonio ti ha strappato la merenda di mano e con un morso ne ha ingoiata metà. Non hai reagito perché avevi paura di essere toccato dalle sue dita sottili, dalle unghie lunghe orlate di nero. Avevi paura che ti prendesse per i capelli e ti schiacciasse a terra, come lo zio. Li evitavi nei corridoi, nei bagni, nel cortile della scuola. Non sai che molti di loro moriranno giovani.
I sogni della tua infanzia dicevano la verità.
Gloria al padre e al figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Astuzia del tempo. Presunzione d’origine o teleologia. Come col Grande fratello, come con Bin Laden. Malinconia e lutto, memoria e scongiuro, ritorno del morto. E anche qui (ma dov’è questo qui? È forse lì?) non abbiamo tempo per ripercorrere le lezioni di Manlio Iofrida sul Fort-Da e sul Time Out of Joint. Se non le abbiamo imparate a memoria, se non ci siamo ritornati dopo, se non abbiamo preso appunti, o se questi sono andati distrutti, se le abbiamo dimenticate, è perché il tempo si è incasinato. Quelli che vogliono farti credere che saremo segnati per sempre, quelli che vogliono convincerti, quelli che credono senza ascoltarti, quelli che non vogliono crederti, sono quelli che ci fanno male – a farci male non è certo lo sterco di cane che cade sui capelli – sono quelli che credono ad una memoria assoluta, ad un tempo omogeneo e vuoto, senza speranza di redenzione: solo Ricordo e mai smemoratezza. I dolori senza parole sono ciechi, le parole senza sentimenti sono vuote. Niente è più falso di un fatto in se stesso.
Benedetto illuminismo.
VI
All’inizio del nuovo secolo, quando avevo 33 anni, ero più spigliato. Mi svegliavo più tardi. Non ero ancora un insegnante. Poi, con l’insegnamento, sono diventato pedante, conformista, moralista. Non è lo stipendio che fa diventare piccolo-borghesi, è la sveglia, è trovare sui sedili del treno gli zainetti stercorari, le braghe calanti, le scarpe slacciate degli studenti poggiate sui sedili. Mai posare le chiappe nude sopra un sedile dove può esserci caduto dello sterco.
Poi mi lava mia madre?
Finché studiavo all’università, ogni sera andavo a letto tardi e mi svegliavo tardi al mattino. Adesso la sera ho sonno, troppo sonno per leggere un romanzo lungo senza frantumarlo tra sera e sera, e ancora ogni singola sera nel mio dormiveglia.
Non lavori in miniera o in fabbrica, mi dico.
Apparecchio e sparecchio, riempio e svuoto lavatrici, apro e chiudo finestre, faccio la spesa e ripongo le merci in dispensa e in frigorifero. Non lavo mai la macchina, ma pulisco ogni giorno tavoli o lavandini. Certi pomeriggi vado a prendere mio figlio a scuola e sto con lui ai giardini pubblici. Non so quando finisce il lavoro e inizia il riposo. Lavoro a scuola, compilo e correggo a casa le verifiche, emendo o glosso i libri che i miei alunni dovranno studiare, leggo qualche articolo, scendo in apnea di fronte a questo schermo.
Certe notti, quando mio figlio è già addormentato, riesco a leggere. Non di rado dopo quattro pagine mi cade la testa sul libro.
Prima che si dorma devo ricordarmi chi sono. Ecco la genealogia della morale di stasera, la mia preghiera della buonanotte.
Mi sono educato a svegliarmi la mattina presto senza provare rancore per la libertà di quelli che ancora cazzeggiano all’università, nonostante abbiano passato i 30 da tempo.
VII
Da un vecchio libro è saltata fuori questa poesia di Eduardo, trascritta da me. Non garantisco l’esattezza ortografica.
Finalmente posso chiedere a Marco se esiste una traduzione completa in inglese delle interviste di Eduardo. Devo chiedergli se riesce a trovare il tempo di chiarirmi alcuni passaggi.
Con Marco sono stato ingiusto, lo hanno messo sotto per un progetto, non so ancora che mi spedirà buona parte dei libri di Eduardo, libri che la sera, tornando dall’ufficio, mi aiuterà a tradurre.
Ma poi, non sarà che la traduzione è una divinazione, e la lingua madre un mito?
La lingua s’impara, è un artificio, si possono parlare molte lingue. Oggi tutti masticano un po’ di inglese.
L’inglese è la lingua dei signori, del capitalismo mondiale. Ma è anche la lingua servile per chi voglia trasformare il mondo, per chi voglia perseguire l’unità del genere umano nell’uguaglianza e nella libertà.
Illuminismo inquieto.
A chi voglia perseguire l’unità del genere umano nell’uguaglianza e nella libertà, che lingua gli tocca parlare? Davvero l’inglese è una lingua illuminata? Davvero l’inglese può essere lo strumento giusto?
Se questa lingua non è uno strumento o un canale di trasmissione; se questa lingua del padre o dei fratelli e degli zii, lingua storica, lingua del potere e del contro-potere, non è una lingua naturale, non sarebbe meglio scegliere, come lingua d’elezione (ma si può scegliere una lingua?), la lingua della madre – la muttersprache, la mamaloshen – la lingua delle sorelle, lingua cosiddetta naturale?
Non è semplice.
Come avrei potuto guardarli in faccia parlando di Illuminismo? Come avrei potuto guardarli in faccia tutti, dopo aver glissato su fraternità?, il meno complicato dei tre motti della rivoluzione francese – forse. Come avrei potuto, dopo aver taciuto proprio su ciò che, secondo la tradizione, è all’origine della legge, e dunque anche di quell’uguaglianza, di cui il motto parla?
Questa volta non scappo, non mi sottraggo alle domande, non tengo nascosto il disagio.
Come parlare di uguaglianza in una lingua che è, dall’inizio alla fine, una lingua storica?
Non finisce qui.
VIII
Nel 1965, in un’intervista radiofonica, pubblicata in Was ist deutsch?, Adorno dice di aver mal sopportato la necessità dell’inglese nel periodo trascorso in America.
Non soltanto gli esiliati a New York o a Los Angeles hanno subito la forza dell’inglese. Anche chi è rimasto in Germania, col tempo, ha dovuto, se non piegarsi o rassegnarsi alla forza dell’inglese, perlomeno attutirne l’invasione, sentendosi quasi espropriato di quella lingua, il tedesco, considerata da alcuni, e dallo stesso Adorno, dotata di una vocazione, per così dire naturale per la filosofia.
Solo il tedesco ha una affinità con la lingua dei Greci e con il loro pensiero. Affinità che viene sempre di nuovo confermata dai Francesi, i quali, quando cominciano a pensare, parlano in tedesco, assicurando che con la loro lingua non ce la fanno [Ormai solo un Dio ci può salvare].
Non si possono tradurre le poesie, non si può tradurre il pensiero – dice Heidegger. Si può tuttavia in ogni caso parafrasarlo. Ma appena si tenta una traduzione letterale, tutto viene modificato. Si possono tradurre le lettere commerciali, in tutte le lingue – dice. Anche le scienze si possono tradurre. Le scienze naturali, con la fisica-matematica come scienza base, sono già traducibili in tutte le lingue del mondo o meglio: non si traduce affatto, si parla dovunque la stessa lingua matematica. Mentre il pensiero può essere pensato e modificato solo da quel pensiero che ha la stessa provenienza e la stessa destinazione.
Questa invasione dell’inglese è appunto lo spaesante [unheimlich]. Il funzionare come mezzo o come media spinge verso un ulteriore funzionare. Così la tecnica strappa e sradica l’uomo sempre più dalla terra. Non c’è bisogno della bomba atomica – dice. Lo sradicamento dell’uomo è già fatto.
IX
In un’intervista alla televisione tedesca del 1964 (Che cosa Resta? Resta la lingua materna), interrogata sul suo attaccamento alla lingua tedesca, Hannah Arendt risponde senza tanti giri di parole. Nonostante il suo esilio americano, nonostante sia rimasta in America (a differenza di Adorno e di altri che sono rimpatriati), e abbia scritto e insegnato in angloamericano, alla domanda se, nonostante i momenti più amari, la lingua tedesca sia sopravvissuta, Arendt risponde in modo diretto: Sempre. Ho sempre conservato l’attaccamento e la familiarità assoluta con la muttersprache.
Questo attaccamento è rimasto intatto anche nei momenti più cupi del nazismo?
Mi dicevo: che cosa si può fare? Non è la lingua tedesca a essere diventata folle! E in secondo luogo, niente può sostituire la lingua materna.
Come può la lingua stessa diventare folle? Non è mica una persona, non può certo ammalarsi, non la si può portare da un dottore. A perdere la ragione sono i soggetti di quella lingua, sono i tedeschi, alcuni di essi.
La lingua rimane intatta.
Mentre Arendt rivendica un attaccamento insostituibile, unico, costitutivo, direi quasi fondativo; un attaccamento senza riserve, fisico, intimo, esclusivo alla muttersprache e alla madre, mentre rivendica tutto ciò, riconosce, contemporaneamente, che la lingua non ha nulla di personale, di fisico, di tangibile.
Quello che Arendt sembra negare – dice Derrida -, anzi, denegare, scongiurare, è la possibilità che una lingua possa diventare folle. Arendt, dice Derrida, non può pensare questa aberrazione.
Quale?
Affinché i «Soggetti» di una lingua diventassero «folli», perversi e diabolici, cattivi per un male radicale, bisognava appunto che la lingua c’entrasse in qualche modo. Doveva avere la sua parte in ciò che ha reso possibile questa follia.
Ma come è possibile che una lingua prenda parte a una follia commessa dai parlanti? Non sono sempre gli uomini ad essere responsabili delle azioni, a macchiarsi dei crimini? Cosa ha a che fare la lingua col crimine e la crudeltà?
Se la muttersprache non è un mero strumento, se non è una maschera, se con essa non si ha un semplice legame, come quello che si ha con un qualsiasi oggetto indossato dalla nascita e del quale ci si può sempre sbarazzare; se la lingua è qualcosa nella quale nasciamo, e che non è insieme a noi, ma ci costituisce, ci accompagna negli spostamenti e negli esili, e di cui non possiamo disfarci senza disfare noi stessi, è necessario, dice Derrida, che il cittadino parlante diventi folle in [Derrida sottolinea in] una lingua folle – dove le parole perdono o pervertono il loro preteso senso comune. E si capisce meno di niente di una cosa come il nazismo – dice – se si esclude, con la lingua e il linguaggio, tutto ciò che ne è inseparabile: non è affatto niente, è quasi tutto.
Dall’altra parte, questo legame con la madre e la lingua materna è unico e sostituibile. Non c’è un metalinguaggio con il quale parlare o curare la lingua madre. Non c’è una lingua madre della lingua madre, un libretto di istruzioni della muttersprache.
X
Nel 2002, nel Centre Dona i Literatura di Barcellona, in un seminario tenuto insieme a Hélène Cixous, Derrida torna sulle considerazioni di Hannah Arendt e sulla muttersprache.
Quando parlo della «lingua» – dice – non penso a una cosa autonoma, a un soggetto libero e autonomo, a qualcuno. La lingua non è qualcuno, e neanche qualcosa. Non c’è metalinguaggio. Non c’è una lingua aldilà della lingua. Non c’è un aldilà per la lingua.
Quando parliamo, dice, parliamo in una lingua, e quando vogliamo parlare della lingua continuano a parlare nella lingua. La lingua è un monologo. Ciò non vuol dire che sia solitaria e che non se ne venga fuori, ma che quand’anche se ne esca, c’è bisogno di parlare per uscirne e, paradossalmente, è questa la balaustra contro l’essensializzazione. La lingua è presa prigioniera nella lingua, il discorso sulla lingua è preso prigioniero nella lingua e, pertanto, non si lascia essenzializzare, non si lascia ipostasiare. Quando dico essenzializzazione, denuncio un modo di proiettare qualcosa, di costituirlo in essere, in esistente o in sostanza.
Non si dà metalinguaggio vuol dire che non ci si appropria della lingua. Rispetto alla lingua – e la lingua è sempre muttersprache – siamo in ritardo. La lingua ci segna, e questo segno rimane muto.
In ebraico lingua significa labbra.
Servo-padrone qui trova un limite.
Il padrone, dice Derrida [Monolinguismo dell’altro], non possiede in proprio, naturalmente, quello che tuttavia chiama la sua lingua: perché, qualunque cosa voglia o faccia, non può intrattenere con essa dei rapporti di proprietà o di identità naturali, nazionali, congeniti, ontologici; poiché non può accreditare e dire questa appropriazione che nel corso di un processo non naturale di costruzioni politico-fantasmatiche; poiché la lingua non è un suo bene naturale, proprio per questo egli può storicamente, attraverso la violazione di un’usurpazione culturale, e dunque sempre di essenza coloniale, fingere di appropriarsene per imporla come «la propria». Se questa è una sua credenza vuol farla condividere con la forza o con l’astuzia, vuol far credere a essa, con la retorica, la scuola o l’esercito. Gli basta, con qualsiasi mezzo, farsi capire, far funzionare il suo «speech act». Il «colonialismo» e la «colonizzazione», dice Derrida, sono una continuazione della cultura.
Dal fatto che la lingua si dà, ma non è, non bisogna concludere che la lingua non marchi la sua presenza – con una incisione sulla schiena, per esempio.
Da una parte, dice Derrida, c’è questo effetto di alienazione, di sottrazione delle lingua. Ma non si tratta di un’alienazione, per così dire, tradizionale, di un’alienazione rassicurante, e rassicurante proprio in quanto si ha la possibilità o la pretesa di ritornare in possesso di ciò che è stato alienato, di ritornare, dice, ad una pienezza originaria intatta – con la madre, per esempio. Questa alienazione, dice [La lingua che verrà], non è un evento che ha luogo in un momento dato, come se fossimo, per esempio, padroni e signori del nostro linguaggio e venisse qualcuno o qualche forza a portarcelo via. L’alienazione fa parte della nostra esperienza della lingua sin dall’inizio, è originaria. Dal momento in cui parlo, dal momento in cui accedo al linguaggio, insomma da quando il bebè, il bambino parla, a cominciare dal ricevere, per lasciarsi imporre una lingua che è quella della società in cui si vive, della famiglia, il bambino è già sottoposto alla legge di qualcosa che non gli appartiene, che gli è estraneo, si appropria di qualcosa di cui non può appropriarsi, che gli è e gli sarà estraneo. Poiché questa alienazione non ha storia, poiché comincia dalla prima parola, dalla prima sillaba, è un’alienazione che, dice, non può essere alterata. Sono sempre in questa alienazione.
La lingua, conclude Derrida, non ci appartiene come un bene naturale. Non possiedo la lingua come possiedo un’altra cosa. La lingua non mi appartiene. Nessuno può dire «questa lingua mi appartiene».
Poiché la lingua non appartiene a nessuno, poiché questa non-appartenenza, questa alienazione non ha storia, si conclude che il rapporto che si ha con la lingua è naturale.
Il rapporto alla lingua materna, così come il rapporto alla madre, sarebbe naturale: unico e insostituibile.
L’idea che, a differenza del padre, si sappia «naturalmente» chi è la madre, dice Derrida [Monolinguismo], dal momento che si può vedere la nascita, è un vecchio fantasma, e non sarebbe stato necessario attendere «le madri in affitto» o la «procreazione assistita» per identificarlo come tale, cioè come fantasma.
Così, dice Derrida [Mono], da heideggeriana quale resta a questo riguardo, ma come molti tedeschi, ebrei o meno, Arendt ri-afferma la lingua materna, cioè una lingua alla quale viene prestata una virtù di originarietà. «Rimossa» o meno, questa lingua resta l’essenza ultima del suolo, la fondazione del suolo, la fondazione del senso, l’inalienabile proprietà che viene trasportata con sé.
Al contrario, dice Derrida, la madrelingua non ha nulla di originario. All’origine non c’è la madre. All’origine c’è il fantasma, la traccia della madre, di una madre – di una tra le tante, ma sempre unica, sostituibile ma unica, di volta in volta unica.
XI
Anche per Adorno (Was ist deutzsche?), la lingua tedesca ha chiaramente un’affinità elettiva con la filosofia, un’affinità con la speculazione.
Se è difficile, pensa Adorno, tradurre testi filosofici di alto livello, come La fenomenologia dello spirito o la Scienza della logica di Hegel, è perché il tedesco radica i suoi concetti filosofici in una lingua naturale che bisogna conoscere fin dall’infanzia. Ne deriva, tra filosofia e letteratura, un’alleanza radicale – radicale perché nutrita alle stesse radici, quelle dell’infanzia.
Se non si è radicati in una lingua, se non si trova casa in una lingua filosofica, non si può filosofare. Non si può filosofare in italiano.
Poiché di filosofia non può esisterne più d’una, allora una filosofia in una lingua che non sia il tedesco è falsa.
Perché Adorno, chiede Derrida, tenta di giustificare il suo ritorno in Germania con l’argomento della lingua?
Da una parte, dice Derrida, Adorno tenta di resistere all’egemonia internazionale di una lingua di comunicazione (che per Adorno era già l’angloamericano), tenta di opporsi all’utilitarismo strumentale di una lingua puramente funzionale e comunicativa. Una resistenza che si trova anche in Heidegger.
Dall’altra parte, bisogna chiedersi se Adorno abbia ceduto al nazionalismo, prestando queste armi arrugginite alla reattività identitaria e a tutta la vecchia ideologia sovranista, comunitarista e differenzialista.
Adorno vuole sicuramente – e lo capisco benissimo, dice Derrida, – continuare ad amare la lingua tedesca, a coltivare l’intimità originaria con il suo idioma, senza nazionalismo, senza il narcisismo collettivo di una metafisica della lingua. Contro questa metafisica della lingua nazionale, la cui traduzione e la cui tentazione sono ben note, dice Adorno, la veglia di chi sta sveglio di notte deve essere instancabile.
Ma questo amore per la lingua, per la muttersprache, è sempre un amore nostalgico.
Nostalgia originaria, dice Derrida, nostalgia che non ha atteso la perdita storica o effettiva della lingua. Nostalgia congenita che ha l’età del nostro corpo a corpo con la cosiddetta lingua materna – o paterna. Come se questa lingua fosse stata persa fin dall’infanzia, fin dalla prima parola. Catastrofe destinata a ripetersi ad ogni parola.
L’esperienza dell’unheimlich – lo spaesamento – l’esperienza dello sloggiamento, del profugo, dell’erranza e dell’errare, dell’errore, dell’interferenza e dell’accento è congenita.
La muttersprache la si riceve perdendola.
Eppure – ecco il risvolto della medaglia – questa lingua che non ci appartiene, questa lingua sovrana, cade nella storia. E non cade in piedi.
XII
C’era uno scrittore messicano che aveva una cicatrice in fronte: «La vedete questa? Nel 1968 ero a Città del Messico in piazza delle Tre culture. Ricordo perfettamente la folla, i lacrimogeni, il poliziotto con lo sfollagente, io che fuggivo. Lui, il poliziotto, mi inseguiva, riusciva a colpirmi qui, mentre io svicolavo. Bene. Una sera raccontavo la storia a degli amici francesi. Mia madre ci ascoltava dalla cucina, preparava il caffè. A un certo punto non ce l’ha fatta più e ha sbottato: Che cosa dici, Paco? Ma se sei caduto dal seggiolone a sette mesi».
Uno scrittore italiano riferiva così – o almeno così lo rammento – l’aneddoto dello scrittore messicano. Lo portava a esempio di un falso ricordo. Non ho approfondito, si parlava d’altro, allo scrittore italiano non ho fatto domande. L’ho dimenticato per mesi e mi sono ricordato per caso, conversando al telefono col mio amico Gianluca.
«Facciamo presto a dire falso, errore, sbagliato», distingueva Gianluca, maestro elementare e storico, collega. «Bisogna capire in che modo è falso. Come si sbaglia. Dov’è l’errore. Bisogna valutare l’errore. Gli errori non vanno contati, vanno compresi».
Lo scrittore Paco era convinto di portare i segni della repressione, e magari non aveva torto. Non è chiaro che cosa sarebbe falso nel suo ricordo: la presenza in piazza, la botta dello sfollagente in fronte, la datazione della ferita. Forse Paco aveva ricevuto colpo su colpo, la ripetizione del trauma non aveva lasciato una traccia, perché la cicatrice già c’era.
Sono convinto che la verità sia una ripetizione – dice Alberto. La ripetizione è un modo per capire. Non si ripete quello che fu, che era in passato, senza che ci sia uno scarto, una deviazione, la lieve incoerenza da cui nasce l’intero universo. Diventa vero quello che viene ripreso, che resta e ricresce diverso come l’erba di questo parco. È questa la mia religione? Riconoscere l’ombra del dopodomani, ritrovare nel presente i corpi, i gesti del passato e forse del futuro, il prolungarsi di un evento che ancora non c’era, il sigillo degli altri in noi, qualcosa che era possibile, che finalmente è diventato vero, o che lo sarà.
XIII
Nel 1920 Scholem lesse La stella della redenzione, appena uscito, e cominciò così a corrispondere con Rosenzweig.
Rosenzweig allora non era ancora malato, e aveva cominciato a studiare il Talmud. I due si erano incontrati. Avevano preso decisioni dirette in sensi diversissimi.
Rosenzweig cercava di riformare, o di rivoluzionare dall’interno l’ebraismo tedesco. Scholem non riponeva più alcuna speranza nell’amalgama noto come ebraismo tedesco, e si attendeva che l’ebraismo fosse rinnovato solo dalla sua rinascita nel paese d’Israele.
Una seconda visita di Scholem a Rosenzweig, con una lunga conversazione notturna sul tema di questo ebraismo tedesco che Scholem ricusava, portò a un dissidio completo.
Infine, Scholem aderì completamente al sionismo, si trasferì in Palestina e contribuì alla costruzione dello Stato di Israele. Ma non tutto andò per il verso giusto.
Questo paese è un vulcano – dice Scholem (Da Berlino a Gerusalemme). Si parla qui di molte cose che potrebbero farci andare alla malora, ed oggi più che mai si parla degli Arabi. Ma c’è un’altra minaccia di fronte a noi più inquietante del popolo arabo, che chiama in causa necessariamente l’impresa sionista: che ne è della «attualizzazione» della lingua ebraica? Questo abisso d’una lingua sacra, nel quale i nostri figli vengono calati, dovrà ancora una volta spalancarsi? Certo non si sa quello che si fa. Si crede di aver secolarizzato la lingua; ma non è vero affatto, la secolarizzazione della lingua è soltanto una façon de parler, una frase fatta. È semplicemente impossibile svuotare le parole piene zeppe di significato, a meno di sacrificare la lingua stessa. Lo spettrale volapük che qui parliamo per strada, dice, indica esattamente quell’universo linguistico privo di espressione, nel quale la «secolarizzazione» della lingua poteva realizzarsi, e solo in questo modo poteva realizzarsi. Ma se tramandiamo ai nostri figli la lingua che ci è stata tramandata, se noi, dice, generazione di passaggio, vivifichiamo per loro la lingua degli antichi libri, affinché essa possa di nuovo rivelarglisi – allora un giorno non potrà la potenza di questa lingua prorompere? E tale irruzione quale generazione incontrerà? Viviamo in questa lingua quasi tutti con la sicurezza del cieco sospeso su un abisso, ma quando torneremo a vedere, noi, o chi verrà dopo di noi, non vi precipiteremo? E nessuno sa se il sacrificio del singolo che perirà cadendo in questo abisso sarà sufficiente per chiuderlo.
I creatori del nuovo movimento linguistico credevano sino all’ostinazione nella virtù miracolosa della lingua, e questa era la loro fortuna – dice Scholem. Nessun vedente avrebbe trovato il coraggio demoniaco di far resuscitare una lingua là dove solo poteva nascere un esperanto. Quelli andavano e vanno tutt’oggi come stregati sopra l’abisso, che tace, e l’hanno tramandato alla gioventù insieme con i nomi e i sigilli. Adesso, dice, ci sentiamo talora inorriditi, quando, sentendo una parola religiosa nell’ambito d’un discorso irriflessivo, essa ci spaventa. Nefasto è questo ebraico: nel suo attuale stato non può e non potrà permanere; i nostri figli non hanno più un’altra lingua ed è giusto affermare che loro e soltanto loro dovranno scontare questa congiuntura che noi gli abbiamo causato, senza chiedere, e senza chiedere a noi stessi. Se la lingua si rivolterà contro i suoi parlanti – e in alcuni momenti lo fa già nella nostra vita, e questi sono momenti difficilmente dimenticabili, nei quali si rivela la temerarietà delle nostre audaci imprese – avremo allora una gioventù che potrà sostenere la rivolta di una lingua sacra?
La lingua è nome – dice. Nel nome è racchiusa la forza della lingua, è sigillato il suo abisso. Non è più nelle nostre facoltà evocare tutti i giorni gli antichi nomi senza destare le loro potenze. Essi si manifesteranno, allorché noi li abbiamo certo evocati con grande potenza. Sicuramente noi parliamo una lingua rudimentale e spettrale: i nomi si aggirano nelle nostre frasi, e c’è chi negli scritti e negli articoli giornalistici gioca con loro, e fa credere a sé o a Dio che ciò non significa nulla, e spesso la forza del sacro si sprigiona dalla vergogna spettrale della nostra lingua. Poiché i nomi hanno una propria vita e se non l’avessero, guai ai nostri figli, i quali sarebbero consegnati ad un vuoto senza speranza.
Ogni parola che, dice, non è appunto creata di bel nuovo, ma che piuttosto è tratta dall’«antico buon» tesaurus, è colma di significato. Una generazione che adotta l’elemento più fecondo delle nostre attuali tradizioni: la nostra lingua, non può, anche se lo vuole mille volte di più, vivere senza tradizione. Quel momento in cui la forza che giace riposta nella lingua si manifesterà, e dove il «detto» del contenuto della lingua prenderà di nuovo forma, porrà nuovamente tale sacra tradizione, come segno decisivo, davanti al nostro popolo e questo, a cospetto di ciò, avrà soltanto una scelta: piegarsi o estinguersi. Dio non resterà muto in una lingua nella quale sarà in mille modi rievocato nella nostra vita. Tuttavia, dice, questa inevitabile rivoluzione della lingua, nella quale la Voce tornerà a farsi udire, è l’unico oggetto del quale in questo paese non si parla mai, poiché quelli che avevano richiamato nuovamente in vita la lingua ebraica, non credevano al Giudizio che grava per questo su di noi. Voglia quindi il cielo che la noncuranza che ci ha condotto su questa strada apocalittica non ci porti alla rovina.
XIV
Negli anni venti, in Palestina, scrive Derrida [Gli occhi della lingua], Scholem ascolta i Nomi sacri della lingua ebraica riservati alla preghiera, o perlomeno usati solo nella preghiera, li sente in strada, sull’autobus, nella bottega all’angolo, sui giornali che ogni giorno pubblicano delle liste di parole nuove da iscrivere nel codice dell’ebraico secolare. Si deve immaginare il desiderio ed il terrore di fronte a questo riversarsi, a questa prodigalità prodigiosa, sfrenata, che inonda di nomi sacri la vita di tutti i giorni, donandosi la lingua stessa come una manna miracolosa, ma anche come la tentazione d’una jouissance profanatrice, davanti alla quale una sorta di concupiscenza religiosa arretra terrorizzata.
Se i sionisti fossero stati chiaroveggenti, scrive Scholem a Rosenzweig, non avrebbero mai avuto il coraggio demoniaco di resuscitare una lingua destinata a diventare un esperanto.
Essendo sacro, l’ebraico era allo stesso tempo una lingua morta – in quanto lingua che non si parlava o non si doveva parlare nella vita quotidiana – ed una lingua più viva di quella che correntemente si chiama una lingua viva.
Secondo Scholem l’ebraico attualizzato suscita questo morto vivente, consacrato allo studio e alla preghiera, e non lo conduce fuori dal tempio o dalla tomba se non per una sinistra mascherata, questo quasi esperanto o volapük, è strumento di una semiotica, valore di scambio disincarnato, scarnificato, formalmente universale, strumento nel commercio dei segni, senza un luogo proprio, senza un nome proprio, falso ritorno alla vita, resurrezione di paccottiglia: una razionalizzazione secolarizzante che appiattisce, appiana, livella, con la lingua, la resistenza di ogni singolarità e di ogni eccezione – scrive Derrida.
Cosa va smarrito con questa secolarizzazione della lingua ebraica antica?
La lingua è sacra. In essa parla Dio, la sua voce vi è sigillata, in deposito, in riserva. Essa contiene il giuramento dell’alleanza o della fede che ci lega a Dio.
Il contenuto di questa parola (l’alleanza con Dio) riprende forma ad ogni lettura. La sua voce si ridesterà e Dio parlerà di nuovo, noi gli risponderemo con le stesse parole. Allora ci si sottometterà alla legge della lingua nella quale la forma della parola non sarà più, non sarà in verità mai stata separata dal suo senso. Il senso riprenderà forma nella manifestazione, esso si ridesterà e si rivelerà.
L’interpretazione della lingua – scrive Derrida – implica qui che la separazione fra contenuto e forma non ha luogo nella lingua.
La separazione ha luogo soltanto nel momento in cui la lingua viene secolarizzata. Ha luogo soltanto nella degradazione che contamina la lingua per mezzo della non-lingua, del volapück o dell’esperanto.
Si ritrova qui – dice Derrida – la critica di Benjamin alla semiotica o al semiotismo che chiama «borghese», con le sue opposizioni tradizionali: sensibile/intelligibile, forma/senso, contenuto/forma, significato/significante, le quali si comprendono nella loro tradizione platonica o nella loro modernizzazione, quella dell’Aufklärung, per dirla in breve. Tutte queste dissociazioni mediatizzano, mettono a disposizione i mezzi e strumentalizzano la lingua. Sono mezzi destinati a ridurre al silenzio la parola di Dio. Ci rendono sordi alla parola sacra o, che è lo stesso, riducono Dio al mutismo. Essi reprimono o, se preferite, rimuovono (ma la rimozione è ancora una categoria psico-scientifica, positivista, dunque mutuata da uno spazio secolare e fondamentalmente semiotista) qualcosa come una congiura fra Dio e noi. Questa lingua sacra è la con-giura stessa.
La lingua di cui parla la filosofia, continua Derrida, nella misura in cui quest’ultima vive delle opposizioni che abbiamo appena richiamato, è una lingua di sordo-muti. Il ritornare, oltre la filosofia, a quest’essenza parlante della lingua sacra, è passare attraverso la scrittura sacra che tiene in serbo la parola di Dio, la voce di Dio, e questo ritorno non è niente di meno che una rivoluzione, la rivoluzione stessa.
Il degrado arriva proprio dall’esposizione. Quando la lingua si espone, quando esce per così dire all’esterno, quando diventa scrittura, si degrada.
XV
La perversione dell’artificio genera mostri – dice Saussure. La scrittura, come tutte le lingue artificiali che si vorrebbero fissare e sottrarre alla storia vivente della lingua naturale, partecipa della mostruosità. È uno scarto dalla natura. La Caratteristica di tipo leibniziano e l’Esperanto sarebbero qui, commenta Derrida, uno stesso caso.
L’irritazione di Saussure di fronte a simili casi (irritazione tradita sempre dall’accento) gli fa dire che bisogna proteggere la vita spontanea. All’interno della scrittura fonetica comune occorre guardarsi dall’introdurre l’esigenza scientifica e il gusto dell’esattezza. La razionalità sarebbe portatrice di morte, di desolazione e di mostruosità.
Saussure, dice Derrida, vuole denunciare l’alterazione della parola viva ad opera della scrittura, vuole denunciare il male che questa fa a quella. Sottolinea l’indipendenza inalterabile e naturale della lingua viva.
La tirannia della lettera, scrive Saussure nel capitolo VI del Corso, a forza d’imporsi alla massa, si spinge oltre, essa influenza la lingua e la modifica, fino a creare pronunce viziose. Ad esempio, per il nome di famiglia Lefèvre (dal latino faber) vi erano due grafie, una popolare e semplice, Lèfevre, l’altra dotta ed etimologica, Lèfebre. Grazie alla confusione di v con u nell’ortografia antica, Lèfebvre è stato letto Lefèbure, con una b che non è mai esistita realmente nella parola e una u proveniente da un equivoco. Tuttavia questa forma è ora realmente pronunciata.
Interferenza della lettera sulla voce, dalla langue sulla parole, la quale tradisce una provenienza e una storia di calchi e ricalchi, di errori di scrittura e di pronuncia.
Dov’è il male? dov’è il sacrilegio? – chiede Derrida. Che cosa è stato investito nella Parola Vivente, tale da rendere insopportabili queste Aggressioni della scrittura? Quale interdetto è stato trasgredito?
Qualsiasi risposta si dia a questi interrogativi, rimane il fatto che sia l’interferenza, sia l’accento, rivelano all’orecchio o all’occhio dell’inquisitore la trasgressione, la violazione della regola, se non della legge stessa.
Ma cosa c’è di male? – chiede ancora Derrida.
Perché determinare la fenditura della voce come una violenza? Perché – chiede – la lingua materna non dovrebbe avere storia, o, il che è lo stesso, produrre la propria storia in modo perfettamente naturale? Perché voler punire la scrittura per un crimine mostruoso, tanto da pensare di riservarle, nello stesso trattamento scientifico, un «reparto speciale» che la tenga a distanza?
È proprio in una sorta di lebbrosario intralinguistico – dice – che Saussure vuole contenere questo problema delle deformazioni ad opera della scrittura.
In fin dei conti Lefébure non è male – dice Derrida. Eppure Saussure spiega, con accento pessimista (nota Derrida), che in tutto questo non c’è un Gioco Naturale, ed è probabile che queste deformazioni diverranno sempre più frequenti, e che si pronunceranno sempre più lettere inutili. A Parigi già si dice: sept femmes, facendo sentire la t. Darmester – rincara Saussure – prevede già il momento in cui si pronunceranno perfino le lettere finali di vingt, vera mostruosità ortografica. Queste deformazioni foniche appartengono certo alla lingua, solo che non risultano dal suo uso naturale, ma sono dovute a fattori estranei. La linguistica deve metterle in osservazione in un reparto speciale: si tratta infatti di casi teratologici. Di mostri, insomma.
L’accento e l’interferenza sono deformazione interne. È l’interno che attacca se stesso, che si auto-affetta. Sindrome auto-immune.
L’accento è la voce che attacca se stessa – dall’interno.
L’interferenza è la voce che attacca se stessa – dall’interno.
La dislalia è un nome provvisorio e del tutto inadeguato per questa sindrome dall’auto-immunità.
La dislalia è il tentativo di trasposizione – di traslazione – della lingua con se stessa.
La disgrafia – idem!
Che nella vita di tutti i giorni ad avere l’accento, o a sentire di doverlo perdere pena l’ansia di essere confinati in reparti speciali teratologici, sia il meridionale, è indice di una gerarchia tra gli idiomi cosiddetti materni, gerarchia nella quale l’idioma che interferisce è sempre l’idioma del debole, etichettato come idioma debole, ovvero come dialetto. La partizione gerarchia e convenzionale tra dialetto e lingua formalizza le regole di esclusione e l’insieme di trasgressioni ammesse o non ammesse.
Ognuno nella propria lingua madre, ammesso che sia una lingua dominante, crede di non avere accento. Il meridionale ha sempre l’accento. Anche nel soliloquio.
Ma non finisce qui.
Chi voglia perseguire l’unità del genere umano nell’uguaglianza e nella libertà, in che lingua dovrà parlare?
Come avrei potuto guardarli in faccia, dice Alberto, parlando di Illuminismo? Come avrei potuto guardarli in faccia tutti, dopo aver glissato su fraternità, il meno complicato dei tre motti della rivoluzione francese – forse.
E non finisce proprio qui.
XVI
Derrida (Monolinguismo).
Credo di non aver perduto il mio accento, di non aver perduto tutto il mio accento di «francese d’Algeria». L’intonazione risulta maggiormente percepibile in determinate situazioni «pragmatiche» (la collera o l’esclamazione nell’ambiente di famiglia o familiare, più spesso in privato che in pubblico, ed è in fondo un criterio abbastanza sicuro per l’esperienza di questa strana e precaria distinzione). Ma credo di poter sperare, mi piacerebbe davvero che nessuna pubblicazione lasciasse trasparire nulla del mio «francese d’Algeria». Non credo, per il momento e fino a prova contraria, che si possa scoprire nella lettura, e se non lo dichiaro io stesso, che sono un «francese d’Algeria». Della necessità di questa trasformazione vigilante conservo indubbiamente una sorta di riflesso acquisito. Non ne sono fiero, non ne faccio una dottrina, ma è così: l’accento, qualsiasi accento francese, e in primo luogo il forte accento meridionale, mi sembra incompatibile con la dignità intellettuale di una parola pubblica. (Inammissibile, non e vero? Lo confesso.) Incompatibile afortiori con la vocazione di una parola poetica: aver sentito René Char, per esempio, leggere i suoi aforismi sentenziosi con un accento che mi è sembrato insieme comico e osceno, il tradimento di una verità, non è stata poca cosa nel guastarsi di un’ammirazione di gioventù.
L’accento, continua Derrida, segnala un corpo a corpo con la lingua in generale, dice più dell’accentazione. La sua sintomatologia invade la scrittura. È ingiusto, ma è così. Attraverso la storia che sto raccontando e malgrado ciò che, per un altro verso, sembra talvolta che io professi, ho contratto, lo confesso, un’intolleranza inconfessabile ma inflessibile: non sopporto o non ammiro, per lo meno in francese, e soltanto per ciò che riguarda la lingua, che il francese puro. Siccome in tutti gli ambiti, continua Derrida, sotto tutte le sue forme, non ho mai smesso di rimettere in questione il motivo della «purezza» (la prima mossa di ciò che viene chiamato “decostruzione” la porta verso questa “critica” del fantasma e dall’assioma della purezza o verso la decomposizione analitica di una purificazione che ricondurrebbe alla semplicità indecomponibile dell’origine), non oso ancora confessare questa esigenza compulsiva di una purezza della lingua se non nei limiti di cui sono sicuro: questa esigenza non è né etica né politica né sociale. Non mi ispira nessun giudizio. Mi espone soltanto alla sofferenza quando qualcuno, e potrei essere io, non la rispetta. Soffro di più, certo, quando mi sorprendo o quando sono preso io stesso in «flagranza di reato» (eccomi a parlare comunque di reato, malgrado quel che ho appena denegato). Soprattutto, questa esigenza risulta così inflessibile da eccedere talvolta il punto di vista grammaticale, da trascurare anche lo «stile» per piegarsi a una regola più segreta, per «ascoltare» il mormorio imperioso di un ordine di cui qualcuno in me ha la presunzione di comprendere, anche in situazioni in cui sarebbe l’unico a farlo, faccia a faccia con l’idioma, l’intento ultimo: l’ultima volontà della lingua, insomma, una legge della lingua che non si confiderebbe se non a me. Come se fossi il suo ultimo erede, l’ultimo difensore e illustratore della lingua francese. (Sento da qui le proteste, da diversi lati: ma si, ma sì, ridete pure!) Come se cercassi di giocare questo ruolo, di identificarmi con quell’eroe-martire-pioniere-legislatore-fuorilegge che non esiterebbe davanti a nulla per mostrare che quest’ultima volontà, nella sua purezza imperativa e categorica, non si confonde con niente che sia dato (il lessico, la grammatica, la buona educazione linguistica o poetica) – che non esiterebbe dunque a violare tutte queste regole, a bruciare tutto, per arrendersi e ubbidire alla lingua, a questa lingua. Sempre infatti, lo confesso, mi arrendo alla lingua.
Quale lingua? La lingua – la legge.
E non finisce qui.
XVII
Sarebbe bello se gli oppressi, le minoranze, i minori, i bambini fossero sempre buoni, empatici, sensibili al dolore degli altri. Sarebbe bello se i proletari non fossero mai razzisti. Se non offendessero mai chi non vive seguendo le proprie usanze, se rivelassero sempre un’infallibile vocazione illuminista. Sarebbe bello se i deboli fossero superiori ai forti. Sarebbe bello se dal dolore che proviamo e dalle ingiustizie che subiamo, imparassimo a essere migliori e a lottare con gli altri affinché non ci siano più ingiustizie. Sarebbe bello se non ci vendicassimo mai della nostra debolezza e del nostro dolore su chi è più debole e infelice di noi. Questo pensava il professor Tale appena sceso dal treno, e prima che sterco di picciona gli piovesse sulla testa, costringendolo a sedersi.
Il nazionalismo, pensò, ha bisogno di opporsi a un nemico straniero: eserciti stranieri, territori stranieri, stranieri a metà, stranieri occulti, stranieri interni, imprese straniere, criminali stranieri. Noi non siamo stranieri, stranieri sono sempre gli altri. I nazional-regionalisti borghesi, che chiedevano autonomia o indipendenza, nella misura in cui difendevano i propri interessi economici, mentre nel paese si facevano riforme e si otteneva il suffragio universale, non potevano raffigurare se stessi né per quel che erano, possidenti borghesi, né per quello che erano stati, ma erano sempre di meno, ovvero figli di bianchi, europei, spagnoli.
Il nazionalismo oscura la lotta di classe. Si sostituisce ad essa.
Se non si fanno i conti con le contraddizioni di classe, e con i propri ambigui privilegi, come classe, pensò il professor Tale, ti scegli la comunità atavica, la stirpe, il branco, la cosca, la tua famiglia, che maledice e sottomette tutte le altre.
Ma non va sempre a finire così male. Qualcuno migra o si ricrea, vicino o lontano, un paese di amici. Altri cambiano casa, coltivano l’orto, restano in casa da soli, scrivono poesie liriche.
Una parte di questo mondo dovrebbe bruciare all’inferno. Davvero alcuni uomini e alcune donne per essere più umani dovrebbero distruggerne altri. Ma non lo dici. L’insegnante di sostegno non ha l’autorità, l’insegnante precario non ha il tempo. L’insegnate di ruolo non ha una base di appoggio.
La lotta di classe è assente perché le classi non si incontrano per strada, pensò. Gli operai delle fabbriche, dei cantieri navali, i minatori, i facchini, i braccianti, i muratori esistono e non esistono, e se anche esistono, sono individui dispersi, isolati, alieni che consumano, lavorano, parlano, si riproducono, muoiono in corpi, lingue, generi, religioni, etnie. Stati nazionali, eserciti, separati a una distanza che non vale la pena ridurre nelle lotte di classe. Siamo tutti minoranza di qualcosa, qui e altrove. Mutare la maggioranza in minoranza, senza che nulla cambi.
La lotta comune è anche consapevolezza dei propri effimeri privilegi – pensò.
Le classi di individui sottomessi, espropriati, coartati, esclusi, perseguitati, umiliati dai loro simili umani non sono una divisa o un’identità sicura. Sono campi di forze con limiti e orbite mutevoli. Possiamo essere muratori che pestano a sangue la moglie, vaccari che linciano il nigger, braccianti che stuprano la padrona, studenti che umiliano il frocio.
La classe, non è una classe. Siamo stati formati da gesti, scambi, incontri, relazioni, immagini, suoni, parole che ti tolgono la parola, che qui e ora ti inducono a tacere. Se parlassi di distruzione, dovrei aggiungere troppe parole. Dire quello che Aleksandr Blok scrisse in una lettera mai spedita a Majakovskij. La distruzione è vecchia e tradizionale come la costruzione. Ci si illude di contare qualcosa, ma si abita solo nella via sbagliata. Qualcosa sfugge, non si comprende: una continua perdita. Allora resti nei ranghi. Ci si abitua a restare seduti a un banco, ci si può abituare al lavoro, e anche a stare in cattedra. Ti svegli prima, vai a letto prima; per rubare tempo al sonno tieni la barba lunga fino alle vacanze estive.
Ti senti un vigliacco, un bravo nipote pettinato.
Non c’è nessuna impresa comune che ci protende al futuro, e se anche ci fosse non osiamo nominarla; ma almeno ci si affaccia alla finestra.
Non spari agli orologi se devi portare un bambino a scuola, se ti alzi al mattino per fare un lavoro di merda.
Meglio non restare soli.
Cerco di aggregarmi nel migliore dei modi.
Sto assieme a qualcuno che stimo, a certi colleghi, vecchi amici, compagni.
Ho una casa, un lavoro, una famiglia. Ma ho imparato che non c’è salvezza nella neutralità. Solo la storia ti salva. Ma appena metti piede fuori, una picciona ti caca in testa, e ti ricorda chi sei, che lingua parli, da dove viene, quali sono le cose che ami e quelle che odi.
Il nostro rifiuto del nazionalismo è molto selettivo. Solo questa babele, questo delirio, questi anagrammi zoppi e balbuzienti, sembrano talora racchiudere una profezia. Illuminismo mai attuale, che non è l’illuminismo che tutto dissolve nell’aria e di cui parla il Manifesto; che non è l’illuminismo che trova compimento nell’attualità di cui parla l’Introduzione del 57; che non è l’illuminismo della forza motrice che tutto appiattisce e di cui parla il Capitale; ma è l’illuminismo dei Lineamenti, delle oscillazioni e degli scarti, delle deviazioni, della danza e del casino da cui nasce una stella.