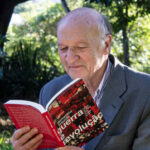Qual è stata la parola d’ordine di Lenin appena vinta la rivoluzione?
Soviet e industria elettrica.
L’industria e l’industrializzazione totale non fanno il comunismo – scrive Pasolini [Scritti corsari, 1975].
Anche se a Stalingrado non passano – aggiungono i CCCP Fedeli alla linea [Socialismo e barbarie, 1987.]
L’industrializzazione totale non l’hanno inventata né Marx né Lenin – dice Pasolini -, l’ha inventata la borghesia. Industrializzare un paese comunista contadino significa entrare in competitività coi paesi borghesi già industrializzati. È ciò che ha fatto Stalin. E del resto – continua Pasolini – non aveva altra scelta.
Pasolini non contesta né l’elettricità né l’industrializzazione. Nemmeno ciò che unisce, potenziandoli, i due fattori. Anche se, a voler essere pignoli, a congiungere la forza motrice elettrica alla fabbrica, non è l’e, congiunzione, ma, come nota giustamente Heidegger [Parmenide], il segno aritmetico +.
Il bolscevismo, scrive Heidegger, è l’unione organica, cioè organizzata e calcolatrice (in quanto +), della potenza organizzata del Partito con la completa tecnicizzazione.
È l’unione calcolante, non il fatto che i russi costruiscano sempre più trattori, ad essere unheimlich.
Perturbante è la portata metafisica del calcolo che tutto vuole misurare, per cosi dire, meccanicamente – persino la parola.
L’uomo moderno, dice Heidegger, non a caso, scrive con la macchina per scrivere, detta le parole nella macchina. La storia del modo di scrivere è una delle ragioni principali della crescente distruzione della parola. Nella scrittura a macchina – dice Heidegger – tutti gli uomini sembrano uguali.
Non c’è bisogno di dire che non è la macchinetta in sé a rendere gli uomini uguali – lo stesso Heidegger dettava le sue opere al fratello, il quale batteva sulla macchina da scrivere meccanica. Tant’è che Heidegger può far arretrare questo inizio sino a Platone (e anche Platone, nel Fedro, può esprimere lo stesso sconcerto), senza il bisogno di arrestarsi a Gutenberg – come capita ingenuamente a molti – per esempio a McLuhan, – o come capita ad altrettanti romanticoni della domenica che si fermano al libro di carta, ostentando un odio per il Kindle, reo di spossessarli di un presunto contatto diretto con la parola stessa, con l’esperienza viva della lettura o della letteratura.
Sia come sia, Pasolini è fedele a questa linea – senza un richiamo diretto ad Heidegger.
D’altronde, nella prima metà degli anni Settanta, quando gli articoli apparsi in Scritti corsari sono stati pubblicati, l’esistenzialismo e l’anti-illuminismo, erano filtrati abbondantemente in Italia, anche grazie al successo di alcuni libri di Marcuse [la traduzione delL’Uomo a una dimensione è del 1967, e nel 68 usciva la 7ima ristampa].
Dunque, il vero nemico è il totalitarismo.
Cos’è il totalitarismo?
È la riconduzione di ogni parola diversa ad un pensiero unico. Tale riduzione si chiama metafisica.
La metafisica non è una mera opera del pensiero.
La metafisica fa tutt’uno con la tecnica e con il capitalismo (e con lo stalinismo).
Quello che il mondo borghese non vuole capire, scrive Heidegger [p. 165], è che con il leninismo – come Stalin chiama questa metafisica – si è compiuto un balzo in avanti nel totalitarismo tecno-metafisico.
L’Europa è stretta in una morsa tra Russia e America, scriveva dieci anni prima Heidegger in Introduzione alla metafisica – 1933.
Se Heidegger fosse vissuto qualche altro lustro, avrebbe scritto che l’Europa era stretta tra la Cina e il Nulla. E che se si voleva salvare “l’essenza dell’uomo storico occidentale era necessario conoscere l’essenza della metafisica” [Parmenide 165].
Per Pasolini la Metafisica coincide con la società dei consumi e la televisione.
La metafisica è il neo-capitalismo, il quale, nel momento in cui promette un mondo di felicità senza confini, allo stesso tempo irregimenta; nel momento in cui offre la possibilità di realizzare il tuo piacere, riduce il tuo desiderio e la tua differenza a un modello unico.
Il neo-capitalismo offre possibilità di esistenza prodotte con la stessa identica matrice: a ognuno secondo il proprio desiderio, a ognuno la propria fuori serie.
Questa metafisica, dice Pasolini (in verità Pasolini parla di Potere – con la P maiuscola), si afferma attraverso tre tecniche:
1) L’edonismo interclassista. Il quale impone di adeguarsi nel comportamento, nel vestire, nelle scarpe, nel modo di pettinarsi e di sorridere, nell’agire o nel gestire a ciò che si vede nella pubblicità dei prodotti industriali. Il risultato è un generale appiattimento, che impedisce di distinguere un fascista da un comunista, un poliziotto da un operaio, uno studente da un professore, e che chiude l’epoca del vecchio fascismo e anti-fascismo e della vecchia sinistra e della vecchia destra, e apre l’epoca del nuovo totalitarismo.
2) La tolleranza permissiva. La quale richiede un modello di libertà sessuale che rasenta la coazione o l’erotomania sociale, e che esige un coito senza ostacoli, il quale non deve fermarsi, dice Pasolini, nemmeno di fronte alla sacralità della vita (il no all’aborto espresso da Pasolini va letto in questo quadro).
3) L’Afasia o la perdita della capacità linguistica. Nel caso della lingua, dice Pasolini, bisogna parlare di una vera e propria tragedia. Il potere transazionale delle multinazionali, estraneo alle realtà locali, avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto della televisione e della pubblicità, ha distrutto il patrimonio linguistico nazionale, imponendo una neo-lingua tecnica e scientifica, veicolare, burocratica e commerciale – borghese.
Tutta l’Italia centro-meridionale, scrive Pasolini, aveva proprie tradizioni regionali, o cittadine, di una lingua viva, di un dialetto che (proprio perché vivo) era rigenerato da continue invenzioni, e all’interno di questo dialetto, di gerghi ricchi di invenzioni quasi poetiche: a cui contribuivano tutti, giorno per giorno, ogni serata nasceva una battuta nuova, una spiritosaggine, una parola imprevista; c’era una meravigliosa vitalità linguistica.
La televisione – metafisica del potere tecno-scientifico – è stata una tragedia. Ha prodotto un genocidio, una distruzione delle differenze cui il fascismo tradizionale non ha mai avuto i mezzi, la forza e nemmeno l’ambizione o il desiderio di realizzare. Al vecchio fascismo importava che la gente ubbidisse, che piegasse la testa e si comportasse così e così.
Sotto la casacca o la camicia nera tutto era rimasto intatto, com’era stato nei secoli dei secoli. Il nuovo fascismo totalizzante, invece, si intrufola nella camera da letto, vuole condurre il gioco anche sotto le coperte; si aggira nella cucina, vuole suggerire le ricette, vuole farci credere di scegliere quello che amiamo e desideriamo, quello che ci piace bere e mangiare, ma poi è sempre lui a decidere, anche quando – soprattutto quando – ci invita a scegliere, quando ci fa credere che l’ultima parola tocca a noi. E invece l’ultima parola tocca sempre a lui, la parola tocca sempre a lui. Perché ormai, dice Pasolini, non si è più capaci di inventare, si è caduti in una specie di nevrosi afasica; o si parla una lingua finta, che non conosce difficoltà e resistenze, come se tutto fosse facilmente parlabile – ci si esprime come nei libri stampati. E a stampare i libri sono loro.
Nella lingua morta dei libri stampati tutti gli uomini finiscono per assomigliarsi, per diventare uguali. La matrice, scrive Pasolini, diventa un pessimo italianuccio tecnicizzato e scolastico, il quale va a rimpiazzare, a debellare, ad annichilire una parlata precedente che aveva conservato un inalterato idioma puramente orale, antico – si direbbe – come la terra [270]. Una parlata locale che a mala pena resiste come relitto e vergogna.
Tra le altre tragedie che ho vissuto in questi ultimi anni, dice Pasolini [226], c’è stata anche la tragedia della perdita del dialetto, come uno dei momenti più dolorosi della perdita della realtà.
La nuova lingua pilota, una lingua morta, una lingua della propaganda e della televisione, una lingua tecno-scientifica, non ha presa sulla realtà.
Una cultura povera (agricola, feudale, dialettale), dice Pasolini, razzola nel proprio cortile, si articola poveramente, ma secondo l’infinita complessità dell’esistere. Quando questo mondo viene investito da una cultura dominante, va in crisi. E la crisi può risolversi anche in un giudizio sul proprio modo di vita, che può giungere fino all’abiura del dialetto, abiura tipica degli emigrati meridionali. Una crisi che si risolve in un annichilimento e umiliazione del dialetto, che pur restando intatto, dice Pasolini, non è più un modo di essere e un valore. Il dialetto è ancora pieno di denari che però non si possono più spendere. Il dialetto è come la mammella di una madre a cui tutti hanno succhiato, e ora ci sputano sopra (l’abiura!). Ciò che non può essere (ancora) rubato è il corpo, con le sue corde vocali, la voce, al pronuncia, la mimica.
Quando un estraneo si insinua tra la mammella della madre e la bocca del figlio, quando qualcosa si interpone, e comincia a mediare il travaso dalla madre al figlio, il dialetto si svaluta, diventa una moneta che non può essere più spesa su alcun mercato. La matrice stampa ormai solo moneta falsa, e se è ancora moneta sonante, non vale più niente, è come quella valuta del terzo mondo che può scambiarsi solo con se stessa, e mai con valute dominanti – il dollaro, per esempio.
Fino a pochi anni fa, dice Pasolini [203], i poveri tra i poveri, i più poveri dei poveri, tanto più puri quanto appunto più poveri, questi poveri venivano chiamati, allora, sottoproletari. Erano portatori di vecchie culture particolari (per lo più regionali). Erano i parlanti per definizione di lingue autonome, che solo essi conoscevano nello spirito ed erano in grado di ricreare, attraverso una continua rigenerazione (senza infrazioni). Chi viveva in queste riserve era povero ma assolutamente libero.
Al cospetto del sottoproletario, o del borgataro, o del calabrese, il proletario, l’operaio-massa sindacalizzato del triangolo industriale, appariva a Pasolini come totalmente assorbito dal Potere.
Il più povero tra i poveri, invece, benché non fosse padrone di nulla, nemmeno della sua forza-lavoro, nella sua lingua, nel suo contatto con la realtà, era ancora libero di chiamare le cose con il proprio nome. La cultura non si era pervertita, il legame con il mondo più prossimo non era ancora mediato da una lingua veicolare. La riserva lo aveva preservato da ogni contatto con gli estranei. Il sottoproletario non poteva vedere le limitazioni che un’altra cultura gli imponeva per la semplice ragione che non conosceva quest’altra cultura (la percepiva solo come una cosa estranea, incommensurabile con la propria). Ma non c’era nessun transito, nessuna traduzione, e dunque nessun tradimento. Perché è di questo che si parla, di abiura e tradimento. Le pene di questa sinistra italiana romantica e regressiva ruotano tutte intorno all’abiura e al tradimento, se non alla traduzione – ma è la stessa identica cosa.
A differenza dei proletari, i quali avevano tra-dotto i propri desideri e speranze nella nuova lingua veicolare, abiurando il dialetto, i sottoproletari, scrive Pasolini [204], si erano conservati perfettamente estranei alla storia borghese. I più poveri tra i poveri – gli orfani, i figli abbandonati ecc. – tutti coloro che la nascita oppure la prima infanzia aveva segnato, si collocavano ai margini. Diventavano banditi, delinquenti. Oppure semplici miserabili. Da qui un certo fascino per il mariuolo che ha sedotto schiere di studenti figli di impiegati statali insegnanti medici condotti craxiani, facendoli partecipare, per interposta persona, ad un mondo supposto originario, orgiastico, polimorfo, e a questi mariuoli far credere di essere investiti e nobilitati da una attenzione così esagerata manco le loro gesta fossero degne di reverenza episcopale.
Poi sono arrivate l’emigrazione e la televisione, e il recinto che preservava il dialetto e la vita agreste ad esso annessa, sono stati spazzati via. I poveri, continua Pasolini, si sono trovati di colpo senza la propria cultura, senza più la propria lingua, senza la propria libertà, e senza i modelli la cui realizzazione rappresentava la realtà della vita su questa terra.
Poiché i ragazzi più poveri dei poveri sono randagi e non hanno un focolare domestico, gli torna, è ovvio, molto comoda la vita protestataria, e dunque ne assumono atteggiamenti che divengono subito inautentici [e qui torna a imporsi il gergo esistenzialista]. I capelli lunghi, la rabbia, la droga, l’imitazione di lingue altrui, per questi giovani, dice Pasolini, sono miseramente mimetici. Sono utenti di una prossemica e di una lingua imparata a memoria, capace di rendere tecnicamente parlabile tutto, staccata da ogni legame con la vita pratica e immediata. Giovani persi, stretti nella morsa di Russia e America (oggi si direbbe di Cina e Nulla). Persi come i loro adulatori, raccolti in Potere Operaio e Lotta Continua, [SC, 196], giornali che offrono un misto di scrittura paradossale e scandalistica di carattere marinettiano e di scrittura sociologica anglo-americana, ma che alla fin fine adottano il modo di parlare della televisione e del più banale giornalismo dei bollettini parrocchiali.
Caro Calvino, scrive Pasolini su Paese Sera, l’8 Luglio del 1974 [SC 64], Maurizio Ferrara scrive sull’Unità che io rimpiango un’Età dell’oro, tu dici che rimpiango l’Italietta: tutti dicono che rimpiango qualcosa, facendo di questo rimpianto un valore negativo e quindi un facile bersaglio.
Ciò che io rimpiango non è un’italietta provinciale e volgare, ai margini della storia. Ciò che io ripiango, se di rimpianto si può parlare, è il mondo contadino e sottoproletario. Fino a pochi decenni fa questo, in Italia, era il mondo pre-borghese, il mondo della classe dominata. Al di fuori di questa semplice formalità, tale mondo non coincideva affatto con l’Italia.
L’universo contadino, continua Pasolini, è transazionale: addirittura non riconosce le nazioni. Esso è l’avanzo di una civiltà precedente (o di un cumulo di civiltà precedenti tutte molto analoghe fra loro), e la classe dominante (nazionalista) modellava tale avanzo secondo i propri interessi e i propri fini (per un lucano la nazione a lui estranea è stata prima il Regno Borbonico, poi l’Italia piemontese, poi l’Italia fascista, poi l’Italia attuale: senza soluzione di continuità). È questo illimitato mondo contadino pre-nazionale e preindustriale, sopravvissuto solo fino a pochi anni fa, che io rimpiango (non per nulla dimoro il più a lungo possibile nei paesi del Terzo Mondo, dove esso sopravvive ancora, benché il Terzo Mondo sia anch’esso entrato nell’orbita del cosiddetto Sviluppo).
L’acculturazione del Centro consumistico, dice Pasolini, ha distrutto le varie culture del Terzo Mondo (cui le culture contadine italiane sono profondamente analoghe): il modello culturale offerto agli italiani (e a tutti gli uomini del globo, del resto) è unico. La conformazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto, nell’esistenziale: e quindi nel corpo e nel comportamento. Dal punto di vista del linguaggio verbale, si ha la riduzione di tutta la lingua a lingua comunicativa, con un enorme impoverimento dell’espressività. I dialetti (gli idiomi materni!) sono allontanati nel tempo e nello spazio: i figli sono costretti a non parlarli più perché vivono a Torino, Milano o in Germania. Là dove si parlano ancora, hanno totalmente perso ogni potenzialità inventiva. Oggi un giovane fascista non può più essere distinto da tutti gli altri giovani. Mi riferisco a questo quando parlo di omologazione. Oggi (e qui cade la mutazione antropologica, la disumanizzazione) gli uomini sono conformisti e tutti uguali uno all’altro secondo un codice interclassista.
L’omologazione riguarda tutti – scrive Pasolini [53]: popolo e borghesia, operai e sottoproletari. Non voglio fare profezie: ma non nascondo che sono disperatamente pessimista. [72]
La matrice che genera tutti gli italiani è ormai al stessa. Non c’è più differenza. [53]
Nel comportamento quotidiano, psicologicamente e, quel che è più impressionante, fisicamente, gli italiani sono tutti intercambiabili. Nel comportamento quotidiano, mimico, somatico non c’è niente che distingua un fascista da un antifascista. Per quel che riguarda gli estremisti, l’omologazione è ancor più radicale.
In queste considerazioni conclusive Pasolini approfitta dell’ambiguità della parola matrice per suggerire una sostituzione, un passaggio, una traduzione, dalla matrix – cioè dall’utero -, allo stampo, al cliché, alla matrice, appunto.
La madre supposta naturale, la quale (sempre in modo supposto naturale) attraverso la mammella trasmette al figlio l’idioma (la madrelingua), in maniera del tutto idiomatica, ovvero intraducibile, viene sostituita (surrogata) dalla madre-stampo, la quale trasmette l’idioma ad ognuno dei suoi figli, non in modo idiomatico, diretto, immediato, intraducibile. In questa sostituzione della matrix con la matrice – dell’utero supposto naturale, con l’utero surrogato – si realizza l’omologazione. L’omologazione è sempre il passaggio dalla natura alla cultura (dalla vita alla macchina, dalla voce al calcolo, dalla vita alla morte), dalla vita che trapassa ad altra vita attraverso e tramite il vivo, e dalla vita che trapassa e si traduce attraverso lo stampo, la matrice, la macchina da scrive, il morto. La paura è sempre quella di essere tradotti, di essere replicati, di essere stampati in serie. L’incubo è la mappatura del DNA (la matrice matematica) e la replica in provetta, di cui la clonazione è un antesignano rudimentale. Lo spaesamento è legato alla paura della perdita della propria unicità – si potrebbe dire della propria identità, se l’uso di questo termine con contrabbandasse già una certa iterabilità.
Rimane da chiedere se è mai possibile una idiomaticità (una intraducibilità) al di là di ogni iterazione.
Pasolini non pone mai esplicitamente questo problema, ci si imbatte, per esempio, in un intervento su Camon degli anni Settanta, ma non lo tematizza mai, nemmeno per sbaglio. La sua ossessione rimane la traduzione, il calcolo, la matrice matematica, lo stampo; la sua ossessione rimane l’ex-appropriazione del materno (del sacro), che nel suo testo assume le facce del ladro, del contadino, del Terzo Mondo, dell’accattone, del mariuolo, del bifolco meridionale. E nemmeno quando Camon rinviene traslate (se non tradotte) nella lingua o nel dialetto di un suo parente contadino tutte le figure, se non i concetti, di una cultura della quale Camon riproduce la matrice, Pasolini non vede, non sente, rimane colpito da quella stessa afasicità che rimprovera alla società dei consumi.
La lettera del contadino a Camon, scrive Pasolini [270], è straordinaria, di una bellezza e espressività che colpisce per la sua intraducibilità. E colpisce tanto più, quanto più è intraducibile. Ha la forza di quelle mosse o di quelle iniziative (anche politiche) o di quelle azioni che vengono intraprese “non perché sia venuto il momento, ma piuttosto per creare la possibilità di tale momento”[Scritti corsari, 117]. Il cuore di Pasolini, la sua generosità, la sua apertura all’avvenire, è tutta in questa sentenza. Non si agisce veramente (anzi, non si agisce per niente, soprattutto politicamente), quando si agisce perché è venuto il momento. Quando il momento si è già affacciato, quando il problema è all’ordine del giorno, quando tutto è calcolabile e programmabile (che il programma sia un piano quinquennale alla Sovietica, o un piano millenario alla Cinese, non conta), quando tutto è inscritto in una matrice, non c’è vera decisione politica. C’è azione politica quando il tema dell’azione è la possibilità stessa – la possibilità della possibilità. Esigenza idiomatica, esigenza di un performativo puro, di un’azione che non sia generata. Esigenza di auto-nomia e di auto-glossia, sino alla messa in gioco della propria vita.
Non è qui il caso di mostrare come il richiamo di Pasolini al dialetto, alla terra, all’idioma e, se non al sangue, perlomeno al latte e alla madre (che surroga il padre) abbia una certa parentela con il vitalismo e il biologismo otto-novecentesco. Non rimane che rimandare qui ai testi politici di Heidegger, dove questo tema è affrontato in modo diretto, e con la minuzia che richiede e che è tipica di Heidegger. È sufficiente riportare brevemente ciò che Heidegger scrive della traduzione e della lingua (dialetto compreso).
Considerato dal di fuori, ovvero in termini tecnico-filologici, si ritiene, dice Heidegger, che il tradurre sia la trasposizione di una lingua in un’altra, della lingua straniera nella lingua madre o viceversa. [Parmenide]
Ma le cose non sono così semplici – dice Heidegger.
Non ci accorgiamo che, costantemente, traduciamo già anche la nostra stessa lingua, la lingua madre, nella parola che le è propria. Parlare e dire, continua Heidegger a pagina 48, sono in sé un tradurre, la cui essenza non può esaurirsi nel fatto che la parola da tradurre e la parola tradotta appartengono a lingue diverse.
Queste considerazioni di Heidegger sulla lingua materna sono sorprendenti e spaesanti – Unheimliche.
La traduzione – considerata dall’esterno e in maniera tecnica – è la trasposizione della lingua straniera nella lingua madre.
Il tradurre, in senso tecnico, consisterebbe nel far cambiare di posto alle lingue. La traduzione sarebbe un mezzo di trasporto, uno strumento tecnico, appunto [da qui una certa avversione per la traduzione].
In senso proprio, la traduzione – ma già ci si accorge che questo termine non va più bene – avviene, preventivamente, già all’interno della lingua madre, tra la lingua madre e se stessa, e tra la lingua straniera e se stessa. Come se la lingua madre, per essere intesa da chi la possiede, avesse bisogno di una traduzione preventiva. Il che equivale a dire che la lingua madre non si possiede in proprio, che per essere intesa necessita sempre di una traduzione, di un passaggio.
Questa dottrina della lingua madre è fortemente spaesante.
Nella traduzione ne va della stessa identità psicologia dell’individuo. Io – quando dico e intendo proprio «io» – sono già, preventivamente, una traduzione. E siccome una traduzione è la trasposizione di una lingua straniera in una lingua madre, io sono già preventivamente abitato dallo straniero, invaso dallo straniero. La proprietà del proprio, ciò che vi è di più intimo, è infestata dallo straniero.
Io sono una traduzione.
In ogni colloquio e soliloquio – scrive Heidegger – domina un tradurre originario.
Anche quando parlo con me stesso, nella mia lingua madre, sto traducendo. La mia lingua non è la mia.
La traduzione non è un espediente tecnico con il quale si abbelliscono i pensieri, o con il quale li si mette a punto, li si raffina o precisa, eccetera.
Con traduzione, dice Heidegger, non va inteso il procedimento con il quale si sostituisce una locuzione con un’altra della medesima lingua, servendosi di perifrasi.
La scelta delle parole, il cambiamento di una parola con un’altra, è preceduto da una traduzione (űbersetzen). Heidegger sottolinea il tra di traduzione.
Questo tradurre può avvenire senza che l’espressione linguistica muti.
Ricapitolando. La parola è già sempre una parola tradotta. L’inizio della parola – la parola iniziale – è già una parola che viene dopo, una parola tra-dotta. Dunque, la lingua madre è una seconda lingua. Il che equivale a dire che non c’è propriamente madrelingua – muttersprache.
La poesia di un poeta, la trattazione di un pensatore, aggiunge Heidegger, stanno nella loro parola propria, che è unica e singolare. Esse ci costringono a percepire sempre tale parola come se la udissimo la prima volta.
Abbiamo necessita di tradurre la parola del pensatore o del poeta, perché la parola da essi pronunciata è unica e singolare.
Come è possibile venire in contatto con una cosa unica e singolare?
E perché la parola profferita dal poeta o dal pensatore è singolare?
La parola è singolare e unica perché esiste, e in quanto esiste si distingue da tutte la altre parole. Due stesse parole sono pur sempre due parole differenti. E la stessa parola, pronunciata ripetutamente, è sempre una parola diversa, e ogni volta richiede che sia tradotta, essendo appunto diversa. Se le parole non fossero diverse, se non fossero cioè uniche e incommensurabili (cioè intraducibili) non ci sarebbe bisogno della traduzione. Se si dà traduzione è perché le parole sono intraducibili. Dunque, non c’è traduzione. La traduzione è piuttosto una trasposizione. Ecco perché la traduzione parola per parola è impossibile – oppure, se è tecnicamente possibile, produce risultati incomprensibili, o perlomeno aleatori.
Il pensiero e la poesia – queste primizie della parola, dice Heidegger – ci traducono ogni volta su una nuova sponda, ci trasportano, fanno transitare, ci fanno errare, ci spaesano.
Il cosiddetto tradurre (űbersetzen) e perifrasare – scrive Heidegger – è sempre solo successivo al tradurre (űbersetzen).
Solo in virtù di questa traduzione originaria, di questa archi-traduzione, possiamo assumerci il compito di tradurre una parola straniera nella nostra madrelingua.
Questa archi-traduzione rimane sempre la cosa più ardua.
La traduzione della parola di un pensatore tedesco nella lingua tedesca, dice Heidegger, è particolarmente ardua, poiché si mantiene qui l’ostinato pregiudizio secondo il quale compendiamo la parola tedesca da sé, dal momento che appartiene senza alcun dubbio alla nostra lingua, mentre, al contrario, nel tradurre una parola greca dobbiamo prima studiare questa lingua straniera.
Questo pregiudizio è basato sull’idea di naturalità e purezza della lingua madre.
Innanzitutto, la lingua madre sarebbe pura. Darebbe un accesso interno, diretto e immediato – e dunque non alterato – al senso. In secondo luogo, la lingua madre sarebbe naturale. Fornirebbe un collegamento certo con il referente. Così intese, la parola profferita nella lingua madre, e la lingua madre stessa, sarebbero autentiche. La parola tradotta e la parola straniera, invece, sarebbero derivate, inautentiche, inappropriate. Sarebbero dei simulacri, sarebbero false, falsa moneta, non coglierebbero il senso pienamente, veramente.
Deriva da ciò la nostalgia per la perdita della lingua madre?
Oppure c’è dell’altro?
Se la lingua madre è essa stessa una traduzione, viene ricevuta come traduzione, da dove proviene allora la nostalgia?
La nostalgia per la perdita o l’espropriazione di una cosa di cui non si è mai stati proprietari.
Oppure la perturbazione – l’unheimlich di Freud – per ciò che attiene al domestico, all’οἶκος, se non anche all’economico, che oggi – più di ieri – assilla non solo i dialetti, ma persino le cosiddette lingue nazionali e gli stessi stati-nazione in ciò che credono di avere di più proprio, ovvero la lingua, è ancora un modo dell’abitare, dell’essere a casa?