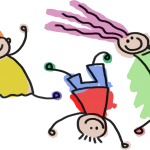Dialettica dell’illuminismo è un libro singolare. La forma piuttosto poco chiara dell’esposizione – dice Habermas (Il discorso filosofico sulla modernità, 1983) – non consente di distinguere a prima vista la netta struttura della linea di pensiero. Nelle sue parti essenziali è nato da appunti presi da Gretel Adorno nel 1944, nel corso di discussioni tra Horkheimer e Adorno a Santa Monica – California. Pubblicato tre anni dopo per Querido-Verlag di Amsterdam è rimasto invenduto per quasi venti anni. Tuttavia, dice Habermas, la sua influenza è stata inversamente proporzionale alle vendite.
Se fossi stato in contatto con la Scuola di Francoforte, dice Foucault (colloquio con Gilles Raulet, Strutturalismo e post-strutturalismo, 1983), se l’avessi conosciuta quando ero studente, non avrei detto un sacco di stupidità che invece ho detto, e avrei potuto evitare molti giri tortuosi che ho fatto cercando di perseguire il mio modesto percorso quando, invece, alcune strade erano state aperte dalla Scuola di Francoforte.
Foucault ha in comune con Horkheimer e Adorno l’interesse per Nietzsche e per Sade, gli scrittori neri della borghesia. Dialettica dell’illuminismo muove proprio da questi autori per elaborare l’auto-distruzione della ragione – dell’Illuminismo.
Guidati dalla speranza dei disperati, Horkheimer e Adorno, nonostante la patente dimostrazione dell’irragionevolezza della ragione, e dunque della vanità del loro tentativo, non vollero tuttavia desistere dal lavoro teorico, divenuto ormai paradossale. E se questo paradosso – continua Habermas – può far pensare a certe uscite del post-strutturalismo, bisogna in ogni modo dimostrare che questa convergenza non c’è.
Invece, qualche assonanza si potrebbe trovare con Heidegger, per esempio con L’epoca dell’immagine del mondo (1938), oppure con Perché i poeti? (1946), contenuti entrambi nella raccolta Sentieri interrotti, testo in cui Heidegger sembra dialogare con Dialettica dell’illuminismo.
Non è la bomba atomica, di cui tanto si parla, a costituire, in quanto ordigno di morte, il mortifero – dice Heidegger. Ciò che da tempo minaccia l’uomo di morte — e di una morte che concerne la sua stessa essenza — è l’incondizionatezza del puro volere, nel senso dell’autoimposizione deliberata e globale. Ciò che minaccia l’uomo nella sua essenza è l’ingannevole convinzione che, attraverso la produzione, la trasformazione, l’accumulazione e il governo delle energie naturali, l’uomo possa rendere agevole a tutti e in genere felice la situazione umana. Ma la pace di questa pacificità è null’altro che l’agitazione ininterrotta della più sfrenata autoimposizione, orientata ormai su se stessa. Ciò che minaccia l’uomo nella sua essenza è la convinzione che la realizzazione della produzione assoluta possa aver luogo senza pericolo alcuno, purché restino in vigore anche altri interessi, ad esempio quelli della fede; come se questo rapporto essenziale in cui l’uomo si è contrapposto al tutto dell’ente in conseguenza del volere tecnico permettesse un soggiorno a sé stante in un luogo adiacente, tale da costituire qualcosa di più della fuga nel mondo delle illusioni (di cui fa parte anche la fuga verso gli Dei della Grecia). Ciò che minaccia l’uomo nella sua essenza è la convinzione che la produzione tecnica metterà in ordine il mondo; mentre, al contrario, questo genere di ordine livella ogni ordo, cioè ogni rango, nella uniformità della produzione, dissolvendo così, sin dall’inizio, la possibile provenienza di ogni rango e di ogni riconoscimento dal fondamento dell’essere.
Non è dunque il carattere totalitario del volere a costituire il pericolo originario, ma il volere stesso nella forma dell’autoimposizione all’interno di un mondo risolto in volontà. Il volere che vuole in base a questa volontà ha già deciso di sé come comando incondizionato. Con questa decisione esso si è rimesso alla organizzazione integrale. Ma è la tecnica a sbarrare prima di ogni altra cosa la comprensione della propria essenza. Difatti, man mano che prende piede, essa sviluppa in seno alle scienze un genere di sapere che è del tutto inidoneo alla comprensione dell’essenza della tecnica, e ancor più a risalire all’origine di questa essenza.
L’essenza della tecnica viene a giorno con estrema lentezza. Questo giorno è la notte del mondo, mistificato in giorno tecnico. Si tratta del giorno più corto di tutti. Con esso si leva la minaccia di un unico interminabile inverno. Frattanto, non solo è tolta all’uomo ogni protezione, ma le tenebre avvolgono l’integrità del tutto dell’ente. Ogni salvezza [Heile] è tolta. Il mondo diviene allora empio [heillos].
Non bisogna affrettarsi a caercare punti in comune tra il contadino di Messkirch, figlio del sacrestano del paese, e il marxista (pentito), figlio di benestanti francofortesi, anche perché Adorno odiava Heidegger – basti considerare Il gergo dell’autenticità (uscito postumo nel 1970) o i giudizi sprezzanti espressi nelle lezioni di filosofia del 1962 (Terminologia filosofica).
Adorno – scrisse Arendt in due lettere a Jaspers del 18 aprile 1966 e del 4 luglio 1966 – è uno degli uomini più ripugnanti che conosco. Mezzo ebreo, aveva sperato di farla franca grazie alla sua discendenza italiana da parte di madre.
Anche l’opinione di Ernst Bloch non è tenera.
In un’intervista per la televisione francese rilasciata a José Marchand nel 1974, Bloch racconta di un giovane Adorno estremamente dotato.
Aveva diciotto anni, disse Bloch, quando, colpito dal mio libro Spirito dell’utopia, si decise a farmi visita a Berlino, dove trascorsi gli ultimi anni Venti. Ci comprendemmo subito ottimamente e diventammo amici. Gli feci conoscere Brecht, il quale fece un gran bene al giovane Adorno che si sentiva marxista. Poi venne il periodo francofortese, che fece emergere quella componente della sua personalità che non disprezzava il compromesso. Rinnegò Brecht, che aveva ammirato sopra ogni altro. Cadde sotto l’influenza dei finanziatori dell’Istituto per la ricerca sociale (Institut für Sozialforschung), che Kracauer chiamava Istituto per la falsificazione sociale (Institut für Sozialfälschung), e si allontanò sempre più dalla sinistra. Benché non si possa dire che si spostasse a destra, non c’era, in ogni caso, più traccia del suo vecchio impeto rivoluzionario, posto che sia mai stato davvero a sinistra. Era pur sempre lui, dice Bloch, ma entro curiosi paludamenti, quelli dello snobismi e dell’esoterismo. La fine, che tutti conoscono, fu che chiamò all’Istituto di Francoforte la polizia, quando venne sfottuto da alcune studentesse abituate a chiamarlo col soprannome Teddy, le quali, in tale occasione, gli si avvicinarono con i seni scoperti mentre era in cattedra. Era fatto così. Amava la bella forma, il lusso, soprattutto i titoli nobiliari, specialmente quando erano le donne a possederli.
Dialettica dell’illuminismo è una presa di distanza dal socialismo reale. Ma prima ancora è una presa di distanza della Rivoluzione francese, dalle sue promesse di liberazione dal mito e dalla superstizione, promesse rappresentate dalle scienze positive dell’Ottocento. Pensatori come Adorno, Heidegger e Foucault – scrive Rorty (Scritti filosofici, 42) – hanno fuso assieme, da un lato, le critiche che Nietzsche ha rivolto alla tradizione metafisica e, dall’altro, le sue critiche alla civiltà borghese, all’amore cristiano e alla speranza del XIX secolo che la scienza avrebbe reso il mondo un luogo dove condurre una vita migliore.
Si tratta di capire se questa presa di distanza abbia allontanato Adorno anche dalla lotta di classe, dall’idea cioè di un’emancipazione dei lavoratori.
La teoria critica, dice Habermas (119), era stata sviluppata dapprima nella cerchia intorno a Horkheimer, per elaborare le delusioni politiche sulla mancata rivoluzione in Occidente, sullo sviluppo stalinista nella Russia sovietica e sulla vittoria del fascismo in Germania. Essa poteva spiegare il fallimento delle previsioni marxiste, senza però rompere con le intenzioni di Marx. Tuttavia, dice Habermas, negli anni più duri della seconda guerra mondiale, l’ultima scintilla di ragione dovette spegnersi, e con essa spegnersi anche la speranza dell’avvento del Regno della libertà. I proletari erano stati definitivamente e irrevocabilmente omologati, insieme al loro rappresentante e bonzo sindacale (Bonzo è un termine che appare proprio in Dialettica dell’illuminismo – Gewerkschaftsbonzen).
L’aumento della produttività economica, si legge nella Premessa alla Prima edizione di Dialettica dell’illuminismo, genera, da un lato, le condizioni di un mondo più giusto, dall’altro lato, fornisce all’apparato tecnico e ai gruppi sociali (sozialen Gruppen*, non classi sociali) che ne dispongono una immensa superiorità sul resto della popolazione. Il singolo, di fronte alle potenze economiche, è ridotto a zero. Mentre il singolo sparisce davanti all’apparato che serve è rifornito da esso meglio di quanto non sia mai stato. Nelle condizioni attuali anche i beni materiali diventano elementi di sventura.
Non si salvano nemmeno i beni immateriali. Poiché l’elevazione del tenore di vita degli inferiori si rispecchia nell’apparente e ipocrita diffusione della cultura. Il cui vero interesse è la negazione della reificazione (Verdinglichung). Lo spirito non può che dileguarsi quando è consolidato a patrimonio culturale e distribuito a fini di consumo. La libertà cui anche il Sessantotto tenderà è costituita da una valanga di informazioni minute e di divertimenti addomesticati che scaltrisce e istupidisce nello stesso tempo.
Se le forze produttive, dice Habermas, entrano in una nefasta simbiosi con quei rapporti di produzione, che un tempo esse dovevano far saltare, allora non vi è più alcuna dinamica in cui la critica potrebbe riporre le proprie speranze. Dunque, ha ragione Bloch nel dire che quella di Adorno fu senz’altro la morte di un uomo che, nato nell’infelicità, finì nell’infelicità. Senza contare su Horkheimer, che nel frattempo era diventato reazionario.
II
Negli anni Venti la disperazione toccò il fondo. L’economicismo della Seconda internazionale, unito al fallimento di ogni tentativo di allargare la rivoluzione a Occidente, tolsero ogni appeal al marxismo ortodosso. Era venuto il tempo di ripensare la teoria da capo a fondo. La lotta di classe non era il motore della storia. Bisognava ripensare tutta l’impostazione della parte prima del primo libro del Capitale. Bisognava dare un calcio definitivo all’economia classica e alla sua metafisica. Bisognava demolire il lavoro come fonte del valore. Bisognava togliere all’operaio la sua centralità orizzontale e verticale. Il lavoro non è il centro di una struttura, la causa basica che determina ogni perturbazione sovrastrutturale. Bisognava rompere la dialettica che si esprime nella triade diacronica lavoro-espropriazione-rivoluzione. Non c’è nessun ripristino delle condizioni originarie, non c’è ritorno verso uno stato adamitico, non c’è nessun regno della libertà che ci attende nel futuro. Non c’è causalità che tenga, non ci sono leggi economiche, nessun meccanicismo, nessuna tendenza, nessuna contraddizione che si risolva in sintesi e liberazione. Non c’è dialettica positiva tra rapporti di produzione e forze produttive, non ci sono Hegel e Feuerbach, non ci sono Marx ed Hilferding, ci sono solo le mani d’acciaio del bisogno che scuotono il bossolo dei casi. Non c’è una storia universale che conduca dal selvaggio all’umanità (Dialettica negativa). Bisogna decidersi a considerare la storia in termini di contingenza anziché di necessità. Bisogna sostituire alla causalità verticale e diacronica una causalità orizzontale e sincronica, ma priva di un centro ordinatore – come il lavoro. Il lavoro è periferico (intravedere in questo declassamento del lavoro la silhouette dell’operaio sociale italiano non è errato). Il lavoro va inteso come un punto luminoso in una costellazione senza dominante. Adorno, dice Jameson (Tardo marxismo, 93), pensa sostanzialmente al passaggio dalla causalità lineare, ancora centrale in Kant, ad una causalità essenzialmente sincronica, che dovrebbe operare più con reti causali che con catene causali.
Le serie causali (Dialettica negativa) si intersecano in ogni fenomeno. Il fenomeno non è determinato univocamente nella serie temporale dalla causalità. L’infinità degli intrecci e degli incroci, dice Adorno, rende impossibile per principio, e non solo praticamente, che si formino catene causali univoche. Lo schema di una causalità univoca imita il semplice rapporto generazionale. Così come, all’inverso, per spiegare quest’ultimo c’è bisogno della causalità. A questo schema unidimensionale della causalità, continua Adorno, appartiene un aspetto feudale, se non uno del codice arcaico di vendetta. C’è una misura del sistema che, come dipendenza universale di tutti i momenti da tutti, supera come obsoleto il tema della causalità. La causa è adesso niente altro che la società stessa. La causalità si è per così dire ritirata nella totalità. All’interno del suo sistema diventa indistinguibile. Il tessuto estremamente fitto della società universalmente socializzata consente di ricondurre con evidenza un determinato stato a un altro solo. Ciascuno di essi è collegato sia orizzontalmente sia verticalmente con tutti, li influenza tutti e da tutti viene influenzato. La dottrina in cui per l’ultima volta l’illuminismo usò la causalità come arma politica decisiva, la dottrina marxista della soprastruttura e della struttura, è arretrata rispetto a una condizione in cui sia gli apparati di produzione, di distribuzione e di dominio, che le relazioni socio-economiche e l’ideologia sono inestricabilmente intrecciati tra loro. Nell’illusione che quel che c’è sarebbe ineludibile e quindi legittimato, che la storia avanzi secondo una legge causale unidimensionale oggettiva, il marxismo, dice Adorno, manca il bersaglio. La critica potrebbe mostrare sulla base di una qualunque sede amministrativa dell’industria e di ogni aeroporto fino a che punto la struttura si è trasformata nella soprastruttura di se stessa.
Questo schema sembra avvicinare moltissimo la Teoria critica a Nietzsche e allo strutturalismo. E invece le cose si complicano, perché Adorno attribuisce questa tendenza al tardo capitalismo. È il capitalismo ad essere strutturalista. Le tendenze della filosofia contemporanea – strutturalismo, post-strutturalismo, esistenzialismo, eccetera – replicano gli interessi dello Stato moderno e del capitalismo monopolistico. La crisi della causalità risulta dalla società contemporanea. Il piano strutturale, la rete, i nodi, il rizoma, eccetera, sono l’espressione filosofica del franchising – prim’ancora che del www. La scomparsa della causalità patriarcale non segnala alcun regno della libertà. Nell’interazione totale si riproduce allargata l’antica dipendenza. Con i suoi milioni di nodi essa impedisce la matura, afferrabile comprensione razionale che il pensiero causale, a servizio del progresso, intendeva promuovere (Dialettica negativa). E nonostante ciò non si può opporre al rizoma alcuna riaffermazione della causalità verticale, non si può regredire verso forme arcaizzanti di causalità. Esse non rappresenterebbero risposte politiche adeguate al tardo capitalismo, sarebbero reazioni suscitate da ciò che vorrebbero togliere di mezzo. Ci si trova invischiati in un doppio vincolo, dove qualsiasi scelta è la scelta sbagliata.
IV
Il capitalismo, così come toglie la causalità verticale tra struttura e sovrastruttura, toglie anche la relazione tra valore d’uso e valore di scambio, tra lavoro e valore. La Critica potrebbe mostrare sulla base di una qualunque negozio Adidas o Apple fino a che punto il valore d’uso si è convertito nel valore di scambio. Il valore d’uso non vale più né come significato né come referente. Diventa significante di un nuovo segno – come nella mitologia di Roland Barthes (si veda a questo proposito anche Jean Baudrillard, L’economia politica del segno). Anche qui bisogna stare attenti a non lasciarsi traviare dal sociologismo americano alla Veblen che trasforma tutto in una critica regressiva dello status symbol. Dietro la critica allo status symbol si nasconde l’idea regressiva che vi sia un valore d’uso intangibile, una natura intatta, al di là o al di fuori del valore di scambio. Non c’è nessuna natura intatta, nessun grado zero del valore d’uso, non c’è alcun uso senza scambio – sia Kant, sia Hegel lo hanno dimostrato in modo abbastanza chiaro.
La particolare originalità di Adorno e Horkheimer di una dialettica dell’illuminismo, dice Jameson (110), consiste nel fatto che essa esclude qualsiasi inizio o termine primo e descrive specificamente l’illuminismo come un processo «sempre già in atto», la cui struttura si trova più precisamente nell’illusione della generazione che ciò che lo precede (che era a sua volta un fenomeno di illuminismo) fosse quell’«originale» momento del mito, l’unione arcaica con la natura, che è vocazione «propria» dell’illuminismo annullare. La separazione tra natura e cultura è un mito illuminista. Di più, la separazione è l’illuminismo. Ci si illumina nella separazione, ci si illumina nella differenza tra natura e cultura – questa differenza deve essere posta (c’è qualcosa di più “originario” della “differenza”). Lo scopo e la funzione dello sciamano, come pure dei filosofi e degli scienziati nella storia più recente, rimangono quelli di controllare la natura (incoraggiando la fertilità, provocando la pioggia, propiziando gli dèi) e occorre anche supporre che le tecniche del sacro possiedono una storia che corrisponde alla più generale dialettica dell’illuminismo (111).
V
La prima parte del Primo libro del Capitale è una meditazione sui misteri dell’identità (Jameson, 32). Come è possibile, si chiede Jameson, quando il consumo (o l’«uso») di qualsiasi oggetto specifico è unico e costituisce anche un evento temporale unico e irripetibile nelle nostre vite, come è possibile che possiamo pensare simili cose come «le stesse»? L’identità non si esprime solo nel concetto di bistecca, automobile, capo di biancheria o libro; cioè nel concetto che pone il genere di diversi e particolari oggetti (il «questo qui»). L’identità si pone anche e soprattutto come l’equivalenza del loro valore, come la possibilità storicamente costruita di confrontare questi oggetti – un’automobile per tanti chili di carne. Quando in termini di esperienza e di consumo – in altre parole di valore d’uso – essi rimangono non comparabili e la speculazione non è in grado di confrontare l’esperienza di mangiare questa particolare bistecca con quella di una scampagnata in automobile. Il valore di scambio, dice Jameson, cioè l’emergere di un terzo termine astratto fra due oggetti non comparabili (astrazione che, tramite la dialettica storica trattata da Marx in questa parte del Capitale, assume la forma del denaro), costituisce dunque la forma primordiale da cui nasce l’identità nella storia dell’umanità.
Questa storia dell’identità nel Capitale prende un’altra piega. Il valore è ricondotto al lavoro socialmente necessario, e il lavoro socialmente necessario alla sua durata media, e la durata media è posta a base della comparazione. In quanto valori le merci sono semplici cristallizzazioni di lavoro umano (Capitale, 82). Facendo di un abito, come cosa di valore, l’equivalente di una tela, il lavoro inerente all’abito viene posto come equivalente al lavoro inerente la tela.
È vero, dice Marx, che il lavoro della sartoria che fa l’abito è un lavoro concreto differente da quello della tessitura che fa la tela. Ma l’equiparazione alla tessitura riduce effettivamente la sartoria a quello che realmente è uguale nei due lavori: al loro carattere comune di lavoro umano. Neppure la tessitura, in quanto tesse valore, possiede note distintive che la differenziano dalla sartoria. Solo l’espressione di equivalenza fra merci di genere differente mette in luce il carattere del lavoro creatore di valore, in quanto riduce effettivamente i diversi lavori impiegati nella produzione di differenti merci, a ciò che è loro comune, lavoro umano in genere. La grandezza di valore non può essere determinata dalla forma-valore.
Che cos’è la forma-valore?
Le Merci, dice Marx (79), vengono al mondo in forma di valori d’uso o corpi. Si tratta della loro forma naturale, casalinga. In quanto corpi, gli oggetti d’uso sono depositari di valore. Il valore depositato nei corpi non è niente di afferrabile con i sensi. Nemmeno un atomo di materiale naturale passa nell’oggettività del valore. Potremmo voltare e rivoltare una singola merce quanto si vuole, ma come cosa di valore rimarrà inafferrabile.
Quando qui si parla di forma naturale non bisogna mai dimenticare che non si parla minimamente di qualcosa di opposto e separato rispetto al mondo culturale o sociale del lavoro. L’oggetto naturale è già una merce. La merce viene al mondo, si presenta con una veste, e queste veste è stata confezionata, non ha nulla di spontaneo, di separato e a se stante. Il valore d’uso è un fenomeno. È ciò che appare al lavoratore che lo produce. Ha una forma, e questa forma gli è impressa dal lavoro. Ma siccome questa forma non ha nulla di materiale, di sensibile, ecco perché, per apparire allo sguardo, per manifestarsi, ha bisogno di imprimersi in un corpo, di incarnarsi in esso. Lo spirito, per apparire, deve farsi corpo e carne. Per converso, la carne non può uscire dall’ombra dell’indistinzione e dal caos che la lega nella confusione alle altre cose, senza che la luce dello spirito la illumini. Si potrebbe dire che l’illuminismo si accende a partire dalla separazione dell’unità primitiva. La differenziazione, in un unico movimento, pone l’illuminino e la natura illuminata.
Quel che si è detto, parlando alla spiccia, all’inizio di questo capitolo, che la merce è valore d’uso e valore di scambio, è – dice Marx (92) – errato, a volersi esprimere con precisione. La merce è (contemporaneamente) valore d’uso (corpo fisico) e valore (corpo spirituale). (Essa è, aggiungo io, corpo mistico). Si presenta come quella duplicità che è, appena il suo valore possiede una forma fenomenica propria differente dalla sua forma naturale, quella del valore di scambio; e non possiede mai questa forma se considerata isolatamente, ma sempre e soltanto nel rapporto di valore o di scambio con una seconda merce, di genere differente. Ma una volta che si sappia ciò, dice Marx, quel modo di parlare non fa danno, serve, per abbreviare.
Quindi, riassumendo, è errato credere che da una parte – isolato e per sé stante – ci sia un valore d’uso, e dall’altra parte – isolato e per sé stante – ci sia un valore di scambio. La merce è duplice – corpo e spirito. Appare in questa duplicità solo se posta nel rapporto con una seconda merce di genere differente. Prima che questa duplicità si esprima e appaia non si può parlare, a rigore, di valore e di valore di scambio. Il valore d’uso, dice Marx (88), diventa forma fenomenica del suo contrario, del valore. E tutto appare dal confronto con un’altra merce, in un piano strutturale, dove il valore che parla nella merce A corrisponde al corpo della merce B, e dove il corpo della merce A corrisponde al valore della merce B.
Che cos’è il fenomeno?
La cosa così come è, a prescindere dalla conoscenza che la conosce, la cosa in sé, non può essere raggiunta. Non si conoscono mai le cose come sono in sé stesse, al di fuori della conoscenza. Ciò che si conosce sono le cose così come appaiono al soggetto che le conosce. Si conoscono solo fenomeni (ciò che appare alla conoscenza). E non possono conoscersi che fenomeni. La conoscenza non può accostarsi ad una cosa evitando di imprimerle una forma. Tutto ciò che viene in contatto con la ragione prende necessariamente la sua forma. Non si può prescindere dal soggetto che conosce, e andare verso le cose stesse. Oppure – ma è la stessa cosa – andare verso le cose stesse, significa apprenderne il fenomeno.
La forma naturale della merce, continua Marx (88), diventa forma di valore. Ma, si noti bene, questo quid pro quo si verifica per una merce B soltanto all’interno del rapporto di valore nel quale una qualsiasi altra merce A entra con essa, e soltanto entro questa relazione. Poiché nessuna merce può riferirsi a se stessa come equivalente, né quindi può fare della sua propria pelle naturale l’espressione del suo proprio valore, essa si deve riferire ad altra merce come equivalente, ossia deve fare della pelle naturale di un’altra merce la propria forma di valore. L’identità non può essere pensata come equivalente di se stessa. L’identità deve essere posta come identità dell’identità e della non-identità.
Un pan di zucchero, poiché è un corpo, è pesante, e quindi ha un peso, ma non si può vedere o toccare il peso di nessun pan di zucchero (89).
Qui ci imbattiamo nel famoso tema kantiano dei 100 talleri, e nella prova ontologica dell’esistenza di Dio. Di questa prova Adorno dice che si tratta, ancora oggi, proprio del centro della riflessione filosofica (Terminologia filosofica, I, 92).
Dal concetto di un essere sommo e assolutamente perfetto (Dio), o dell’ens realissimum, dovrebbe necessariamente derivare che questo essere esiste, poiché il suo concetto contiene anche la sua esistenza. Non c’è bisogno di provare l’esistenza di Dio con l’esperienza (con un prova sintetica aposteriori). La sua esistenza si ricava per analisi dal suo concetto (con una dimostrazione analitica apriori – con una deduzione). Detto terra terra: poiché Dio può tutto, può anche esistere; se non potesse fare tutto, non sarebbe Dio.
L’obiezione di Kant alla dimostrazione si articola intorno alla differenza tra concetto e giudizio.
Noi possiamo esprimere il concetto di una cosa qualsiasi – 100 talleri, ad esempio – e attribuire a questa cosa una serie di proprietà. Tutte queste proprietà si riferiscono sia alla cosa possibile sia alla cosa effettiva (reale). Considerati secondo il concetto, 100 talleri sono sempre 100, o che siano soltanto possibili o che siano anche reali. Detto in soldoni: i 100 talleri che ho in tasca, e i 100 talleri che penso di incassare domani, sono sempre 100, e non 99. L’esistenza non aggiunge niente a (concetto di) 100 talleri.
Nel concetto di 100 talleri non c’è nemmeno un grammo di realtà, di esistenza. Come dice Marx nel Capitale, il valore depositato nei corpi non è niente di afferrabile con i sensi. Nemmeno un atomo di materiale naturale passa nell’oggettività (nel concetto) del valore. Potremmo voltare e rivoltare una singola merce quanto si vuole, ma come cosa di valore rimarrà inafferrabile.
Nell’universale (Hegel, piccola logica §51) non è contenuto il determinato; e il determinato è qui l’essere [realtà effettiva]. Vuol dire che l’essere [realtà effettiva] non si può dedurre e trar fuori per analisi dal concetto. Quel che io penso o immagino non è per questo anche reale – la rappresentazione, o anche il concetto, non basta per esistere.
Posso mettere insieme le caratteristiche di un uomo e di un cavallo e formare nella mente il concetto di un centauro. Ma se tale essere affettivamente esista, dice Adorno (Terminologia), non è una domanda a cui si possa rispondere considerando il concetto, anche se quest’ultimo in se stesso non è affatto problematico o contraddittorio, come sarebbe invece se si parlasse di un ferro di legno. Posso credere di incassare 100 talleri alla scadenza, e questo pensiero può essere corretto e in linea con le aspettative, ma il fatto di pensare l’incasso non garantisce per nulla che l’evento si verifichi.
Il concetto di zucchero, insomma, non è dolce.
VI
Il processo di astrazione può essere banalizzato in due mosse. Si può credere, da un lato, a una molteplicità dispersa, a un contesto naturale inarticolato, a ciò che oggi viene chiamato con allegria e nonchalance La Natura; e, dall’altro, a un soggetto – un Io penso – come termine di unificazione, di identità, di sintesi.
Pensando la Natura in questi termini ci si riferisce, dice Adorno (Terminologia I, 229), al concetto di datità con cui opera la filosofia empirista. Nel concetto dei cosiddetti dati che ci troveremmo di fronte, quale che sia la loro origine, e con cui il nostro pensiero dovrebbe fare qualcosa – questa concezione empirista si ritrova ancora in Kant – , c’è l’idea di una natura diffusa, indipendente da noi, che ci si dà. Quindi, continua Adorno, la natura ci starebbe in primo luogo immediatamente di fronte, e secondo questo approccio noi cercheremmo di darle un ordine. L’espressione «dato» implica in primo luogo che qualcosa non sia stato prodotto da noi, che non provenga dall’unità dello spirito, ma ci sia per così dire gettato in faccia; ma implica anche – in contrasto col principio unificante – il momento della pluralità, della dispersione nello spazio e nel tempo, momento che si contrappone alla sintesi, all’unificazione, o, si potrebbe dire in termini logici, anche e soprattutto al momento dell’identità. Contro il principio di identità – chiude Adorno – questa pluralità di cui si parla qui è dunque il molteplice. D’altro lato il principio superiore è quello che domina la natura, e che in genere viene identificato con lo spirito umano, con l’uomo spogliato delle sue qualità naturali e proprio per questo astratto.
Insomma, da una parte ci sarebbe il molteplice e il fluente, l’apparente, il cangiante, il mutevole, l’empirico, il materico, e , dall’altra parte, il fisso, lo stabile, l’invariante, il sostanziale, il razionale, l’ideale. Da una parte ci sarebbe la natura concreta ed effettiva, e dall’altra l’Io penso astratto, tratto fuori, appunto, da questo mutevole empirico e materico. Da una parte ci sarebbe una mente pura (purificata da ogni tratto empirico) – da una parte ci sarebbe il razionalismo -; mentre dall’altra, contrapposta a questo razionalismo, ci sarebbe una materia molteplice brulicante – ci sarebbe l’empirismo.
In secondo luogo, si banalizza il processo di astrazione pensandolo non come un processo spazio-temporale, ma come tratto fuori (purificato) da ogni interferenza, da ogni movimento, da ogni differenza. Se l’astrazione (l’azione di astrazione) fosse essa stessa ripresa nella materia molteplice e brulicante, non ci sarebbe possibilità alcuna di fissare il concetto. Dunque, non ci sarebbe nessuna natura brulicante. Il brulichio che non si fissa e non si posa, non si dà. L’Io penso e la natura molteplice – l’identità e la differenza – si co-implicano. L’idea di una natura brulicante e in movimento richiede (per essere pensata) proprio un Io penso a-storico e a-topico.
Il fatto sorprendente – dice Adorno (Terminologia, I 219) – è che in genere queste coppie filosofiche (razionalismi-empirismo, idealismo-realismo, eccetera), in ogni caso quelle della filosofia moderna, sono ordinate in coppie antitetiche. All’inizio della filosofia moderna stanno, come estremi opposti, Descartes e Bacone, il primo come fondatore del razionalismo e il secondo dell’empirismo. Dunque, il razionalismo non può essere posto senza che si ponga contemporaneamente l’empirismo. Il fatto è che questo dualismo deve prodursi, non lo si trova bello e fatto, come nei libri di scuola.
In più, dice Adorno, emerge una complicazione già nota a Descartes. Se, per produrre l’astrazione, parto dalla sostanza pensante, secondo l’espressione cartesiana, come posso arrivare a ciò che non è contenuto in questa sostanza, che è diverso da essa, alla realtà? Questo problema è espresso con una nudezza paradigmatica nelle Meditazioni di Cartesio.
VII
L’empirismo va a cercare il vero nell’esperienza, in quel che è presente nella percezione interna e esterna. Nell’empirismo c’è questo gran principio (Hegel, piccola logica, § 38): che ciò che è vero, deve essere nella realtà ed esservi per la percezione. Questo principio è opposto al dover essere [al razionalismo, alla teologia – che deducono da dogmi] col quale la riflessione si gonfia e prende atteggiamenti sprezzanti verso il reale e presente, adducendo un al di là.
L’empirismo, dice Hegel, si limita al finito, all’universo dell’effettività, e perciò nega il sovrasensibile in generale. Si attiene alle cose del mondo, e da queste cose vuole trarre la verità. La verità non è ricevuta, ma cercata nelle cose. Al pensiero è concessa solo l’astrazione, l’universalità e l’identità formale.
Tuttavia, dice Hegel, in questo suo atteggiamento, anche l’empirismo deve cedere al suo contrario, cioè al razionalismo, e accogliere nel suo seno il sovrasensibile. La sua illusione di riferirsi solo al mondo effettivo deve cedere di fronte all’uso di categorie razionali, quali materia e forza, uno, molti, universale, anche d’infinito ecc., e con queste categorie andar sillogizzando, inconsapevole di praticare la metafisica [il razionalismo], e adoperando queste categorie e le loro connessioni in modo del tutto privo di critica e di consapevolezza.
Con i sensi si percepisce il singolare brulichio delle differenza, con essi si percepiscono solo differenti che trapassano gli uni negli altri, non si percepisce mai l’unità, l’identità, la materia, eccetera.
In ciò che si chiama esperienza, dice Hegel §39, che è da distinguere dalla semplice percezione singola di fatti singoli, si trovano due elementi: l’uno, che è la materia per sé isolata e infinitamente varia; l’altro, la forma, i caratteri dell’universalità e della necessità.
L’empiria mostra molte, innumerevoli, percezioni eguali; ma l’universale è qualcosa di affatto diverso dalla gran moltitudine. Ugualmente, l’empiria ci offre percezioni di cambiamenti successivi o di oggetti giustapposti; ma non già una connessione necessaria. Dovendo la percezione restare il fondamento di ciò che vale come verità, l’universalità e la necessità sembrano qualcosa d’ingiustificato, un’accidentalità soggettiva, una semplice abitudine, il cui contenuto può essere costituito così o altrimenti.
Dall’atteggiamento empirista, dice Hegel, deriva un’importante conseguenza: le determinazioni e le leggi [economiche] appaiono come qualcosa di accidentale. Pertanto si deve rinunciare alla loro oggettività e alla loto intima verità. L’empirismo maturo diventa scetticismo. Hume, dice Hegel, pone a fondamento la verità dell’empirico, del sentimento, dell’intuizione; e, muovendo da essa, combatte i principi e le leggi generali, per la ragione che non si giustificano mediante la percezione sensibile.
Ai rischi dello scetticismo risponde la filosofia Critica di Kant.
La filosofia Critica – Hegel §40 – ha in comune con l’empirismo l’accettazione dell’esperienza come unico campo delle conoscenze. Lo spettro della conoscenza empirica non viene da Kant elevato di per sé a verità, ma viene riconosciuto come fenomeno. Kant parte col riconoscere apertamente e col tematizzare esplicitamente (a differenza dell’empirismo che li accoglie a-criticamente) gli elementi che si trovano nell’analisi dell’esperienza, cioè la materia sensibile e le relazioni universali della stessa.
Nella percezione per sé presa è contenuto solo il singolo e solo quello che accade. In più, in ciò che si riconosce e si chiama esperienza (che non è da confondere assolutamente con l’universo dei fatti o col brulichio effettivo dell’esistente) in ciò che si chiama esperienza si ritrovano, come caratteri egualmente essenziali, l’universalità e la necessità. E poiché questi caratteri non derivano dall’empirico in quanto tale, essi appartengono alla spontaneità del pensiero, ossia sono apriori. Necessità e universalità – la legge – si trovano nel pensiero. Ma non nel pensiero di una mente empirica – nella psiche. Se si cercasse la legge nella psiche si ricadrebbe nell’empirismo, e dunque nello scetticismo. La legge, che non è trascendente – che non si trova in un aldilà – è trascendentale – non psicologica, eppure limitata.
Anche in Kant il problema posto da Adorno rimane intatto: Se parto dalla sostanza pensante come posso arrivare a ciò che non è contenuto in questa sostanza, che è diverso da essa, come posso arrivare alla realtà?
Le rappresentazioni date dal sentimento e dall’intuizione sono un molteplice. Questo molteplice della sensazione e dell’intuizione, essendo dall’io riferito a se stesso e riunito in sé come in una coscienza (appercezione pura), viene ridotto così a identità, a una connessione originaria. I modi determinati di questo riferimento, dice Hegel (§42 Unità trascendentale dell’autocoscienza: identità originaria dell’io nel pensiero) – sono i puri concetti dell’intelletto, le categorie.
L’io, l’unità dell’autocoscienza, continua Hegel, è del tutto astratto e pienamente indeterminato: come si può dunque giungere alle determinazioni dell’io, alle categorie? Per buona fortuna, ironizza Hegel, queste categorie si trovano già nella logica comune, empiricamente indicate. I diversi modi del giudizio, già belli e pronti e annoverati.
La ragione pensa l’identità del molteplice. Ragione, dice Hegel §45, si chiama questo astratto io o pensiero, il quale prende a oggetto o scopo la pura identità. Identità priva di determinazioni, alla quale le conoscenze di esperienza sono inadeguate, poiché sono determinate. E quando si assume siffatto incondizionato come l’assoluto e il vero della ragione (come l’idea), le conoscenze dell’esperienza sono dichiarate come il non vero, come apparenze.
La realtà effettiva – l’immediato – si presenta come un’accozzaglia di infinite accidentalità, o come un’accozzaglia di infiniti fini e relazioni di fini – dice Hegel §50. Pensare quest’accozzaglia immediata, significa cancellare da essa le individualità e le accidentalità, e concepirla come un ché di universale, in sé e per sé necessario. Il mondo, dice Hegel, non mostra, in sé come tale, l’universalità, alla quale viene sollevato dal pensiero, questa universalità non viene giustificata dalla rappresentazione empirica del mondo. L’elevazione del pensiero sul sensibile, sul mondo effettivo, il progredire di esso di là dal finito verso l’infinito, il salto che viene fatto, rompendo le serie del sensibile, verso il soprasensibile, tutto ciò è il pensiero stesso; questo trapasso è soltanto pensiero. Dire che questo trapasso non debba essere fatto, è dire che non si debba pensare. In effetti, gli animali non lo fanno – dice Hegel – se ne restano fermi all’apprensione sensibile o all’intuizione: e perciò non hanno alcuna religione.
VIII
Resta il fatto che questo pensiero è il pensiero di qualcuno. Il ricorso all’Io penso, dice Adorno (terminologia I, 222), rinvia ad un io esistente, ad una persona esistente. Se si prende sul serio questa conclusione, ovvero che l’Io penso dell’appercezione rinvia ad un io psicologico (e viceversa), essa significa che ciò che deve essere spiegato, e cioè il mondo reale (effettivo), nello stesso tempo è anche sempre presupposto, sotto specie di persone reali. E così questo concetto dell’Io che dopo tutto è stato astratto dai soggetti empirici, quali siamo noi seduti a queste sedie, in un certo senso fa sempre riferimento a ciò che dovrebbe essere prima costituito attraverso il concetto dell’Io. L’enorme sforzo che poi è stato intrapreso dall’idealismo tedesco in senso stretto, dice Adorno, e cioè dalla filosofia post-kantiana, che è legata soprattutto ai nomi di Fichte, Schelling e Hegel, mira a superare questa difficoltà, e consiste soprattutto nel liberare questo concetto dell’Io trascendentale o dello spirito, che è produzione pura, dal presupposto di questi Io empirici. Ma questa operazione, conclude Adorno, non è mai riuscita loro del tutto, e il tentativo di risolvere interamente nell’Io ogni realtà può essere considerato fallito.
In Hegel questa differenza diventa tematica – dice Adorno (I, 223). Intorno a questa contraddizione ruota tutta la sua filosofia, in particolare la Fenomenologia dello spirito. Hegel ha cercato di fare proprio di questo punto, contro cui sbatte la testa l’idealismo coerente, l’elemento vitale entro cui si muove la speculazione filosofica (ed è proprio per questo che la filosofia hegeliana è geniale, ma nello stesso tempo può sembrare simile a un gioco di prestigio).
Anche nel materialismo di Marx emerge il dualismo tra empirico e razionale. La categoria dello scambio – dice Adorno (I, 224) – in se stessa ha anche carattere concettuale, mentale. Lo scambio degli equivalenti, di valori tra loro uguali, presuppone la possibilità di prescindere dalla determinata qualità che le singole cose o gli oggetti da scambiarsi possiedono come valori d’uso, e che è fondata nella loro immediatezza sensibile. Valore di scambio – scambio in genere – c’è solo, a rigore, se c’è concetto.
Per Kant il concetto è una forma pura del pensiero, rispetto alla quale si dispiega un mondo empirico informe, privo di regole o di leggi. Kant ha visto, dice Adorno, che non ci può essere un’esperienza unitaria, non ci può essere identità, se il pensiero non procede aldilà del puro ordinamento dei suoi dati, ha visto nelle forme, nella misura in cui vanno oltre l’esperienza, delle indicazioni di direzione, delle linee di tendenza, delle regole senza cui non solo non è possibile pensare, ma soprattutto è impossibile un comportamento pratico dotato di senso. Ha indicato queste forme trascendenti come regolative. Quelle che in Kant si chiamano idee in senso pregante sono i principi regolativi della nostra ragione, di cui non possiamo affermare la validità, ma che dobbiamo però esigere, o postulare, affinché sia possibile un’esperienza in se stessa compiuta e unitaria.
A questo proposito Kant deve supporre una separazione delle forme dai contenuti. Questa separazione garantisce di pensare il mondo empirico come totalmente aperto a nuove possibilità, e, contemporaneamente, di basare la conoscenza sul concetto forte di giudizio sintetico (Terminologia I, 272), vale a dire del giudizio in cui il predicato aggiunge qualcosa di novo al concetto del soggetto.
Al contrario, dice Adorno, nell’idealismo assoluto di Hegel non ci può essere a rigore nulla di nuovo. L’idealismo sviluppato con perfetta coerenza (il sistema hegeliano) è un unico, gigantesco giudizio analitico.
Come si arriva ad affermare che non c’è nulla di nuovo, che tutto ciò che accade doveva accadere?
Vi si arriva pensando fino in fondo questa formula: Tutto ciò che è reale è razionale, e tutto ciò che è razionale è reale.
XIX
Il reale è razionale e il razionale è reale. Si tratta di una formula affascinante, ammaliante. Tutti quelli che vi hanno di volta in volta ceduto hanno prodotto risultati sorprendenti. È una formula talmente prossima al positivismo delle scienze, tanto da fornirgli (a sua insaputa) un basamento solido.
L’idealismo coerente, dice Adorno (Terminologia, 275), non tollera nulla al di fuori dello spirito. Nella logica di Kant, in ciò simile alla logica delle scienze positive, i contenuti sono esterni ad essa. Nella logica hegeliana, al contrario, i contenuti non sono sperati dalla forma. Non vi è una logica che afferisce alla forma della ragione, una ragione di fronte alla quale si dispiega una molteplicità naturale priva di ogni ordine. Per Hegel è la realtà stessa ad essere logica, a muoversi secondo uno schema. Questo schema non si riflette semplicemente nella mente di chi la studia o l’osserva – come crede, in modo ingenuo, il positivismo scientifico. L’idealismo hegeliano non tollera nulla fuori di sé, figurarsi una realtà invariante assunta come dato. Siccome è un idealismo assoluto, per conseguire questo primato e ottenere la sua libertà (ab-soluta), non deve dipendere da niente che sia fuori di sé, non deve riferirsi ad altro.
Lo spirito non è niente di personale, di individuale, di soggettivo: non è una parte in cui il tutto si riflette – è il tutto.
Per l’idealismo tutto è spirito – dice Adorno. Ma ciò ha anche la conseguenza che non c’è propriamente nulla di spirituale che sia isolato dalla realtà. Tutta la ricchezza della realtà deve poter essere dedotta dalla spirito, viceversa lo spirito deve essere cercato nella realtà in tutta la sua ricchezza, e solo in essa. Tutto ciò che è, dice Adorno, viene fatto rientrare nel concetto dello spirito come suo momento. La filosofia idealistica non ammette nulla al di fuori dello spirito, perciò essa si rovescia in una forma di realismo. Può nutrirsi di tutto il reale. Ciò implica un’inaudita forza del pensiero, e il pensiero è così immensamente produttivo. Ogni qualvolta cerchiamo di fare filosofia in senso forte, dice Adorno, e cioè vogliamo capire veramente la realtà, ci nutriamo ancora sempre di questo motivo dell’idealismo, secondo cui si tratta di decifrare l’essere, e ciò è veramente e originariamente possibile solo se l’essere stesso viene concepito come espressione dello spirito, in altri termini come dotato di senso.
Poiché il reale è razionale (e viceversa) si aprono le cataratte alle incursioni in tutti i campi possibili (cinema, teatro, spot televisivi, soap opera, telenovelas, telefilm, fiction, telegiornale, calcio, tennis, tornado, installazione, cibo, moda, arredo, barzellette) con lo scopo di mostrare (più che dimostrare – non c’è più niente da dimostrare, se non che tutto ha una logica, che tutto è tenuto insieme dalla logica corrente – la logica del capitalismo, dell’industria, dello strumento, della divisone del lavoro, della finanza, eccetera – persino le quattro dita di topolino hanno una spiegazione logica legata al disegno, alle rotative e ai limiti tecnici di produzione del cartone animato), con lo scopo di mostrare che tutto ha una logica, che nulla succede per caso, che ogni minuta azione, anche all’insaputa di chi la compie, ha un motivo, una spiegazione, si incardina in un ordine complessivo – davvero! La sorpresa che lo spettatore vive quando scopre che Pulp Fiction è Rorty spiegato al cinema e che tutti e due corrispondono alla logica del tardo capitalismo, e che 1) il Tardo capitalismo, 2) Rorty, 3) Pulp fiction e 4) l’Hotel Bonaventura di Los Angeles riproducono la stessa logica, lo sorpresa non ha prezzo.
Il motto di Hegel ha un’ulteriore conseguenza. Siccome il reale è razionale, allora ogni cosa che accade ha un motivo per accadere, ha una ragione che la incardina nella logica hegeliana. Ogni cosa ha il suo posticino nel sistema della logica hegeliana. Non c’è modo di contestare Hegel. Di più, ogni contestazione è parte del sistema, perché per Hegel (altro motto famoso) il Tutto è il vero (il tutto è il falso – obietta Adorno).
Se tutto ciò che accade è vero, è sufficiente lasciar accadere le cose affinché la verità trionfi.
Se posso immergermi nella realtà perché mi è stato garantito a priori che questa realtà è spirito e viene legittimata dall’assoluto che essa stessa è, dice Adorno, ciò implica anche la tendenza latente a convalidare il mondo così come è, ad esaltarlo. Si rinuncia allora in una misura sempre maggiore a intervenire criticamente nel mondo, ci si conforma alla tendenza dominante di questa realtà, poiché questa tendenza, come dice esplicitamente Hegel, non è altro che la tendenza dello stesso spirito del mondo. In termini molto paradossali, si potrebbe dunque dire che proprio l’idealismo interamente coerente ha una particolare affinità con il positivismo, e cioè con la concezione per cui ci si deve attenere ai fatti. Si pretende che non ci sia dubbio che anche la realtà di fatto è spirito; e quindi secondo la stessa impostazione è certo che questo essere appunto come spirito è il positivo, il bene, l’assoluto.
Il razionale è reale e il tutto è il vero trovano la loro apoteosi nella Seconda internazionale, nelle leggi economiche ineluttabili, nella caduta tendenziale del saggio di profitto, nella composizione organica del capitale, eccetera.
Che come reazione a questo storicismo si affermi l’anarcosindacalismo è del tutto giustificato.
A questo punto, conclude Adorno, meglio Kant che Hegel. Nonostante Kant sia più prossimo alle scienze positive, perlomeno lascia aperto uno spiraglio al libero arbitrio. Per Kant la conoscenza non è assoluta identità, dice Adorno, e dunque lascia aperto uno spiraglio al nuovo, a ciò che sarebbe diverso, all’utopia. Gli idealisti coerenti si impadroniscono dell’utopia, la concretizzano e la pensano, ma in questo modo la liquidano. Kant, rinunciando a questa posizione, ha espresso la possibilità di un cambiamento, la possibilità che il mondo diventi diverso da quello che storicamente è.
Gli idealisti coerenti, dice Adorno (Terminologia, 279), a differenza di Kant, insegnano l’unità di teoria e prassi. A questo punto, se vi dico che l’idealismo è un pensiero dell’identità, tutto ciò non deve sorprendere, se dico che per l’idealismo tutto deve essere dedotto da un principio unico, ciò deve, a questo punto, risultare chiaro.
Ogniqualvolta pongo l’identità, affermo anche che il pensiero e l’essere sono la stessa cosa.
Che implicazioni ha tutto ciò?
XIX
Se il razionale è reale, l’identità non si forma per astrazione dalla realtà.
Il lavoro è la fonte del valore non perché si astrae dalle sue qualità particolari e lo si considera come lavoro genericamente umano o come lavoro mediamente necessario o lavoro sociale necessario. L’identità (l’uguaglianza) non si forma per astrazione dalle qualità individuali.
L’astrazione non è un’operazione della logica formale, tale per cui, in teoria, si parte da un concetto astratto di lavoro, da un parametro prefissato, e si commisura la realtà a questo parametro. Non si astrae commisurando il lavoro, fissato nella sua identità astratta, alla durata, fissata anch’essa come durata astratta, generica, senza qualità, vuota. Questo metodo di misurazione deve presupporre come già posto il dato. Qui si tratta invece di arretrare rispetto al dato, e alla divisione presupposta tra pensiero e pensato, tra teoria e prassi. La divisione deve prodursi, non è un dato.
Se l’identità non si produce per astrazione formale – il concetto di Albero non nasce nella testa, dopo aver tolto (astratto, tratto fuori) ai diversi alberi effettivamente esistenti tutte le differenze – se l’identità non si produce per astrazione formale, come si produce?
Se l’astrazione è razionale allora è reale.
Intanto, dice Adorno, bisogna dire che l’astrazione, in Hegel, ha un significato diverso da quello ordinario. Nell’uso linguistico abituale (Terminologia, II, 348) il termine concreto indica ciò che è immediato, che non è ancora passato attraverso il concetto, mentre astratto significa concettuale. Hegel, invece, chiama sempre astratti dei momenti singoli nella misura in cui compaiono senza prendere in considerazione il tutto di cui fanno parte. Concreto è per Hegel il tutto, forse anche per una reminiscenza del significato originario della parola concretum: il tutto è concrescimento.
L’astrazione considera ogni momento singolo, senza tener conto che ogni momento fa parte di un tutto, e che la verità del momento la si trova nel tutto. La melodia di un brano musicale non è una proprietà delle note che lo compongono. Con le stesse note si possono comporre melodie differenti. La melodia emerge dal tutto – non sta in nessuna nota in particolare. Non si ottiene la melodia astraendo dalle differenze che distinguono una nota dall’altra, ma la si ottiene appunto perché le note sono, quando vengono eseguite, l’una differente dall’altra. Questa differenza non sta né nell’una né nell’altra nota, ma non sta nemmeno nella testa di chi ascolta, non si produce per astrazione dalle singole note o dal loro insieme, è immanente all’esecuzione stessa del brano. Nessuna astrazione, di nessun tipo, restituisce la melodia. La melodia (ciò che non si tocca ma si percepisce) è reale. Quando si tocca un oggetto non si tocca mai la forma, si tocca sempre e solo l’oggetto, eppure la forma è lì davanti agli occhi.
Adesso si comincia a capire perché nel Capitale Marx ci tiene a ribadire che la divisione tra valore d’uso e valore di scambio è un errore, un errore che non fa danno, e che serve ad abbreviare.
Ad abbreviare cosa?
XX
La Relazione di scambio, dice Jameson (32), è l’altro grande Leitmotiv che ritorna in tutta l’opera di Adorno, ed è proprio «identico» a quel Leitmotiv più filosofico chiamato «identità».
Adorno non può certo accontentarsi di un empirismo ingenuo, il quale ritiene che l’uguaglianza sia il frutto di una misurazione delle differenti occorrenze, ricondotte e ridotte ad un unica scala di valore. Il problema qui è appunto il valore. Non è sufficiente dire che paramento è il tempo in generale, il tempo dell’orologio, perché il tempo convenzionale dell’orologio rimanda appunto ad una convenzione, e le convenzioni non sono stabili e fisse, appunto perché sono storiche. Qui si tratta di trovare un criterio necessario e universale – a meno che non si voglia cedere allo scetticismo o al relativismo inconcludente. D’altra parte, Adorno non vuole nemmeno cedere ad un razionalismo dogmatico, secondo il quale l’identità è già bella e pronta e annoverata all’Io penso, purificata da ogni inferenza corporale.
L’identità emerge dal rapporto di scambio. Identità e Scambio sono la stessa cosa.
L’identità, dice Jameson, è il termine impiegato da Adorno per definire il concetto marxiano di relazione di scambio. Il risultato di questa adozione (di questa traduzione) è stato quello di aver potentemente generalizzato, in maniera più circostanziata di ogni altro teorico di tradizione marxista, la risonanza e le implicazioni della dottrina del valore di scambio, adattandola agli scopi della filosofia.
Nella Relazione di valore (Capitale I, cap. 1, 91) una merce A viene equiparata ad una merce B. Aristotele, dice Marx, vede che queste merci, differenti quanto ai sensi, è impossibile che siano tra di loro qualitativamente eguali. Se vi è identità tra le due merci differenti è perché esse sono equiparate a qualcosa di estraneo alla loro natura.
L’analisi di Aristotele deve arrestarsi qui. Perché gli manca il concetto di valore – dice Marx.
Che cos’è quell’uguale che, nell’espressione di valore, permette di commisurare una merce A ad una merce B?
Aristotele, dice Marx, dichiara che una cosa del genere non esiste.
E invece esiste – dice Marx
Aristotele non poteva vederla perché la società greca poggiava sul lavoro servile e quindi aveva come base naturale la disuguaglianza degli uomini e delle loro forze-lavoro. L’arcano dell’espressione di valore – dice Marx (Capitale I, cap. 1, 91) -, l’eguaglianza e la validità eguale di tutti i lavori, perché e in quanto sono lavoro umano in genere, può essere decifrato soltanto quando il concetto dell’uguaglianza umana possegga già la solidità di un pregiudizio popolare. Ma ciò è possibile soltanto in una società nella quale la forma merce sia la forma generale del prodotto del lavoro, e quindi anche il rapporto reciproco fra gli uomini come possessori di merci sia il rapporto sociale dominante.
Cosa bisogna intendere per lavoro umano in generale?
Le merci sono equiparabili fra loro – sono identiche le une alle altre – perché sono uguagliabili nella forma di valore. In quanto valori d’uso esse sono tra loro differenti. Al contrario, in quanto hanno la forma di valore, sono tra di loro identiche. Il valore d’uso è la pelle del valore di scambio. Non ci sono due corpi. C’è un solo corpo, e questo corpo incarna la forma di valore: cristallizza lavoro umano astratto. Lavoro astratto poiché si astrae dal carattere determinato, utile e concreto del lavoro contenuto in esso; lavoro umano, poiché qui il lavoro conta solo in quanto dispendio di forza-lavoro umana in generale. Così, mediante il rapporto di valore, il valore di una merce è espresso nel valore d’uso di un’altra merce, cioè in un altro corpo di merce di tipo diverso dal primo.
Che cosa si intende qui per astrazione?
Marx, scrive Adorno (Terminologia II, 409), riconduce tutto al processo di scambio, o piuttosto alla figura dell’astrazione che si ritrova in fondo allo stesso processo di scambio, poiché nello scambio ciò che è qualitativamente diverso viene ridotto a un comune denominatore, alla forma dell’equivalenza. Nella forma di questo processo di astrazione, per cui il diverso viene ridotto a un comune denominatore, il momento soggettivo della riflessione è contenuto nella realtà sociale; la riflessione è presente nella stessa legge oggettiva, materiale, se volete, dello scambio, che secondo Marx domina la realtà.
L’astrattezza dello scambio risiede nella sua universale esecuzione, e non nella riflessione scientifica. Lo scambio prescinde dalla natura qualitativa dei produttori e dei consumatori, dal modo della produzione, persino dal bisogno, che il meccanismo sociale soddisfa solo accidentalmente, come qualcosa di secondario. Primario è il profitto – dice Adorno. Anche l’umanità classificata come clientela – il soggetto dei bisogni – è socialmente preformata al di là di ogni ingenua immaginazione. L’astrattezza del valore di scambio coincide con il dominio dell’universale sul particolare, della società sui suoi membri. Il vero non emerge dal singolo: vero è il tutto.
L’astrazione – commenta Jameson (Tardo marxismo, 51) – è strettamente connessa alla divisione del lavoro. Il capitalismo, in questo senso, diventa il compimento dell’estrema astrazione attraverso il macchinario.
L’astrazione ha a che fare con la macchina.
Bisogna tenere bene in mente che non c’è un terzo. L’astrazione non è l’operazione di un terzo – un denominatore comune, un metro, una bilancia, eccetera. Il rapporto tra A e B non viene stabilito con un metro di misura (con uno strumento). Nel rapporto, A e B diventano strumenti di se stessi, misura di se stessi. Non si può uscire dalla relazione – non si può uscire dal tutto (A e B) e supporre un terzo esterno come metro e misura comune. Hegel vuole mostrare l’operareuna misura interna, una misura che si possa avvalere, per misurare, solo del misurato.
XXI
Per Marx (Claudio Napoleoni, Discorso sull’economia politica, 42) lo scambio è ciò che, attraverso la mediazione delle cose, stabilisce rapporti tra gli individui reciprocamente indifferenti. Questa indifferenza non va intesa come un isolamento che la cosa, una volta indossata la veste della forma valore, verrebbe a togliere (come sembra suggerire Napoleoni). Questa indifferenza è il legame sociale stesso. Il valore – il vero – nasce dalla separazione. Non c’è verità senza separazione.
Il tutto è il vero – il tutto scisso è il vero.
Se l’astrazione è il concetto, e il concetto è il vero, allora il concetto non può che prodursi nella separazione – e mai come processo esterno astraente.
Il luogo in cui la posizione di Marx sullo scambio risulta più evidente, dice Napoleoni (nota 20, 142) è probabilmente nei Lineamenti (I, 97-120). Il presupposto del valore di scambio quale base oggettiva dell’intero sistema di produzione, scrive Marx, implica fin dall’inizio la coercizione per l’individuo. Il suo prodotto immediato non è un prodotto per lui, bensì, lo diventa soltanto nel processo sociale, ed è costretto ad assumere questa forma generale ma estrinseca. L’individuo ha ormai un’esistenza soltanto come entità produttiva di valore di scambio, in ciò è già implicita la negazione totale della sua esistenza naturale.
L’individuo, produttore di valore di scambio, ha già cessato di essere un tutt’uno con la natura. La divisione è già intervenuta. Lo scambio crea la possibilità della divisione del lavoro, e la divisione del lavoro crea la possibilità dello scambio. L’emergere di questa possibilità, che è l’emergere del valore, implica la coercizione, la forza, la negazione, la separazione violenta. Contro questa violenza, Adorno – disperatamente (perché ogni contro-formula hegeliana è ancora una formula hegeliana) – produce la formula inversa: il tutto è il falso.
Quando i lavori dei singoli sono lavori indipendenti – Napoleoni, 42 – occorre che il prodotto sia valore. Nell’economia di scambio il lavoro è reso sociale dall’assunzione della forma di valore da parte del prodotto. I lavori singoli, allora, che come lavori concreti sono diversi l’uno dall’altro, in quanto invece sono produttori di valore, sono tra loro uguali: questa uguaglianza qualitativa è un’astrazione dalle particolarità dei singoli; ma è un’astrazione non nel senso dell’elemento comune che può mentalmente essere colto in una molteplicità, ma nel senso della separazione reale che costituisce questo lavoro astratto in sostanza di valore. La separazione del lavoro creatore di valore dai lavori concreti è ciò che rende generici gli individui, separandoli dalle proprie determinate individualità, ma nello stesso tempo costituendoli in termini di rapporto sociale.
Il discorso di Napoleoni lascia il dubbio di una primaria unità tra individuo e valore d’uso, unità che verrebbe spezzata (separata) dalla trasformazione del bene naturale in merce.
Marx ha chiarito che non c’è valore d’uso senza valore di scambio. Nella divisione del lavoro il valore d’uso, anche quando viene consumato direttamente da chi lo ha prodotto, anche quando rimane invenduto, anche quando viene distrutto, ha una natura mistica, doppia. È corpo e pelle del valore di scambio, è lavoro cristallizzato. L’individuo isolato e il corpo mistico della merce sono contemporanei del rapporto di scambio. L’individuo separato è l’espressione della divisione del lavoro. E la divisione del lavoro è una forma di socialità. La merce non interviene, in un secondo tempo, a unire ciò che è diviso. La merce è divisione. Emerge come divisione.
La separazione del lavoro creatore di valore dai lavori concreti, dice Napoleoni, è ciò che rende generici gli individui, separandoli dalle proprie determinate individualità, ma nello stesso tempo costituendoli in termini di un rapporto sociale.
Nello stesso tempo – contemporaneamente, sullo stesso piano sincronico, dunque per differenza – la separazione dal proprio prodotto rende il genere, il generico, il tipo, il modello, il cliché, lo stampo, la forma, che è la forma stessa di una relazione.
La misura la produce il misurato – non è esterna, non c’è un terzo che misura, non c’è trascendenza.
Cos’è la separazione?
Napoleoni non riesce a rinunciare all’idea della separazione come catastrofe, come decadenza, come cacciata dal paradiso, anche quando pone in modo esplicito e chiaro questo stadio adamitico, antecedente alla separazione, come ipotesi, come finzione.
Il lavoro, dice Napoleoni (43), se fosse pienamente posseduto dal lavoratore [se non ci fosse separazione] sarebbe dotato della sua caratteristica essenziale.
Qual è questa caratteristica essenziale?
Essere lavoro sociale.
La non-separazione è socialità immediata.
Il lavoro se fosse pienamente posseduto dal lavoratore non dovrebbe aspettare di diventare sociale attraverso i suoi prodotti, cioè attraverso lo scambio. Ma siccome il lavoro non è posseduto dal lavoratore, dunque, la socializzazione deve passare attraverso la cosa.
È possibile una socializzazione qualsiasi senza passaggio dalla cosa?
No. Perché la socializzazione (che è già divisione) si illumina a partire dall’alienazione, e l’alienazione si produce come estraneazione. Senza estraneazione non c’è astrazione e costituzione del valore, a meno che non si resusciti il terzo, l’aldilà, magari nella veste dello Stato regolatore – del piano quinquennale.
Il lavoro diventa lavoro generico, dice Napoleoni, solo sulla base dell’espropriazione completa dei produttori, cioè della loro separazione dalle condizioni materiali della produzione, le quali, in virtù di questa separazione, si trasformano in capitale. La separazione pone, da una parte, il capitale, e, dall’altra, il lavoro mercificato. Il capitale non è Laboratorio artigianale, e l’operaio non è Artigiano. Entrambi sono, da una parte, potere generico di mettere all’opera lavoratori, e, dall’altra, offerta generica di manodopera. In ciò consisterebbe la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra servo e padrone.
È in virtù di questa separazione che si compie anche l’inganno – il furto del plus-prodotto.
La separazione non corrisponde a meri rapporti formali o giuridici. La separazione passa attraverso una sussunzione reale.
Di cosa si tratta?
Ogni singolo capitale, dice Napoleoni (46), se unifica sotto di sé un insieme di lavori particolari, non per ciò muta il lavoro particolare in lavoro generale o sociale. Non è il rapporto giuridico, la semplice sussunzione formale, a trasformare il lavoro in valore. Il modo in cui il capitale unifica il lavoro nel processo produttivo è funzione diretta del fine cui la produzione è rivolta, cioè il valore di scambio.
Nella sussunzione reale si va oltre la semplice unificazione di più lavori, che mantengono però la caratteristica di lavoro concreto pre-capitalistico, e si arriva – appunto nelle macchine e nella grande industria – al lavoro astratto vero e proprio. La macchina, dice Napoleoni, incorpora nella propria struttura una conoscenza, che è esterna ed estranea all’operaio; perciò il suo funzionamento non dipende più dall’abilità personale dell’operaio, ma dipende solo dalle leggi incorporate nella macchina stessa.
La sottomissione del lavoro al capitale non si svolge sul piano giuridico o sociale, ma ha il proprio inizio nel processo produttivo, dove ha luogo una sottomissione materiale del lavoro al capitale. La presenza della scienza e della conoscenza all’interno dello strumento è anche la separazione della scienza dall’operaio.
Non siamo lontani da Hegel. L’idealizzazione segue la stessa strada della separazione.
Non ti mangio, dunque ti desidero, ti penso, ti idealizzo.
Mi separo dalla cosa, la lavoro e la trasformo per un uso futuro possibile. La cosa stessa si sdoppia – pur rimanendo la medesima cosa. L’uso possibile la trasforma in valore. Il grano non consumato immediatamente, può diventare nuova semente, può diventare pane, può marcire, può non valere niente e rimanere in magazzino, eccetera. In questa virtualizzazione compare il valore d’uso (possibile). Prima che questa virtualizzazione intervenga non c’è valore d’uso. Il valore d’uso è sempre e solo valore d’uso possibile.
Non è vero, come sostiene Baudrillard, che non ci sono valori d’uso, e che ci sono solo valori di scambio.
Qual è la funzione valore d’uso?
La possibilità deve supporre una fissità – questa unità fissa che si mantiene in tutte le transazioni possibili è il valore d’uso. La fissità è posta dalla possibilità. E non il contrario.
Non è vero che all’origine c’è un valore d’uso che, in un secondo tempo, viene pervertito dal valore di scambio. Non è vero, per dirla in modo più preciso, che all’origine si ha un uso, il quale, in un secondo tempo, veste l’abito del valore (di scambio). A fronte degli usi effettivi immediati, i più disparati, non pensati, c’è un uso mediato, che trasforma gli usi immediati in usi possibili (ma, a rigore, non c’è alcun uso immediato, ciò che dà – precede – l’essere è la possibilità – eppure, per pensare la possibilità, non si può non supporre (pensare), anche qui, l’impensabile: l’immediato).
Non ti mangio, dunque penso alle possibilità di consumo (patata fritta, patata bollita, patata arrosto, purè di patata, eccetera), tutte le possibilità devono supporre una fissità (la patata) anche quando è evidente oltre ogni dubbio, che la patata effettiva non rimane sempre la stessa. A rimanere identica dovrebbe essere la patata pensata, il concetto di patata. Ma come si vedrà, non solo non può darsi concetto senza supporto – e poiché il concetto è attaccato ad un sopporto, si deteriore o altera, segue lo stesso destino del supporto – ma Marx, forzando Hegel, pensa il circolo tra concetto e supporto.
XXII
Nel marzo 1972 Napoleoni tiene due lezioni presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino, dal titolo Lavoro astratto, scambio e capitale in Marx, pubblicate nel 1973 nel libretto Smith, Ricardo, Marx.
Queste lezioni sono importanti perché mettono a fuoco un punto che si può riassumere così. I rapporti immediati sono un bene, al contrario, i rapporti mediati sono un male. Il male si chiama alienazione. Nei rapporti mediati si cerca di superare il male (l’alienazione) con la mediazione di una cosa. La cosa – lo strumento, il mezzo – finisce per prendere il sopravvento sulle persone che l’hanno adottata. Il rapporto si inverte, gli uomini si trasformano in mezzi, e i mezzi in fini. In più, gli uomini assumono tutte le caratteristiche del mezzo. Si tratta di un tema classico del cinematografo, da Tempi moderni a Matrix.
Il lavoro separa l’uomo dall’oggetto di consumo immediato. Il mezzo congiunge ciò che è separato. Anziché essere consumata, la cosa viene usata come mezzo per ottenere una maggiore o migliore quantità di prodotti – pensiamo al seme. Il frutto non viene colto e mangiato immediatamente. Il godimento viene frenato, trattenuto. Nella mani dell’uomo il frutto diventa seme, e le mani stesse diventano mani di contadino. Ma il contadino non è solo colui che si separa dal seme piantandolo nella terra, è anche colui che riesce a pensare la possibilità che il seme si trasformi in pianta e moltiplichi i frutti. Nel seme, il contadino deve prevedere la possibilità del raccolto futuro. Il seme che sta nelle sue mani deve incarnare anche questa possibilità. Siccome la possibilità che il seme si trasformi in frutto può anche non verificarsi, la separazione espone al rischio e al fallimento – il male. La posticipazione del consumo – l’investimento libidico – può andare delusa. Nel rapporto immediato, al contrario, nulla altera la gioia del piacere, perché non c’è nulla che interrompe la continuità tra la cosa e chi la consuma – il desiderio non si forma. Quando il frutto diventa seme, mille e più potranno essere gli accidenti che si frappongono tra il frutto e il suo consumo.
Il seme è il mezzo di un uso possibile. Il seme incarna in sé la possibilità di essere piantato, di marcire prima di essere piantato, di essere piantato e andare distrutto, di moltiplicarsi nei frutti, di diventare semilavorato, prodotto finito, di ridiventare seme, eccetera. Lo stesso seme può significare svariati usi possibili. Il seme non è il fine, è il mezzo per raggiungere il fine. In quanto tale, si fa portatore del fine, portalettere dello scopo. Siccome lo scopo è incarnato in un corpo, e questo fatto non si può eliminare – non si può aspettare il frutto, senza piantare il seme – il seme può andare disperso. Questa possibilità non è un accidente empirico che può essere eliminato con qualche espediente (la pianificazione). Non c’è modo di avere il frutto senza alienare il seme. E non si può alienare il seme senza possibilità di perderlo irrimediabilmente – il male è sempre possibile, questa possibilità non può essere eliminata. Napoleoni, invece, crede che questa possibilità possa e debba essere eliminata. Ma eliminare questa possibilità significa eliminare il lavoro stesso. Il lavoro è la fonte di ogni ricchezza (anzi, la natura è la fonte di ogni ricchezza – Critica al programma di Gotha), e insieme è la fonte del male. Ha un carattere duplice.
È da questa duplicità che prende le mosse l’argomento di Napoleoni.
Stando al primo libro del Capitale, dice Napoleoni (131), il duplice carattere del lavoro è il perno intorno al quale ruota la comprensione dell’economia politica.
Il meglio del mio libro – confessione di Marx a Engels in una lettera del 24 agosto 1967 – il meglio del libro è il doppio carattere del lavoro, a seconda che esso si esprima nell’oggetto d’uso o nel valore di scambio. Nel primo caso è lavoro concreto, nel secondo caso è lavoro astratto. Questa duplicità è alla base della teoria del valore.
Cosa sia il lavoro concreto pare evidente. In ogni caso, Napoleoni non vi dedica una riga. La molteplicità del molteplice non è tematizzata, la si dà per acquisita. E invece bisognerebbe subito mettere in chiaro che la molteplicità si costituisce a partire dalla differenza. Non c’è alcuna molteplicità concreta aldilà della differenza tra identità e molteplicità. In più, bisognerebbe dire, ma qui non c’è spazio sufficiente, che la differenza tra identità e molteplicità (la differenza tra identità e differenza), suppone all’origine – ma qui parlare di origine non ha alcun senso, visto che l’origine e l’originario sono legati all’identità puntuale – suppone una differenza più primitiva della differenza tra identità e molteplicità.
Il lavoro astratto, in Marx, si ricava sia da un’analisi dello scambio, sia da un’analisi del rapporto tra lavoro e capitale.
Per Marx, dice Napoleoni, lo scambio è ciò che, attraverso la mediazione delle cose, stabilisce rapporti tra individui indifferenti. Nel loro lavorare concreto gli uomini sono isolati, il loro rapporto si stabilisce a cose fatte, dopo che il lavoro è stato svolto, mediante appunto lo scambio di prodotti. Il nesso non si stabilisce durante la prestazione del lavoro vivo ed effettivo, ma si stabilisce allo stadio del lavoro morto, una volta che il lavoro è diventato cosa, oggetto d’uso. Tuttavia – qui emerge una complicazione che dovrà essere tematizzata con maggiore precisione – nello scambio, il carattere intrinseco del lavoro umano, ossia l’essere lavoro sociale, è negato, e la società è recuperata fuori dal lavoro, quando il lavoro è ormai solo un oggetto.
Che cos’è il carattere sociale che il mercato negherebbe al lavoro?
Napoleoni non lo spiega direttamente, lo ricava per differenza. Dice esattamente queste parole: Cosicché, a differenza delle società basate sui vincoli di dipendenza personale, la società mercantile è l’universale dipendenza degli individui da un nesso sociale, lo scambio, che si è reso indipendente da loro. Questa indipendenza (a suffragio della tesi Napoleoni cita un passo dei Lineamenti) è superata per mezzo dello scambio. Il legame che unisce i lavoratori tra loro indifferenti si esprime nel valore di scambio. Le attività lavorative concrete, così come gli oggetti d’uso concreto, frutto di queste attività tra loro differenti, posti come valori di scambio, diventano qualcosa di generico, in cui ogni individualità concreta e ogni proprietà concreta sono negate e cancellate. La negazione non è un annichilimento, è un Aufhebung.
Insomma, i lavoratori isolati producono oggetti concreti. Da questi oggetti deve essere negata ogni individualità effettiva. Non devono presentarsi come oggetti legati indissolubilmente al contesto in cui sono apparsi, devono acquisire l’autonomia dal contesto che li ha visti nascere, devono valere fuori contesto. Di più, si valorizzano proprio in quanto sono in grado di funzionare in altri contesti possibili. Devono sciogliere il vincolo della dipendenza personale. Devono valere a prescindere dall’uso possibile in un contesto dato, ed essere trapiantabili in altri contesti.
Per il lavoratore che li produce, questi oggetti d’uso sono oggetti qualsiasi, oggetti generici, esemplari di un genere. Questa genericità è frutto della divisione del lavoro. Più il lavoro è diviso e specializzato; più la mansione è parcellizzata; più le operazioni sono meccanizzate (incorporate nella macchina e nello stampo – divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale) più il prodotto diventa generico. Più il prodotto diventa generico; più competenze sono incorporate nelle macchine e più al lavoratore sono richieste funzioni generiche, mera produzione di forza motrice umana. L’idea generale è incorporata nella macchina, gli usi possibili degli oggetti d’uso sono incorporati nella merce o nel denaro. Il generale, l’universale, l’astratto, si trova dalla parte della cosa, incarnato nella cosa. Il reale è razionale. La misura è interna. Il misurato si auto-misura – non c’è astrazione (nel senso di Hegel). La realtà è misura di se stessa.
Cosa distingue questa realtà parlante, dai fatti – anch’essi parlanti – del positivismo?
A questo livello nulla.
Se a parlare sono i fatti – i dati o i database, come si usa oggi – che ruolo ha nella storia la lotta di classe?
Nessuno.
La storia è uno svolgimento meccanico che, seguendo legge bronzee, parte da un capo e si conclude al capolinea.
L’importanza che negli anni Venti del Novecento assume Hegel per due filosofi marxisti di primo piano – Korsch e Lukács – è legata proprio alla battaglia contro il marxismo positivista della seconda internazionale. Questa battaglia ha due obiettivi principali: 1) il meccanicismo storicista, l’idea che la storia avanzi necessariamente da uno stadio ad un altro secondo leggi deterministiche, e 2) il positivismo scientifico, secondo cui la realtà è un dato positivo inconfutabile, e che l’errore non è un’erranza, bensì un calcolo formalmente scorretto o formalmente corretto, ma non confermato dal dato. A questi due pilastri del positivismo viene opposta la dialettica di Hegel, secondo la quale non c’è teoria, non c’è metodo, non c’è opposizione tra un soggetto teorico e un oggetto della teoria. Non c’è un dato economico che una teoria si presterebbe a rilevare statisticamente. Il dato è teorico tanto quanto la teoria è pratica, e viceversa. La teoria non è un riflesso della realtà, tale per cui la realtà autonomamente andrebbe per la sua strada e la teoria, puntando questa realtà autonoma e indipendente, cercherebbe di fornire un’immagine realistica, e quando ci riesce è vera, quando non ci riesce è falsa (in Hegel, il falso e il vero, così intesi, sono entrambi reali, e in quanto reali sono entrambi effettivi – veri).
I caratteri sociali dei lavori privati, scrive Marx (Capitale, I), appaiono solo nello scambio.
Non si tratta di lavori privati resi sociali, in un secondo tempo, dallo scambio. Lo scambio opera già al livello della separazione dei lavori privati. Lo scambio è contemporaneo della divisione del lavoro. Non ci sarebbe scambio senza divisione del lavoro, e non ci sarebbe divisione del lavoro senza scambio.
I lavori privati, dice Marx, si effettuano di fatto come articolazioni del lavoro complessivo sociale. Ognuno lavora separatamente e autonomamente, ma sempre in vista dello scambio.
Ai produttori, dice Marx, le relazioni sociali dei loro lavori privati non appaiono come rapporti immediatamente sociali fra le persone e i loro stessi lavori, ma appaiono come rapporti di cose, come rapporti sociali fra cose. L’allusione è alla mano invisibile.
Si tratta di un passo del Capitale molto oscuro, che Napoleoni commenta così. Quando il rapporto sociale è lo scambio, i termini rapportati non sono direttamente i lavori delle persone (che così sarebbero immediatamente sociali), ma sono direttamente le cose (che così diventano merci). Mentre le persone sono rapportate tra loro solo mediatamente. Ad esse il legame sociale si presenta perciò come un legame cosale esterno.
Il commento di Napoleoni non è meno oscuro del testo di Marx.
Marx parla di rapporti immediatamente sociali. Cosa intende con ciò?
Immediato, qui, non si riferisce direttamente ai rapporti sociali, a presunti rapporti sociali, i quali avverrebbero senza mediazione, senza scissione e alienazione. E nemmeno si riferisce al fatto che ci sarebbe, a fronte di una comunicazione alienata una comunicazione diretta, senza mediazione, una sorta di telepatia, come si crede che avvenga, per esempio, in quelle comunità – la famiglia, o il contesto amicale – dove domina il rapporto personale, e dove, quando si arriva al Banco per pagare, nessuno, per l’imbarazzo, tira fuori il portafoglio, e a smenarci è sempre il più fesso.
Immediato significa che il legame non si presenta per quello che nei fatti è – ovvero un legame. Ma si presenta come una separazione – un essere privato e isolato – che lo scambio, in seconda battuta, verrebbe a collegare. L’individuo isolato, il Robinson Crusoe, è un mito dell’economia politica (Introduzione del 57). Nei fatti non ci sono individui isolati. Ciò non significa che questi individui non-isolati stiano tra di loro in un nesso di indistinzione, di non separazione, di comunanza o comunione o telepatia. Se si dà nesso sociale, ciò vuol dire che le persone sono separate tra di loro, sono distinte, e che dunque, in qanto distinte, sono mediate nell’alienazione. La separazione e l’unione (differenza e identità) non sono l’uno rispetto all’altra il primo. Non c’è nessun primitivo. Qui c’è dialettica.
Il fatto è che le forme di mediazione non sono tutte uguali. Di questo tema vuole occuparsi Marx. La forma di mediazione capitalistica produce il plusvalore. Questo è il nesso che qui interessa, e non la mediazione o l’immediatezza. Non c’è alternativa tra mediato e immediato. Ma c’è alternativa tra sfruttato e non sfruttato. Perlomeno così crede Marx.
Non ci sono individui isolati. O meglio, gli individui diventano isolati nel modo in cui li conosciamo oggi – come percettori di redditi da stipendi e pensioni -, in virtù della divisione del lavoro e dello scambio generalizzato. Scambio e divisione del lavoro disegnano una struttura economica e determinano un modo singolare di nesso sociale. Al contrario, l’individuo di cui parla l’economia politica precedente a Marx (e anche quella successiva), è un individuo astratto (nel senso di Hegel), è una parte staccata dal tutto e che non rimanda a niente, è l’individuo pensato in quanto depositario originario di bisogni, di desideri, di diritti, eccetera, quando è evidente oltre ogni dubbio che l’individuo isolato che conosciamo oggi, l’individuo libero di spendere il suo reddito come meglio crede e senza dar conto a nessuno, l’individuo che non ha bisogno di mettere al mondo figli in quanto bastoni della vecchiaia, perché per la vecchia c’è l’INPS (quando c’è), che non ha bisogno di curare i genitori, perché ci sono le case di cura, che non deve provvedere ad accumulare provviste e legna per riscaldarsi d’inverno, perché ci sono i supermercati e l’Enelenergia, che non è vincolato da nulla, se non dal potere generico rappresentato nelle carte di credito che tiene in tasca, carte che sono il segno del nuovo nesso sociale e ciò che rende alla vita privata del singolo le comodità dalla divisione del lavoro, divisione del lavoro che è una forma molto elaborata di legame sociale, ebbene, questo individuo isolato non esiste, è frutto di una astrazione, è il dato della scienza positiva, è il record del dabatase. E menarsela con l’individuo isolato e alienato che sta attaccato a internet dalla sera alla mattina è una robinsonata.
Bisogna ribadirlo ancora. Non c’è alternativa tra immediato e mediato.
Hegel ha insegnato che non c’è un immediato che non sia al tempo stesso anche un mediato (Adorno, Metafisica, V). Se la dimostrazione data da Hegel è felice, e non c’è motivo di dubitarne, dice Adorno, allora bisogna chiedersi a cosa ci si riferisce quando si invocano rapporti immediati, quando si presume un accesso immediato ai dati sensibili, primari, eccetera, quando ci si riferisce all’oggetto d’uso come ad un oggetto immediatamente disponibile, eccetera.
Immediato sarebbe ciò che non ha bisogno di nessun’altra cosa per sussistere, immediata sarebbe la realtà effettiva. Mentre mediato sarebbe tutto ciò che, per essere colto, ha bisogno di qualcos’altro, per esempio un mezzo, un medio, un intermediario, uno strumento, una cosa. Pertanto, si chiamerebbero diretti quei rapporti in cui non c’è intermediario, in cui non si intromette la cosa e che non necessitano di un apparato strumentale. Diretto sarà il colloquio faccia a faccia, diretto sarà stringersi la mano, darsi una pacca sulla spalla, scambiare un panino con un bicchiere di vino, mangiare insieme intorno al tavolo, passarsi le vivande, offrire da bere, invitare a pranzo, eccetera. Mentre indiretto sarà comprare un panino, affittare una stanza, salire su un taxi, prendere il treno, scendere dall’autobus, bere il caffè al bar.
Stando ad Hegel, invece, tra queste diverse azioni non c’è differenza – in merito all’immediato e al mediato. Non si tratta nell’un caso di rapporti informali, mentre nell’altro si tratta di rapporti formali. La differenza non passa tra formalità e informalità, tra immediatezza e mediazione, tra rapporto diretto e rapporto mediato – dal denaro, ad esempio. L’esclusività di questi due momenti non è sostenibile. Ognuno implica sempre al tempo stesso anche l’altro o, come si dice in linguaggio hegeliano, questi due momenti sono mediati l’uno dall’altro. Non si dà immediatezza senza mediazione, e viceversa.
Tuttavia, non bisogna pensare il rapporto tra mediato e immediato come un rapporto additivo. Dove il momento formale si imporrebbe al momento, per così dire, effettivo, materiale, reale. Non ci sono da una parte, precostituiti, una intenzione diretta di interazione, e, dall’altra, una formalità pronta a guidare lo scambio. Se proprio li si vuole distinguere, dice Adorno (Metafisica, VII), bisogna riconoscerli come astrazioni che indicano soltanto dei momenti, nessuno dei quali si può pensare indipendentemente dal suo contrario, e ciascuno dei quali, secondo il proprio concetto, ha bisogno dell’altro. L’identità dei due momenti, pensata in questo modo, è un’identità astratta. Sorta da una negazione che è avvenuta fuori di essa, separando il diverso, lasciandolo fuori come prima e sempre (Hegel, Grande Logica II, Identità). I due momenti dovrebbero costituirsi nel rapporto positivo A=A. Ma si tratterebbe, dice Hegel (Logica), di una vuota tautologia. Come se si volessero rapportare – dunque scambiare – 10 euro con 10 euro, oppure un litro di acqua con un litro di acqua. L’esempio non è propriamente calzante, funziona solo se si immagina lo scambio immune dal tempo – dunque se lo si immagina in modo astratto. Il problema è proprio il tempo. Nel tempo, il rapporto non è mai una equivalenza vuota. Nell’equazione 10 euro = 10 euro, i dieci euro futuri (non c’è identità immune dal tempo, il 10=10 è finzione, e si deve ancora cogliere tutta la portata di questa finzione ai fini pratici) sono il contenuto (potere d’acquisto) espresso dai dieci euro nominali attuali, tale che 10 euro attuali-nominali, nominando 10 euro futuri, possono attualizzarsi in 9 euro effettivi (o anche zero euro effettivi) di domani. Quando l’equazione si riempie di contenuto si trasforma in 10=9, ovvero dieci euro attuali nominali corrispondo a dieci euro nominali di domani, che però non avranno il potere di acquisto di dieci euro di oggi, ma avranno il potere di acquisto di 9 euro di domani: identità dell’identità e della non identità – Hegel.
La forma (valore nominale) e il contenuto (potere d’acquisto) non preesistono alla banconota esigibile (effettiva). Non si dà un potere d’acquisto che non sia espresso in un valore nominale, e non si dà valore nominale che non nomini un potere d’acquisto. Il valore nominale – ciò che è fisso, l’invariante -, e il potere d’acquisto – ciò che varia, il molteplice – (la forma e il contenuto, il mediato e l’immediato, l’identità e la differenza) diventano fenomeno (appaiono, si manifestano, diventano reali, effettivi) nella banconota. La banconota è il medio, che non sta tra i due estremi come un terzo separato. È medio perché è forma effettiva, è copro mistico.
Dunque, pensando l’immediato come identità a sé, pensando l’oggetto d’uso come diverso dal valore di scambio, pensandolo come oggetto immediato e vero, in verità, dice Hegel, non ci si accorge che si dice già che l’identità è un diverso, poiché si dice che l’identità è diversa dalla diversità. Pertanto, bisogna convenire che l’identità, intrinsecamente, nella sua natura, nella sua intimità, consiste nell’esser diversa. La verità è completa, dice Hegel, solo nell’unità dell’identità con la diversità, ed essa consiste solo in questa unità.
Tuttavia, bisogna ricordarlo ancora, non si tratta di addizionare all’identico il diverso. In verità l’identico è più grande di se stesso. Il diverso non gli passa accanto, non gli sta di fronte o di fianco, il diverso non è il lontano che diventa vicino, l’estraneo che si accoglie in casa propria. Il diverso non è l’estrinseco, non è lo straniero, il diverso è l’identico.
Infine, a proposito del medio o del mezzo o dello strumento, bisogna dire chiaramente, che il mezzo non è un intermediario, non è il terzo posto tra i due – l’identico e il diverso. Intanto, perché non c’è alcun due da intermediare. E poi, soprattutto, perché il medio è ciò in cui si presentano l’identico e il diverso. Tornando all’esempio del denaro, bisogna riconoscere che senza banconota di carta l’identico e il diverso non sono niente, nemmeno idea, nemmeno pensiero, nemmeno possibilità, nemmanco ipotesi, niente. Si spazializzano nella banconota, ma prima della banconota non sono niente. E tuttavia la banconota non è un inizio, non è un’origine, non è un immediato, perché sin da subito, è sdoppiata, e non è un terzo che si pone tra i due – è i due.
L’immediato, l’oggetto d’uso, lo stringersi la mano, l’affetto, cenare insieme, dividere il pane, condividere il vino, eccetera: quando si parla di questi gesti, e questi gesti stessi quando entrano nello spettro dell’attenzione o dell’intenzione, conquistano una forma, la forma concettuale. Quando si parla di oggetto d’uso, dice Adorno (Metafisica, IX), si usa un concetto o si parla di un principio che, secondo il suo senso, indica proprio ciò che non è da parte sua un concetto, ciò che non è un principio; e solo se capiamo questo, dice Adorno, se quindi capiamo che il senso concettuale di un concetto come quello dell’oggetto d’uso è il non-concettuale, allora capiamo al tempo stesso correttamente cosa si intende con questo concetto. Non possiamo parlare di niente se non per mezzo del linguaggio, se non mediato dal linguaggio, ma anche il linguaggio, come un fenomeno tra gli altri, ricade nell’intera realtà, è esso stesso un momento della realtà e non può essere ipostatizzato rispetto ad essa. E ciò si vede nel fatto che – stando nella prigione del linguaggio, potendo però riconoscere questa prigione come tale – si può parlare di un oggetto d’uso assolutamente privo di forma, benché il discorso su un oggetto privo di forma sia già, da parte sua, una forma.
Vi ho esposto questa dialettica, conclude Adorno, perché credo che pensare inizi proprio nel punto che vi ho appena indicato; cioè nel punto in cui non ci si lascia liquidare con spiegazioni concise come questa: la materia come «primo concetto» o «primo principio» è già essa stessa forma, per cui il concetto di una materia senza forma non ha senso – ma si parte da qui per poi proseguire la riflessione. E se vi dovessi indicare sotto questo aspetto la differenza tra il mio modo di pensare e quello positivistico, direi che il pensiero non-positivistico è precisamente quello che non si accontenta della logica già coagulata dell’esclusività che dice: aut-aut, o mediato o immediato, o concetto o puro non-concettuale, ma analizza i fenomeni in modo che tali ovvietà che per il momento vi ho qui spiegato comincino proprio a vacillare.
XXIII
Secondo Hegel non c’è alternativa tra rapporto Mediato e rapporto Immediato. La coppia mediato/immediato appare come mediazione. Non è possibile pensare, immaginare o sognare un rapporto immediato senza contrapporlo ad un rapporto mediato. Questa è la dialettica tra mediato e immediato. La dialettica – la scissione – non è la barra che divide mediato/immediato. La scissione passa all’interno stesso dell’immediato, tale per cui il mediato stesso non è lo stesso: l’immediato è mediato. Che piaccia o no, è così.
Qui tocchiamo un tema classico del dibattito marxista. Prima di avvicinarsi a questo tema non guasta riprendere il discorso di Napoleoni sulla mediazione e l’immediato, visto che il tema è svolto proprio sul filo di questa differenza.
Quando i lavori dei singoli, dice Napoleoni (Smith, Ricardo, Marx, 135), non sono lavori immediatamente sociali, quando sono cioè lavori privati e indipendenti, onde l’onere per la costituzione della società è rimesso per intero alla cosa, al prodotto, occorre che il prodotto, a parte la sua determinazione materiale come oggetto d’uso, sia valore, cioè potere d’acquisto generale o denaro.
Questo testo di Napoleoni dovrebbe chiarire un passo di Marx tratto dai Lineamenti. Il chiarimento (ogni lettura è, per forza di cose, una riscrittura) privilegia una lettura arcaizzante e additiva dell’immediato. Siccome i lavori sono immediatamente sociali, dunque non c’è bisogno che essi siano mediati da qualcos’altro – per esempio dal denaro.
Originariamente, dice Napoleone, il lavoro concresce con le condizioni oggettive della produzione, in un secondo tempo – nel capitalismo – il lavoro si separa da queste condizioni. In un terzo tempo il lavoro si ricongiunge con queste condizioni – siamo sempre in una terna hegeliana.
Il secondo tempo – il tempo medio – non è il tempo della separazione tra capitale e lavoro, è il tempo del lavoro morto. Il medio è il lavoro morto. Il capitalista, dice Marx, è una personificazione del lavoro morto, mentre il lavoro vivo, a fronte del lavoro morto, è lavoro astratto. Ma il lavoro morto non è, come si crede, così morto, visto che è in grado di ricostituire il nesso sociale. Ma qui siamo entrati prematuramente in quella zone speciale dell’ultimo paragrafo del primo capitolo del primo libro del Capitale dove i morti parlano. E invece bisogna soffermarsi sul penultimo capitolo del primo libro, dove Marx spiega bene l’origine di questo stadio intermedio nella storia universale.
In questo capitolo Marx parla di un circolo. Il tema dell’origine, comunque trattata, immette sempre in un circolo: il circolo deve essere tematizzato. Non si può dire – con innocenza – che originariamente il lavoro concresce con le sue condizioni oggettive. Per affermare questa unità è necessario pensare come diviso ciò che darà origine alla divisione.
L’accumulazione del capitale, dice Marx (Capitale, 1**, XIV), presuppone il plusvalore, e il plusvalore presuppone la produzione capitalistica, e questa presuppone a sua volta la presenza di masse di capitale e di forza-lavoro. Tutto questo movimento sembra aggirarsi in un circolo vizioso dal quale riusciamo ad uscire soltanto supponendo un’accumulazione «originaria» («previous accumulation» in A. Smith) precedente l’accumulazione capitalistica: una accumulazione che non è risultato, ma il punto di partenza del modo di produzione capitalistico.
Nell’economia politica, continua Marx, quest’accumulazione originaria fa all’incirca la stessa parte del peccato originale nella teologia: Adamo dette un morso alla mela e con ciò il peccato colpì il genere umano.
Il rapporto capitalistico, dice Marx, ha come presupposto la separazione fra i lavoratori e la proprietà delle condizioni di realizzazione del lavoro. La produzione capitalistica, non solo mantiene questa separazione, ma la riproduce su scala sempre crescente. Il processo che crea il rapporto capitalistico non può dunque essere null’altro che il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle proprie condizioni di lavoro, processo che da una parte trasforma in capitale i mezzi sociali di sussistenza e di produzione, dall’altra trasforma i produttori diretti in operai salariati. Dunque, la cosiddetta accumulazione originaria non è altro che il processo storico di separazione del produttore dai mezzi di produzione. Questo processo appare come «originario» perché costituisce la preistoria del capitale e del modo di produzione ad esso corrispondente.
Ma non ha nulla di originario. All’origine non c’era nessuna unità adamitica. Dietro l’operaio c’era il servo della gleba o, tutt’al più, il garzone di bottega. Alla liberazione del servo e del garzone corrispose la spoliazione del servo e del garzone dei propri mezzi di produzione da parte di quelli che diventarono capitalisti. Per datare questo processo, dice Marx, non bisogna andare molto indietro, basta risalire al XVI secolo – al massimo al XIV secolo. Ma, cosa più importante, dice Marx, questi nuovi potentati, i capitalisti industriali, che hanno soppiantato i maestri artigiani delle corporazioni e i signori feudali possessori delle ricchezze, che hanno lottato e soppresso i rivoltanti privilegi feudali, questi cavalieri dell’industria riuscirono a soppiantare i cavalieri della spada soltanto sfruttando avvenimenti dei quali erano del tutto innocenti.
All’origine del capitalismo non c’è alcuna immediatezza. Dunque, l’immediatezza di cui Marx parlava nel passo citato da Napoleoni non si riferisce a rapporti pre-capitalistici, e non si riferisce nemmeno ad un incorrotto stato adamitico.
Per trovare invece l’immediatezza a cui si riferisce Napoleoni bisogna andare molto (molto) più indietro – e non è ancora detto che questo arretramento sia sufficiente. Dato che ogni arretramento si involve in un cattivo infinito.
Nell’Introduzione del 57 Marx parla dell’immediatezza di produzione e consumo. Viene subito da pensare che questa immediatezza si riferisca al fatto che tra l’atto della produzione e l’atto del consumo non ci sia alcuna scissione, che la persona che produce il prodotto, ad esempio il contadino, sia nelle condizioni di consumare direttamente il suo prodotto e con ciò soddisfare il suo bisogno, senza che debba prima trasformare il prodotto in merce per scambiarlo con un altro prodotto, posseduto da un altro, e capace di soddisfare il suo bisogno. Che dunque il suo prodotto non vali per lui il prodotto contro il quale potrà eventualmente scambiarlo.
E invece no.
L’immediatezza cui fa riferimento Marx è proprio l’opposto. La produzione, vuol dire Marx, è mediata dal consumo. La mediazione non passa tra il consumo e la produzione, non è un terzo che traduce i primi due elementi l’uno nell’altro. La mediazione tra consumo e produzione è, per così dire, immediata: l’uno è immediatamente l’altro, oppure, l’uno è se stesso essendo anche l’altro, è se stesso, se è anche l’altro.
L’identità di produzione e consumo, dice Marx, viene ad essere la proposizione di Spinoza: Determinatio est negatio.
In Terminologia filosofica (42) Adorno dice che uno dei concetti centrali della dialettica hegeliana è appunto la negazione determinata. In Tre studi su Hegel (II), dice ancora di più: la negazione determinata è la dialettica.
Con la negazione determinazione la filosofia scende dal piedistallo e si muove verso la realtà effettiva. Ma ciò non significa una regressione all’accertamento dell’esistenza irrelata, e in definitiva al positivismo. È vero che, dice Adorno, quando Hegel divinizza la quintessenza dell’esistente, agisce un segreto impulso positivistico. Ma la forza che dischiude alla conoscenza il singolo determinato è sempre la forza dell’insufficienza della sua mera singolarità. Ciò che esso è, è sempre più di lui stesso. In quanto l’intero è all’opera nel microcosmo del singolo, si può parlare a buon diritto di una ripresa di Leibniz in Hegel, benché per il resto egli si opponga fermamente all’astrattezza della monade.
L’intero è all’opera nel microcosmo del singolo, e il singolo è più di se stesso. Questa svolta verso le cose stesse serve ad Hegel per superare la separazione kantiana tra fenomeno e noumeno.
Kant, dice Adorno, aveva ancorato la filosofia ai giudizi sintetici a priori. Ma i giudizi sintetici a priori sono solcati da una profonda contraddizione. Se fossero a priori nel senso stretto di Kant non avrebbero alcun contenuto, sarebbero forme, proposizioni puramente logiche, tautologie, con cui la conoscenza non aggiungerebbe a se stessa nient’altro, niente di nuovo. Se però sono sintetici, cioè conoscenze sul serio, non semplici autoraddoppiamenti del soggetto, allora hanno bisogno di quei contenuti che Kant voleva bandire dalla loro sfera perché accidentali e soltanto empirici. Come è possibile, a questo punto, far incontrare forma e contenuto? Come si giunge a quella conoscenza di cui pure Kant voleva giustificare la validità? Questo diventa un enigma – dice Adorno. La risposta di Hegel è che forma e contenuto sono per essenza reciprocamente mediati.
Con questo passaggio al contenuto, dice Adorno, viene cassata la separazione fra a priori ed empiria, mantenuta da tutta la tradizione platonico-aristotelica sino a Kant.
In questo superamento gioca un ruolo centrale la negazione determinata.
Nel paragrafo 92 della Piccola Logica, Hegel scrive che tutto ciò che è distinto dalla determinazione è una vuota astrazione.
Che cos’è la determinazione?
In genere si pensa la determinazione come il questo qui, la cosa singolare. Il questo qui non sussiste per sé. È questa cosa qui, in quanto non è quest’altra cosa qui. Nella determinazione è implicita la negazione. La determinazione è negazione – determinatio negatio est – perché nell’atto in cui qualcosa si afferma nella sua individualità essa separa e nega da sé ciò nei cui confronti si differenzia. Ciò che viene escluso, che è il suo negativo, non può essere buttato via come inessenziale. Al contrario, solo includendo nella determinazione della cosa anche ciò che la nega determinatamente si conosce la cosa nella sua verità. La verità non sta nel singolo momento – il questo qui individuale – ma sta nel tutto dei momenti che si implicano vicendevolmente. Qui bisogna stare molto attenti a non pensare la negazione determinata come semplice composizione additiva, sostenendo, ad esempio, che l’individuo singolo è arricchito dalla molteplicità di persone e cose che lo circondano. Non c’è nessun individuo da arricchire al di fuori e prima della negazione determinata, e non c’è nessuna molteplicità di fronte alla singolarità. La molteplicità non sta di fronte, a fianco, o insieme.
Nell’essere determinato, continua Hegel (§92), la determinazione è un limite, è una barriera.
Dove passa questa barriera?
Se si pensa il limite e la barriere come frontiera tra il questo qui e il suo altro (lo straniero), e si ritiene che la verità del questo qui, si trovi in ciò che sta oltre la barriera, la politica conseguente è quella dell’apertura della frontiera. Tenere lontano l’altro sarebbe come volere tenere lontana da sé la verità.
Se invece si pensa la barriera, così come la pensa Hegel, come un limite interno, e non esterno, allora la barriera non è ciò che io posso controllare, e al limite aprire o chiudere, ma è ciò che, essendo costituivo del mio sé, faccio fatica anche solamente a localizzare e fissare, figurarsi a dominare completamente con una decisione – posto che una decisione qualunque sia in grado di abbracciare ciò che fornisce occasione per la sua espressione.
L’essere altro, continua Hegel, non è un momento indifferente fuori dal questo qui effettivamente determinato, ma è un proprio momento, è una parte di se stesso.
Nell’aggiunta al § 92 Hegel chiarisce che il limite è la negazione. Qualcosa è quello che è soltanto nel suo limite e mediante il suo limite.
Il questo qui – il dato della scienza positiva – è sempre e fin da subito mediato. Perciò, dice Hegel, non è lecito considerare il limite come qualcosa di semplicemente esterno all’essere determinato, ma piuttosto il limite è qualcosa che passa attraverso l’intero essere determinato.
L’intera impostazione di Hegel, vincolata alla negazione determinata, sta di traverso al programma dell’immediata assunzione del cosiddetto dato quale base inamovibile della conoscenza. Non ci sono dati. Eppure, dice Adorno, dopo Hegel quel programma è diventato quasi scontato, non solo nel positivismo, ma anche nei suoi autentici avversari, come Bergson e Husserl.
La negazione determinata fornisce a Hegel il tema per riscrivere di sana pianta il concetto di esperienza ereditato dall’empirismo. Nella tradizione di Hume, l’esperienza ha come suo stesso criterio il carattere dell’immediatezza, e precisamente dell’immediatezza per il soggetto. Esperienza significherebbe ciò che c’è immediatamente, che è immediatamente dato, per così dire non contaminato dall’aggiunta del pensiero, e per ciò inoppugnabile. E la verità sarebbe l’apprensione precisa di questo dato. Mentre in Hegel, al contrario, l’esperienza non è mai un dato comunicabile, una conoscenza teorica trasmissibile, ma è sempre la mia esperienza, esperienza nella quale l’io è sempre (e non può essere altrimenti) coinvolto personalmente – da non confondere con una Weltanschauung.
Spesso, dice Hegel, gli uomini considerano superiore l’immediato, e si pensa invece che il mediato sia dipendente. Ma le presunte qualità elementari dell’immediatezza non esistono per sé, compaiono sempre già formate categorialmente, e perciò i momenti sensibili e categoriali non si lasciano distinguere in «strati» con tanta pulizia. Non c’è nulla fra cielo e terra che non sia mediato – stoccata definitiva contro il positivismo. La revoca dell’immediatezza dà conto del fatto che l’immediato, il più prossimo, su cui la coscienza ingenua fa affidamento, oggettivamente non è l’immediato e il primo, come non lo è alcun possesso. Hegel, dice Adorno (Tre studi su Hegel), distrugge la mitologia del primo in quanto tale. Essa si contrappone alla mera teoria della conoscenza, dimostrandole che le sue forme costitutive della conoscenza dipendono dal contenuto conosciuto tanto quanto il contenuto dipende dalle forme. Non c’è, in generale, materia senza forma, né forma senza materia. La materia e la forma si generano a vicenda. Questo anti-empirismo di Hegel ha di mira le scienze positive – frutto della divisione del lavoro – le quali cercavano di sottrarre terreno alla filosofia.
Contro la scienza razionale, dice Adorno, Hegel ha un’obiezione del tutto razionale: la scienza, che si crede la fonte di diritto della verità, per amore dei suoi concetti ordinatori, della sua immanente non contraddittorietà e praticità, manipola gli oggetti, li aggiusta finché non entrano dentro le discipline istituzionali, «positive». Il fatto che la scienza si preoccupi meno della vita delle cose che della loro compatibilità con le sue regole del gioco, motiva il concetto hegeliano di reificazione: ciò che si pone come verità intoccabile e irriducibile è già il prodotto di un trattamento, è secondario e derivato. Il dato viene spacciato come dato immediato. Molto prima che si arrivasse a tanto, Hegel l’ha riconosciuta per ciò che oggi essa si rivela in innumerevoli ricerche vuote e insulse: unità di reificazione – cioè oggettività falsa, esterna alla cosa stessa, in linguaggio hegeliano astratta – e di un’ingenuità che scambia il calco esteriore del mondo, fatti e numeri, con il suo fondamento.
Hegel, dice Adorno, ha sofferto dell’estraniazione fra soggetto e oggetto, fra la coscienza e la realtà, come nessuno prima di lui. Ma la sua filosofia ha avuto la forza di non cercare rifugio da tale sofferenza nella chimera di un mondo e di un soggetto di pura immediatezza. Siccome la mediazione implica la separazione, e la separazione è esporsi all’altro, e questa esposizione affetta nell’intimo, dunque, la mediazione è sofferenza, sofferenza nella reificazione e per la reificazione. Meglio sarebbe ritornare ad uno stadio precedente – o prospettare uno stadio successivo – di unità.
Hegel ha annunciato che la società reificata e razionalizzata dell’età borghese, nella quale la ragione dominatrice della natura è giunta a compimento, potrebbe diventare una società degna dell’uomo, non regredendo a stadi più antichi, più irrazionali, anteriori alla divisione del lavoro, ma applicando a se stessa la sua razionalità: in altre parole, scoprendo – e così guarendo – le macchie dell’irrazionalità fin nella propria ragione, ma anche la traccia della ragione nell’irrazionale.
La capacità di vedere tutto ciò ha protetto Hegel da ogni sentimentalismo, da ogni romanticismo, da ogni fissazione del pensiero e della realtà su stadi del passato
Nell’Introduzione del 57 si ritrova lo stesso schema: la produzione è immediatamente anche consumo.
Cosa vuol dire?
Il consumo, dice Marx, è immediatamente produzione. Nella natura il consumo degli elementi e delle sostanze chimiche è produzione di un nuovo essere: produzione consumatrice. Al che, dice Marx, l’economia politica risponde che in questo caso si tratta solo di un consumo secondario, successivo alla produzione vera e propria, produzione nella quale i due momenti sono separati e autonomi.
La produzione è immediatamente anche consumo, ciascuno momento è anche il suo opposto. Al tempo stesso, tuttavia, tra i due momenti si svolge una mediazione.
La mediazione – lo ribadisco ancora una volta – non è il misurare entrambi i momenti con un metro esteriore. È la produzione stessa che media il consumo, di cui crea il materiale e al quale senza di essa mancherebbe l’oggetto. Ma il consumo – continua Marx – media a sua volta la produzione, in quanto crea ai prodotti il soggetto per il quale essi sono dei prodotti. Il prodotto riceve il suo ultimo finish nel consumo. Una ferrovia sulla quale non si viaggi e che quindi non si logori e non venga consumata, dice Marx, è soltanto un ferrovia in δύναμει, in potenza e non una ferrovia in atto. È una ferrovia possibile, e non una ferrovia effettiva. Per diventare effettiva – vera – la ferrovia deve essere consumata, per consumarsi deve servire allo scopo, deve porsi nella forma richiesta, deve diventare vera. La potenza, il movimento, deve fissarsi e permanere, e permane nel consumo. Nel consumo la ferrovia diventa esperienza di viaggio.
Qui viene tirato in ballo Aristotele.
XXXIIIa
Per Aristotele – Adorno, Metafisica – la vera realtà è la forma. In fondo la realtà è tale solo in quanto è realtà formata – e non il materiale di una tale realtà. La materia, invece, è definita come semplice possibilità, come potenzialità, perché deve avere sempre in sé la possibilità di pervenire a una tale realtà, alla sua forma, alla sua µορϕή. La materia quindi si chiama δύναµις, il che è molto singolare, dice Adorno, perché noi associamo a δύναµις, proprio seguendo il significato della parola greca, il concetto di forza; ma qui δύναµις significa lo stesso che possibilità, quindi non è proprio un elemento statico e immutabile, che si associa al concetto di materia, ma, come indica il nome, è essa stessa un principio dinamico. La forma è propriamente la realtà, l’ἐνέργεια, mentre la materia è la semplice possibilità, la δύναµις. La δύναµις – la materia, la possibilità -, per diventare effettiva (vera) deve formarsi, modellarsi, costituirsi. Non si dà materia senza forma (rimane mera possibilità), e non si da forma senza una materia formata. A tal riguardo, dice Adorno, si potrebbe anche dire che la metafisica di Aristotele è un idealismo non ancora riflesso, ma oggettivo. La mediazione tra forma e materia che deriva da questo concetto di realtà, questa mediazione tra forma e materia non viene veramente sviluppata. Materia e forma sono certo riferite l’una all’altra, ma dall’esterno, attraverso la semplice capacità della materia di divenire qualcosa di diverso da ciò che è; cioè: essa non è insieme sempre anche forma, non è in se stessa mediata dalla forma. In tal modo, ciò che in una dottrina conseguente della mediazione avrebbe bisogno della materia, adesso, nonostante la svolta antiplatonica, viene trasformato di nuovo in un ente-in-sé. Nasce il paradosso per cui la forma, che secondo il proprio concetto può essere solo forma di qualcosa, adesso in Aristotele in definitiva deve essere trasformata nel reale per antonomasia, mentre, partendo dalla stessa immediatezza dogmatica, alla ὕλη si attribuisce ciò che essa riceve solo dalla forma – la pura possibilità è essa stessa una possibilità categoriale, una determinazione formale, un’astrazione in cui c’è un pensiero, una categorizzazione: che qualcosa contenga la possibilità di divenire un’altra cosa, le viene attribuito come se fosse una proprietà prima di ogni determinazione, che deve essere assolutamente immanente alla materia. In Aristotele ciò comporta le più ampie conseguenze per la comprensione del concetto di materia; quelle appunto a cui già si alludeva: che nello sviluppo di questa filosofia la materia non è affatto quell’elemento indeterminato e vuoto che viene introdotto nel senso della logica della sua filosofia, ma essa stessa diviene anche, anzi, proprio ciò da cui egli teneva tanto a distinguerla, cioè una specie di sostanza.
XXXIIIb
Il consumo, dice Marx, produce la produzione in due modi: 1) perché solo nel consumo il prorotto diviene un prodotto effettivo, e 2) perché il consumo crea il bisogno di una nuova produzione e quindi il motivo ideale che è lo stimolo interno della produzione e il suo presupposto. Esso crea anche l’oggetto, che agisce nella produzione determinandone lo scopo. Se è chiaro che la produzione offre esteriormente l’oggetto del consumo, è perciò altrettanto chiaro che il consumo pone idealmente l’oggetto della produzione, come immagine interiore, come bisogno, come impulso e come scopo.
La questione è: come si forma l’immagine, come appare lo scopo, da dove viene la forma che l’oggetto prenderà, se questa forma è nella testa e non proviene da un aldilà? Non si può certo dire che l’immagine venga dall’oggetto, non solo perché, in questo caso, l’oggetto non c’è ancora, ma perché, di principio, e in ogni caso, l’oggetto non è un dato che trasmette immagini di sé.
Bisogna anche dire, continua Marx, che a tutto ciò corrisponde, dal lato della produzione, che 1) la produzione fornisce al consumo la materia, e 2) che essa dà al consumo la sua determinatezza, il suo finish.
Quando il consumo emerge dalla sua immediatezza e dalla sua prima rozzezza naturale, scrive Marx, esso stesso come impulso è mediato dall’oggetto, e il bisogno di quest’ultimo che esso prova è creato dalla percezione dell’oggetto.
In questo preciso punto Marx si riferisce a quell’immediato di cui parla anche Napoleoni. C’è un momento in cui – ma come situare questo momento? È impossibile. Ogni tentativo di situarlo arretra la storia ad un momento precedente. Adorno dice che quando il pensiero arriva a questo limite, a questo imbroglio, esso inizia veramente a pensare, che non si tratta dunque di smascherare questo imbroglio come tale, e giubilarsi della denuncia, ma si tratta di vivere in questo imbroglio, cercando di raccapezzarsi – c’è un momento in cui, dice Marx (bisogna fingere questo momento, fingere un cosiddetto stato naturale – nel Capitale Marx avverte che la distinzione tra valore d’uso e valore di scambio è una finzione necessaria alla comprensione, e che in verità non c’è alcuna divisione tra valore di scambio e valore d’uso, perché il valore d’uso non è il sostrato, ciò che appunto vale, nel valore di scambio, perché il sostrato del valore di scambio, dice Marx, è il lavoro; supporre uno stato originario, primitivo, immediato, serve a fissare il pensiero al di qua dello scetticismo – c’è un memento in cui la scissione tra natura e cultura non è ancora avvenuta, in cui il consumo e la produzione non sono scissi, e dunque non hanno bisogno di mediarsi l’uno con l’altro. Siccome non c’è scissione, allora non c’è nemmeno idealizzazione – posto che l’idealizzazione sia prodotta dalla scissione, e non sia la scissione stessa. Non appena si esce da questo presunto – finto – stato naturale (e in questa stessa Introduzione del 57 Marx critica sia l’economia politica, sia Rousseau, per aver posto – chi più, chi meno – l’origine nella storia: nelle vesti dell’homo oeconomicus o dello stato di natura), ogni impulso è mediato dall’oggetto. Che significa? Significa che da questo momento, dice Marx, ciascuno dei due momenti non soltanto fornisce all’altro il suo oggetto, la produzione l’oggetto esterno del consumo, il consumo l’oggetto rappresentato della produzione; ma ciascuno di essi – oltre ad essere immediatamente l’altro e il mediatore dell’altro – realizzandosi crea l’altro, si realizza come altro.
Nel capitolo Cinque del primo libro del Capitale Marx riprende questo tema, usa ancora la chiave aristotelica, e dice che l’uso della forza-lavoro è il lavoro stesso. Il compratore della forza-lavoro la consuma facendo lavorare il suo venditore. Attraverso tale processo la forza-lavoro diventa actu, mentre prima era solo potentia. Quel che il capitalista fa eseguire all’operaio è un articolo determinato. La potenza – la possibilità – si attualizza in un oggetto d’uso determinato.
Mentre la potenza – la possibilità, il materiale – sta dalla parte della forza-lavoro – l’energia – la forma, l’idea – è fornita dal capitalista (qui si presenta la divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale). L’imprenditore ha l’idea, ma non ha la materia per realizzarla. L’idea rischia di rimanere mero proposito. Al contrario, l’operaio, che non ha l’idea, ha la possibilità di trasformare ogni idea in prodotto finito, in oggetto determinato. Ed è ciò che avviene. La materia – la possibilità – prende forma – idea – e l’oggetto si determina, esiste.
L’esistenza, attraverso la quale l’idea deve passare per diventare vera, è un accidente del quale bisogna liberarsi per ritornare presso di sé arricchiti del travaglio. Insomma, senza questo travaglio l’idea resterebbe vuota di contenuto. Sporcandosi con la materia rischia la tentazione e la perdizione, rischia di cedere al male, di dissolversi, di non ritornare più al luogo superiore di origine. L’esperienza è un arricchimento che richiede movimento. Non siamo dentro il grand tour, dove il figlio del ricco faceva conoscenza del mondo e delle sue ricchezza viaggiando per valli e per monti, rischiando di rompersi il collo prima di ritornare alla casa del padre arricchito del viaggio. E non siamo dentro l’esperienza turistica dei nostri giorni, surrogato del Grand Tour, in cui il turista crede di conoscere il mondo assaggiando la cucina esotica. Si tratta dell’esperienza teologica dell’incarnazione e della resurrezione.
L’oggetto determinato, in sé, non ha alcun valore per il capitalista, l’oggetto d’uso può significare qualsiasi cosa. Per il capitalista esso vale solo se ritorna ad essere idea, idea arricchita dal travaglio dell’esistenza-tolta o superata D-M-D’. L’oggetto d’uso e l’operaio sono il medio, il determinato, l’incarnato partecipe di due mondi. Il denaro – valore puro – si incontra con il lavoro e diventa oggetto effettivo d’uso, ma questo oggetto effettivo d’uso deve essere rimosso, affinché il denaro ritorni maggiorato di un surplus (ROI). Il medio deve essere tolto, perché, come ogni medio, è imperfetto, è limitato, è eterodiretto. Soggetto alla negazione determinata, non è libero, non è assoluto, non è autonomo, eccetera. Il primato dell’anima sul corpo, del pensiero sulla materia, del lavoro intellettuale sul lavoro manuale, nasce proprio con Aristotele, e si perfeziona con l’idealismo.
Quindi solo se ci si immagina che in ogni movimento ciò a cui si tende sia fin dall’inizio e al tempo stesso l’agente del movimento – solo con questa premessa, dice Adorno, è in fondo comprensibile la teoria del movimento di Aristotele. E proprio questa svolta: cioè spiegare in forma spirituale, grazie a una riflessione gnoseologica, questa premessa, e mostrare come ciò che è attivo fin dall’inizio si manifesti poi anche in sé e per sé, è stato in effetti il tentativo della Logica hegeliana, della quale perciò si può dire in un senso molto preciso e rigoroso che abbia cercato di recuperare, per così dire, il programma ontologico della Metafisica aristotelica attraverso un’analisi trascendentale, quindi rivolta in senso soggettivo.
Secondo Aristotele, dice Adorno (Metafisica), ogni movimento presuppone due cose: un motore e un mosso. E, secondo Aristotele, questo vale persino per ciò che muove se stesso. Persino là dove possiamo parlare di qualcosa che muove se stesso, troviamo in esso due diversi elementi o principi: il motore e il mosso. In Aristotele questa dottrina è rivolta all’uomo, si riferisce all’uomo che è l’unico essere semovente – a prescindere dagli animali – di cui in fondo possiamo sapere. E a questo punto – al fatto quindi che l’uomo si divide in due principî: cioè nel principio motore, che è quello superiore, immateriale e spirituale, e nel principio mosso, cioè materiale – a questo risale in fondo (per mostrarvi di nuovo anche qui che tutti parliamo l’aristotelico senza saperlo) l’intera figura del dualismo di corpo e anima, il cosiddetto problema corpo-anima che domina il pensiero occidentale e che è poi divenuto esplicitamente tematico nel razionalismo del XVII secolo a partire da Descartes. Tutto il successivo dualismo di sostanze tra corpo e anima, nonché tutta la questione del rapporto reciproco tra questi momenti dualistici di corpo e anima, in fondo è stato formulato come problema per la prima volta e con ogni precisione in questa, come dire, antropologia ontologica che scompone l’uomo stesso in un principio motore e in uno mosso o materiale. Il principio motore è anche quello in atto o la forma, e il mosso è anche quello in potenza o la materia. La forma, quindi la ἐνέργεια, non fa che indurre la materia – nonostante i momenti di resistenza che vi sono contenuti – a muoversi verso di essa.
Ma Marx segue un’altra strada. Anche se all’inizio sembra incamminarsi sullo stesso sentiero tracciato da Aristotele, quello di un privilegio e di un ritorno all’immediato (anima) togliendo il mediato (il copro).
Il prodotto frutto del travaglio del lavoratore è un oggetto d’uso. Ma benché questo oggetto costituisca la base del progresso sociale e, dice Marx, il capitalista sia un deciso progressista, egli non fabbrica il prodotto per amore del prodotto stesso. L’oggetto d’uso, continua Marx, non è affatto la cosa qu’on aime pour elle-méme, nella produzione delle merci. Qui gli oggetti d’uso vengono prodotti soltanto perché e in quanto essi sono sostrato materiale, depositari di valore di scambio. In quanto sono il medio. Senza medio non ci sarebbe possibilità di ritorno (ROI). Il capitalista non vuole produrre soltanto un oggetto d’uso, vuole produrre una merce, non soltanto valore d’uso, ma valore, e non soltanto valore, ma anche plusvalore.
Che cos’è questo valore che si cristallizza nell’oggetto d’uso?
Intanto, dice Marx (Libro I, cap 5, 222), per il valore (anima) è indifferente quale valore d’uso (corpo) ne sia il portatore, ma, nonostante questa indifferenza, da un valore d’uso deve pur essere portato. Durante il processo lavorativo il lavoro – l’informe, la materia, la possibilità, la virtualità, la molteplicità – si converte continuamente dalla forma del divenire in quella dell’essere, dalla forma del movimento in quella dell’oggettività. Alla fine di un’ora di lavoro il grano macinato si trasforma in farina. Come dal sapore del grano non si sente chi l’ha coltivato, così nell’oggetto d’uso non si vede il valore cristallizzato. Il valore (anima) passa nell’oggetto (nel corpo): s’incarna. L’oggetto, sotto le mani del lavoratore, prende forma, si valorizza (si anima – animismo). L’oggetto materiale, sensibile, diventa il corpo fisico e tangibile di un oggetto sovrasensibile, intangibile, invisibile, eppure presente (corpo mistico).
Si tratta dello schema di valorizzazione del capitale: D-M-D’.
Il patrimonio si scinde in lavoro morto e lavoro vivo, il patriarca pianta il seme nella terra, moltiplica le messi, e queste ritornano al padre come patrimonio rinvigorito. Lo schema patriarcale è servito: la donna è la materia, mera possibilità, potenza attualizzata dall’energia patriarcale.
Non c’è valorizzazione senza passaggio dalla potenza all’atto. Non c’è valorizzazione senza mediazione. D-D’ è identità vuota, tautologia. L’idea che il medio possa essere eliminato corrisponde all’idea che si possa produrre valore eliminando il lavoro. Là dove ciò dovesse accadere – il riferimento è all’arcinoto passo dei Lineamenti sulle macchine – il lavoro, effettivamente, diventerà una misura miserabile. Ma ciò non vuole assolutamente dire che la mediazione scomparirà e che con essa scomparirà il travaglio dell’uomo, semmai scomparirà il lavoro produttore di un’eccedenza – e, in ogni caso, avverte Marx nel programma di Gotha, non è il lavoro la fonte di ogni ricchezza, ma la natura).
Il capitale – l’anima – per riprodursi, deve incarnarsi, deve reificarsi, deve fasi corpo, deve fecondare la terra col seme e attendere il travaglio e il frutto, e attendere ancora che il frutto lasci la spoglia terrena, e ritorni con vigore rinnovato a porsi come capitale. Il medio deve essere tolto, per tornare all’immediata unità del capitale con se stesso. Non può avere per contenuto altro che se stesso. È l’immediato cui allude Napoleoni.
Come si spiega quest’ansia di togliere il medio (ammesso e non concesso che possa essere tolto, dato che il lavoro morto è ancora un medio)?
Perché il medio è il male possibile. Il medio è la carne debole, il corpo che si consuma e invecchia, che va alla deriva e si perde, che muta e si trasforma, che tentatalo dal peccato lascia la retta vita.
Secondo Aristotele, dice Adorno (Metafisica), solo l’incorporeo è immutabile e assolutamente immobile. Mentre l’oggetto determinato, soggetto alla negazione determinata, non avendo il proprio fine in se stesso (l’operaio ha il proprio scopo nel capitalista, così come il lavoro manuale ha il proprio scopo nel lavoro intellettuale – c’è tutta una gerarchia) non può essere libero, non può essere fine per se stesso, ma è sempre mezzo assoggettato ad un fine che gli è esterno.
Togliere il medio significa togliere l’etero direzione, togliere l’altro, togliere il corpo, togliere la materia, togliere l’informe o il deforme, il deviante, il peccaminoso.
Quindi, dice Adorno, l’ultimo fondamento di ogni movimento è, per dirvelo molto drasticamente nel linguaggio aristotelico, la divinità stessa come spirito puro e perfetto (la chiusura del ciclo: D-M-D’). La sua attività, l’attività di questo puro spirito divino, questa è l’argomentazione di Aristotele, può consistere solo nel pensiero, perché ogni altra attività – quindi sia ciò che s’intende con praxis in senso morale, πράττειν, sia ciò che s’intende con praxis nel senso di produrre delle cose, nel senso di ποιεῖν – deve avere ogni volta il suo fine al di fuori di sé, mentre ciò deve essere inconcepibile per l’essenza prima, pura e autosufficiente. Essa può avere il suo fine solo in se stessa; essa è solo fine a se stessa. E questa è la motivazione del principio per cui Dio è atto puro [tutte le possibilità sono effettive: non ci sono più possibilità] e non è determinato da un fine posto al di fuori di sé, questa è in fondo l’argomentazione che sta alla base della dottrina aristotelica dell’actus purus. Questo atto puro dello spirito, continua Adorno, che non ha alcun fine fuori di sé, è paragonato da Aristotele alla ϑεωρία, al pensiero puro, senza scopo, non riferito a una prassi reale. È l’apoteosi del pensiero puro, della pura contemplazione che deve essere fine a se stessa, senza alcun riferimento a un ente fuori di sé; quindi l’assolutizzazione della pura attività intellettuale – che è in certo qual modo la base di tutto ciò che si è poi chiamato in senso pregnante civiltà occidentale e contro cui poi però si è rivolta la critica più acuta all’idealismo – risiede appunto in questo concetto aristotelico di teoria. Non è difficile vedere qui la condanna di tutti quelli che, abbandonando questo terreno della purezza, si sono incamminati su un pendio di perdizione e di seduzione, subordinando lo studio alla carriera, l’amore alla comodità, l’arte al denaro, la professione alla carriera, la dolce convivialità ad occasione di intrallazzo, l’amore al sesso, la famiglia al divertimento, l’arte al successo, la verità al business, eccetera. Non è difficile leggervi questa costante subordinazione del corpo all’anima, del servo al padrone, dell’ape all’architetto, del povero tapino lavoratore manuale al professorone cattedratico.
In Aristotele questa gerarchia s’imprime anche nell’etica, nel fatto che le cosiddette virtù che consistono nella pura contemplazione e autoriflessione senza alcun riferimento a un fare, hanno ancora un primato rispetto a tutte le altre virtù. Il pensiero basta a se stesso in confronto alla prassi. Come se la separazione tra lavoro corporeo e lavoro intellettuale, che dipende dal processo di divisione del lavoro e in cui il lavoro intellettuale ha il primato sul lavoro corporeo – è come se questa separazione venisse riflessa ideologicamente (si dovrebbe dire) dalla metafisica in una forma per cui ciò che in effetti si è dimostrato come il principio dominante, cioè appunto il λόγος e perciò gli uomini che sono dispensati dal lavoro corporeo, fosse giustificato anche come la realtà superiore in sé e per sé, senza che in ciò subentri nella riflessione la necessaria dipendenza di questo spirito da quello su cui esso domina e da cui si è appunto separato. Il disprezzo di un certo romanticismo per il lavoro corporeo, e in generale un certo disprezzo per il lavoro manuale, deriva appunto da questa impostazione aristotelica, la quale vede nell’assoluto – nell’atto puro, in Dio – la figura della compiuta autodeterminazione. Tutta una certa spocchia artistica – anche quando insiste nel dire che il loro non è un lavoro – deriva ancora da questa pretesa teologica. Tutte le fini del lavoro, compreso il reddito garantito, si aggrappano a questa teologia. Ora, non si tratta di eliminare la teologia, perché siamo illuministi e la teologia rappresenta l’oscurantismo. Non c’è nulla di male nella pretesa all’autodeterminazione, nella pretesa, cioè, all’assoluto. Ciò che resta da verificare è se questa pretesa è sostenibile, o se invece, al contrario, un passaggio per la materia, una incarnazione, e dunque un’esposizione al male, non sia sempre necessaria – ovvero ineliminabile. La pretesa teologica è prima di tutto una pretesa del capitale: l’aufhebung – il toglimento – del lavoro è una speranza del capitale: D-D’ (rapporto immediato), dove l’apostrofo è il medio tolto.
XXIV
Il ciclo dovrebbe concludersi con le spoglie del lavoro, con il lavoro morto pronto per essere posto (tesi) come punto di avvio di un nuovo ciclo. Come era nel principio è ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Nel Capitolo V del Capitale, Marx ripropone questo schema hegeliano (che è anche un tema aristotelico), trattando del processo che si svolge fra l’uomo e la natura, nel quale l’uomo, per mezzo della propria azione, media, regola e controlla il ricambio organico fra se stesso e la natura: contrappone se stesso, quale una fra le potenze della natura, alla materialità della natura. Qui, dice Marx, non ci interessano le prime forme di lavoro, di tipo animalesco e istintive. Lo stadio nel quale il lavoro umano non si era ancora spogliato della sua prima forma di tipo istintivo si ritira sullo sfondo lontano delle età primitive per chi vive nello stadio nel quale il lavoratore si presenta sul mercato come venditore della propria forza-lavoro.
Cosa differenzia questo stato primitivo, in cui il lavoro non si era ancora spogliato dell’aspetto animalesco e istintivo, dal lavoro venduto sul mercato?
Ciò che differenzia l’uomo dall’animale è l’idealizzazione. In linea con la tradizione, Marx caratterizza l’uomo come un animale che parla, che idealizza.
Il ragno, dice Marx, compie operazioni che assomigliano a quelle del tessitore, l’ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggiore architetto dall’ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio nella idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui soltanto un cambiamento di forma nell’elemento naturale; egli realizza nell’elemento naturale. Allo stesso tempo, il proprio scopo, da lui ben conosciuto, che determina come legge il modo del suo operare, e al quale deve subordinare la sua volontà. E questa subordinazione non è un atto isolato. Oltre lo sforzo degli organi che lavorano, è necessaria, per tutta la durata del lavoro, la volontà conforme allo scopo, che si estrinseca come attenzione.
XXV
Nell’Introduzione del 57 Marx dice che la Produzione è immediatamente anche Consumo. Il consumo porta a compimento l’atto di produzione, perfezionando il prodotto come prodotto, dissolvendolo, e facendo diventare abilità, mediante il bisogno della ripetizione. L’oggetto di consumo è tolto, ciò che di esso rimane è il bisogno della ripetizione, unita alla capacità di capitalizzazione dell’abilità produttiva. D’altra, continua Marx, la produzione fornisce una determinazione al consumo. Senza questa determinazione il consumo rimarrebbe desiderio insoddisfatto, forma vuota priva di arricchimento. Anche in questo caso tutto transita in un circolo in cui, partendo da una idealizzazione, passando per una determinazione – un medio – si ritorna soddisfatti e pieni ad un rinnovato e più intenso bisogno.
Visto questo ciclo, dice Marx, niente di più semplice per un hegeliano che porre la produzione e il consumo come identici. E questo è accaduto non solo ad opera di letterati socialisti, ma perfino di prosaici economisti, come ad esempio Say, nella forma seguente: se si considera un popolo o anche l’umanità in abstracto, la sua produzione sarebbe il suo consumo.
L’individuo produce un oggetto e, dice Marx, consumandolo, fa di nuovo ritorno a se stesso.
In questo caso il ciclo si chiuderebbe. Ciò che era all’inizio sarebbe anche alla fine.
Nel caso della società, invece, la relazione tra il produttore e il prodotto è una relazione esteriore e il ritorno del prodotto al soggetto dipende dalla relazione in cui questi si trova con altri individui. Insomma, non è detto che il ciclo si chiuda positivamente, ovvero che la ragione abbia sempre ragione della realtà. Dunque, non si tratta di abdicare alla ragione, perché la ragione, come dice Adorno, diventa verità solo accogliendo pienamente in sé ciò che gli si oppone, ed è sempre anche soggetta alla tentazione di trasformare, proprio per questo, l’opposto stesso in pensiero, idea, verità.
Si tratta, invece, di riconoscere che ogni tentativo di togliere il medio non fa altro che acuire o duplicare o replicare la differenza che si vuole togliere, e ciò avviene per l’ineliminabilità del fatto empirico, della traccia corporea. L’oggetto determinato è un’unità relativa, ritagliata empiricamente fra unità più grandi o più piccole (Nietzsche). Questo fatto, dice Derrida (Il pozzo e la piramide) non è solamente un fatto empirico, non è un fatto che si può eliminare, un fatto contingente, è l’esempio di una legge essenziale che limita irriducibilmente la realizzazione di un ideale teleologico.
Su questo tema Derrida e Adorno si dividono.
XXVI
L’unica interpretazione possibile dell’idea hegeliana, dice Adorno (Terminologia II, 502), è quella per cui essa è quel tutto che per lui corrisponde al vero, in cui soggetto e oggetto sono tra loro identici. Essa è quindi l’assoluta identità dell’essere (della realtà effettiva) e del pensiero.
L’idea hegeliana, continua Adorno, è analoga a quella kantiana. Anche in Kant c’è identità di soggetto e oggetto. Ma mentre in Kant l’oggetto non è realtà effettiva, ed esiste solo nel soggetto, in Hegel l’identità del soggetto e dell’oggetto deve essere presa sul serio, presa alla lettera. L’idea non è più una semplice rappresentazione, essa è realtà: la stessa realtà effettiva deve corrispondere all’idea, che è dunque oggettivata. Come si legge nella Grande Logica, tutto ciò che è reale esiste solo nella misura in cui comprende in sé l’idea e l’esprime – siamo in aperta polemica con Kant.
L’identità tra soggetto e oggetto può portare al più cupo positivismo, per esempio quello che si è affermato nel sovietico Diamat (materialismo dialettico), il quale porta alla giustificazione anche di uno stato totalitario. Anche uno stato totalitario è ragionevole, e non può che essere tale, perché la ragione si afferma necessariamente come realtà – e anche l’opposizione si afferma in questa realtà, dunque quello attuale è l’unico mondo possibile.
Come reazione al Diamat, dice Adorno, nel marxismo occidentale si è cercato di sopprimere il momento propriamente materialistico. Il tentativo di attribuire a Marx una sorta di antropologia, che si appoggia soprattutto sugli scritti giovanili, sui Manoscritti economico-filosofici e sull’Ideologia tedesca, non è sostenibile.
L’opposizione tra Diamat e marxismo occidentale antropocentrico [andrebbe escluso da questa lista il marxismo strutturalista di Althusser], ha impedito quasi interamente di rendersi conto del problema posto dal materialismo di Marx.
Qual è questo problema?
In Marx, dice Adorno (Terminologia II, 454), manca completamente un materialismo naturalistico o una metafisica materialistica. Il tardo tentativo di Engels di colmare questa lacuna è molto discutibile. In questa mancanza, dice Adorno, è insita una critica del pensiero definitivo o totale. Questa assenza costituisce un impulso determinante nel materialismo di Marx, più dall’osservazione a cui lo si inchioda così facilmente nelle discussioni, che l’essere (la realtà effettiva) determina la coscienza, e non viceversa. Marx si sarebbe certamente rifiutato di ridurre la sua teoria a questa sentenza, non meno di quanto avrebbe potuto farlo Hegel.
Si tratta di capire come l’impostazione materialistica marxiana, e tutto sommato hegeliana, si concili con il principio primo e più profondo che si esprime nello scambio delle merci secondo la legge dell’equivalenza, cioè secondo l’astratto tempo di lavoro che è necessario per produrre le merci.
L’economia politica ha la pretesa che il mondo del liberalismo, del libero e giusto scambio, sia un mondo armonico, che grazie a una forza, la totalità delle singole azioni e degli interessi individuali e spontanei si accordino tra di loro e vengano così a costituire un tutto perfetto. Questa forza si chiama mano invisibile, la quale, componendo gli interessi singoli tra loro in contraddizione, realizza un equilibrio generale. Anche in questo caso si segue l’idea di una perfetta coincidenza tra reale e razionale, e di un accordo che si perfeziona aldilà della volontà dei singoli individui (aldilà dell’elemento antropologico o psicologico), di una ragione che è nelle cose stesse e agisce automaticamente. Lasciare fare, lasciare andare, significa appunto accettare il mondo com’è, accettare le sue leggi, non interferire, perché ogni interferenza si risolve comunque in un equilibrio dei fattori. Ogni sacrificio, ogni chiusura aziendale, ogni distruzione creatrice, ha un senso, ha uno scopo e un fine che si risolvono nell’equilibrio generale di un’unità ritrovata.
Hegel, dice Adorno, ha recepito proprio questa concezione dell’economia classica inglese, e la sua teoria della società coincide perfettamente con questo modello. L’origine storica dell’idea hegeliana di sistema risiede nella convinzione che attraverso la successione di atti individuali e spontanei, tutti soggetti alla relativizzazione, si organizza un tutto che è armonico, dotato di senso, interamente vincolato e strutturato, e cioè sistematico.
Marx, dice Adorno, non contrasta questo sistema su un piano, per così dire, volontaristico. Non dice: questo sistema è falso, è ingiusto, eccetera. Verifica invece la sistematicità di questo sistema, per trovare un punto dove esso possa cedere, e dove effettivamente cede. Marx dice che in questa società, in effetti, tutto avviene regolarmente, che si scambiano realmente gli equivalenti, ma che in un punto decisivo, e cioè quando si tratta di quella particolare merce che è la forza-lavoro, proprio in quanto le cose si svolgono regolarmente, c’è qualcosa che non torna. Il lavoratore rende più di quando costa all’imprenditore. La differenza costituisce il plusvalore. Somma che tocca all’imprenditore, e della quale il lavoratore viene letteralmente spogliato. Qui risiede il conflitto di classe. Superare il conflitto significa superare questa spoliazione, anche se, dal punto di vista del calcolo economico, l’imprenditore può giustamente dire che paga all’operaio quel tanto che basta per riprodurre la forza-lavoro consumata in fabbrica.
Insomma, Marx mostra che il sistema borghese, quando segue fedelmente le sue regole, non conduce verso un equilibrio generale, ma al contrario, verso la sua catastrofe. Il sistema marxiano, dice Adorno, può essere perciò definito un sistema negativo, una teoria assolutamente critica. Il mondo è bensì un sistema, ma è il sistema che è stato imposto agli uomini, che è loro estraneo ed eteronomo. È un sistema dell’apparenza. Questo sistema è ideologia, e il tutto, che per Hegel è il vero, secondo la teoria marxiana sarebbe invece il falso.
Perché Adorno ce l’ha con il sistema e con il sistematico?
Perché il sistema è totalitario.
Che cos’è il sistema?
Il sistema, dice Adorno (Terminologia, II 457), si propone anzitutto di dedurre da un unico principio centrale tutta la conoscenza, e anche, a rigore, la totalità della stessa materia. Il sistema è anche pensiero d’identità: tutto ciò che esiste rientra nello spirito conoscente, nulla gli può essere esterno. È proprio l’idea di un fuori che viene meno. Il pensiero sistematico è totalitario in quanto digerisce ogni cosa. Non esiste un contrario del sistema. Il sistema assume la sua forma totalizzante proprio quando, in Hegel, ingloba il suo contrario, facendo della contraddizione il motore del suo perfezionamento. Un sistema parziale – non filosofico – quello giuridico, ad esempio, non pretenderà mai di essere valido fuori dalla sfera giuridica. Invece il sistema filosofico non può ammettere la divergenza fra una materia da ordinarsi e un principio ordinatore. Poiché in questo caso il momento materiale, questa realtà che deve essere ordinata e che non segue dallo stesso principio, in un certo modo sfuggirebbe alla pretesa sistematica.
Marx, dice Adorno, si sottrae alla pretesa sistematica della filosofia, senza però cadere nell’irrazionalismo. Vi si sottrae grazie al suo materialismo, il quale non va inteso come un rovesciamento – un mettere sui piedi – della dialettica hegeliana, la quale poggiava sulla testa.
Il tratto critico e negativo del materialismo di Marx può essere colto nel concetto di lavoro produttivo. A questo proposito Adorno tira in ballo il Capitolo V del primo libro del Capitale, e fa notare come in Marx il concetto di valore, centrale nel suo discorso, sia un concetto interamente differenziato. Secondo Marx, dice Adorno (463), ogni merce si compone di un valore d’uso e di un valore di scambio. Il valore d’uso è il valore che qualsiasi oggetto, nella sua forma concreta, possiede per chi lo consuma. Più avanti, dice Adorno, vedrete come questo concetto, che può essere forse indicato come il concetto di valore che trascende il sistema, assuma un senso quanto mai sorprendente. Al valore d’uso si contrappone il valore di scambio. Il valore d’uso ha una immediata utilità. Tuttavia, non è affatto detto che questa utilità debba necessariamente coincidere con il prezzo o con il valore di scambio, con il valore che l’oggetto possiede come merce. Nel passaggio al valore si produce una indifferenza verso l’oggetto d’uso. Il valore d’uso è una materia naturale che cambiando forma è diventata adeguata a certi bisogni umani. Qui la natura, dice Adorno, è una realtà data, preesistente. Anche le scienze della natura – ad esempio – concepiscono in questo modo il loro oggetto, di cui Marx non analizza più le condizioni di possibilità – o perché la sua riflessione si interrompe a questo punto, o perché egli ha già escluso a priori una riflessione come questa.
Il lavoratore ha filato, e il prodotto è un filato. Il lavoro, scrive Marx, si è congiunto con il suo oggetto, con la materia naturale, è stato oggettivato, e l’oggetto è stato elaborato. Qui, dice Adorno, potete vedere molto bene che cosa significa quel concetto del lavoro coagulato o oggettivato che ricompare continuamente nel materialismo marxiano. Anche Marx, proprio come aveva fatto Hegel, non intende questo lavoro coagulato come qualcosa di puramente soggettivo, ma come il risultato di una mediazione fra il soggetto e l’oggetto. È concepito come qualcosa che contiene in sé sia il lavoro del soggetto che la materia naturale su cui si compie questo lavoro.
Il concetto del lavoro produttivo, dice Adorno, è forse quello in cui il materialismo di Marx si esprime nel modo più drastico, e serve forse meglio di ogni altro argomento a convalidare la tesi del carattere assolutamente asistematico, e cioè critico, del sistema marxiano.
Che cos’è il lavoro produttivo?
Nel processo lavorativo l’attività dell’uomo opera una trasformazione dell’oggetto del lavoro, nel prodotto si ritrova ciò che il lavoratore si era proposto fin dall’inizio. Il processo si estingue nel prodotto. Il prodotto è un valore d’uso, una materia naturale che cambiando forma è diventata adeguata ai bisogni umani. Questo tema, dice Adorno, è espresso in un linguaggio interamente hegeliano. Si pone una tesi (il progetto), la tesi impatta nella materia (negazione), l’oggetto resiste e nella resistenza assume la forma che l’idea gli imprime, l’idea si incarna e il lavoro si coagula, diventa cosa, si reifica, si oggettiva, l’oggetto viene ceduto, il progetto si chiude (sintesi), si tirano le somme, si raccolgono i frutti: D-M-D’. Ciò che era all’inizio sarà anche alla fine (teleologia) -senza resto, ciò che guida il processo in ogni fase è il progetto (l’idea). Tutto si adegua all’idea, prende la sua forma, soprattutto la materia informe. Lavoro produttivo è dunque quel lavoro che, subordinando al progetto la materia, subordina se stesso al valore di scambio. Il valore punta verso se stesso, gli è pertanto indifferente 1) sia l’oggetto d’uso nel quale si incarna e 2) sia il lavoro che si cura di rendere effettiva questa incarnazione. Così come il patriarca è indifferente alla donna che permette al suo seme di incarnarsi nella prole – la donna è materia informe, pasta che si rimpasta sotto la spinta dell’uomo, elemento materico che riceve lo spirito, ma che non è spirito – ed è, allo stesso modo, indifferente alla prole stessa, perché ciò che la prole deve lasciar transitare è il nome di famiglia; allo stesso modo, il capitalista è indifferente al lavoratore – betoniera che impasta – ed è indifferente al prodotto, perché ciò che il prodotto deve lasciare transitare è il valore nominale, il denaro, il capitale. Non è difficile vedere riprodursi in questo schema quello della santa trinità o del servo e del padrone. L’indifferenza verso la donna (fallocentrismo), l’oggetto d’uso (consumismo) e il lavoratore (fordismo), che è indifferenza verso la materia, va a braccetto con il teleologismo.
In Marx, dice Adorno, accanto a questa analisi del lavoro produttivo ce n’è un’altra. Ma poiché l’oggetto concreto del sistema marxiano è l’analisi della società borghese e del suo rapporto di scambio, il significato del lavoro produttivo così come è stato appena delineato deve necessariamente prevalere. Solo l’ottusità borghese, chiarisce Marx in Teorie sul plusvalore, può lasciare intendere che quella appena delineata sia una forma assoluta – e quindi la forma naturale ed eterna della produzione – può scambiare il problema: che cos’è il lavoro produttivo dal punto di vista del capitale?, col problema: quale lavoro, in generale, è produttivo?
Il sistema borghese, insomma, proprio in quanto è sistematico, cerca di ricondurre ogni cosa al sistema, cerca di ridurre tutto il lavoro a lavoro produttivo del capitale. Ciò che non riproduce il capitale semplicemente non è. Anche il non-essere è sempre determinato dal capitale. Marx rimprovera alla società borghese di estendere un concetto ristretto dell’economia capitalistica a tutta la storia universale. Invece, se si considera il lavoro produttivo secondo le regole stesse della società borghese, evitando di universalizzare queste regole, si può mostrare come questo concetto porti a delle assurdità.
Quali sono queste assurdità?
Per il capitalismo, produttivo è solo quel lavoro che valorizza il capitale.
Mentre nella società borghese, dice Adorno, il concetto della produttività è ideologizzato, il lavoro viene esaltato, in realtà la produttività è limitata esclusivamente alla valorizzabilità.
Nel sistema capitalistico, e solo per ragioni sistematiche interne, la produttività è una determinazione del lavoro che in primo luogo non ha assolutamente nulla a che fare con il contenuto determinato del lavoro, con la sua particolare utilità o col peculiare valore d’uso in cui essa si esprime. Lo stesso tipo di lavoro può essere produttivo o improduttivo. Ciò che lo rende produttivo – o improduttivo – è il suo innesto in un contesto di valorizzazione – in sé il lavoro non ha nulla di produttivo (se la produttività viene intesa all’interno del sistema del capitale).
Per esempio, scrive Marx (Teorie sul plusvalore), Milton, che ha scritto il Paradiso perduto per cinque sterline, è stato un lavoratore improduttivo. Vale a dire che non ha creato un valore di scambio, che la sua opera non era valorizzabile. Invece, lo scrittore che esegue un lavoro che gli è stato ordinato dal suo editore, dunque ad esempio anche lo scrittore di copioni cinematografici che fornisce a Hollywood dei testi dozzinali che fanno pietà, assolutamente ideologici e senza alcun valore (aggiunge Adorno), è un lavoratore produttivo.
Milton – dice Adorno – produsse il Paradiso perduto per lo stesso motivo per cui un baco produce la seta. Si è trattato di un’attività della sua natura. Più tardi vendette il prodotto per cinque sterline. Ma lo scrittore proletario di Lipsia che sotto la direzione del suo editore fabbrica dei libri è un lavoratore produttivo; poiché il suo prodotto è sussunto preliminarmente sotto il capitale ed è realizzato solo per la sua valorizzazione. Una cantante che vende il suo canto per proprio conto è un lavoratore improduttivo. Ma la stessa cantante che è ingaggiata da un impresario che la fa cantare per guadagnare denaro è una lavoratrice produttiva, poiché produce capitale.
Dove sta l’assurdità che Adorno vuole farci notare?
L’assurdità del concetto di lavoro produttivo – l’assurdità dell’economia e del sistema borghese in quanto è sistematico – consiste in ciò: che il Paradiso perduto, rispetto al copione di Hollywood scritto da uno scribacchino stipendiato, non vale nulla.
Insomma, dice Adorno, l’indifferenza verso il lavoro effettivo e verso l’effettivo oggetto d’uso (lavoro e oggetto sans phrase), necessaria affinché il progetto capitalista possa, partendo dall’idea (D) far ritorno all’idea (D’), porta all’assurdità di considerare un’opera di grande valore come il Paradiso perduto di Milton, una fetecchia, se paragonata all’opera dell’operaio di catena che produce copioni per l’industria culturale. Qui, si esprime in pieno lo snobbismo romantico di Adorno – e si misura la grande differenza con Derrida, il quale non concede al sistema nessuna attenuante, nessuna via di fuga, nessuna possibilità di ricuperare in extremis – come invece è evidente in Adorno, dove il Paradiso perduto è sempre, in ogni momento, recuperabile da Hollywood, e recuperabile proprio in quanto opera di valore (non c’è differenza tra un’opera di valore, il Paradiso perduto, e un’opera di valore commerciale, si tratta sempre di valore, la sussunzione è già cominciata, non si deve attendere che Hollywood recuperi in extremis ciò che non può non essere recuperabile).
Dove si ferma il recupero, l’aufhebung?
Come fermare l’aufhebung? – si chiede Derrida (Glas).
Risposta: Bisogna far apparire forze di resistenza all’aufhebung, al procedere della verità, alla negatività speculativa, e mostrare che tali forze di resistenza non costituiscono a loro volta negatività rilevabili o che si rilevano.
Ma come?
Nel passo di Marx che Adorno ha appena commentato viene veramente in luce, dice Adorno, come attraverso la critica di tutte le categorie della società borghese, che sono qui rappresentate dalla produttività, viene in luce come l’intero sistema sviluppato da Marx non sia un sistema dell’assoluto o della verità. Marx mostra che il tutto che provvede affinché il copione dello scribacchino di Hollywood sia lavoro produttivo e quello di Milton invece no, che proprio questo sistema è il falso.
Infine Adorno riconosce che il tema del lavoro produttivo, affrontato in questo modo, ha un tratto romantico, insito nella formula che Milton ha cantato come canta l’uccello, o, come si esprime Marx, ha filato come un baco fila la seta.
Che differenza c’è tra il lavoro dell’ape e quello dell’architetto?
Lo abbiamo già visto. La differenza sta nel progetto e nella teleologia. L’ape fabbrica la cella spensieratamente, senza scopo, l’attività è fine a se stessa, il suo fabbricare non è subordinato a un fine, e nemmeno la cella ha un senso che travalica il lavoro effettivo che si esprime nel gesto. Non c’è mediazione, non c’è alienazione. La cella non è il mezzo – perché non c’è fine. La cella, se si può dire così (ma come si vede ogni dire inciampa nella valorizzazione) vale per se stessa, come a dire che non vale nulla. Non c’è reificazione, il lavoro dell’ape non si coagula nella cella perché non c’è lavoro. Non essendoci lavoro, non c’è subordinazione del mezzo – il lavoratore come capitale vivo, e la materia prima come capitale morto – al fine. Non c’è alienazione. Non essendoci alienazione, non c’è niente (anche se espressa così, questa formula – non c’è niente – è ancora subordinata al sistema, implica una certa alienazione, una reificazione, un passaggio per il medio.
Il niente, nota Hegel nella Grande logica, è uguale all’essere, è il sistema. Non si può togliere l’alienazione, perché questo togliere è l’aufhebung. L’aufhebung è l’essere (la è), non come stato determinato o come totalità determinabile dell’essente, ma come l’essenza “attiva”, produttrice dell’essere. Noi siamo continuamente rinviati ad esso, ma tale rinvio non rinvia a niente di determinabile – Derrida, Glas).
Marx, dice Adorno, non tematizza la natura, essa viene acquisita come una realtà data, preesistente, alla stessa stregua delle scienze della natura. L’immediatezza del baco che tesse la tela viene posta fuori sistema – come uno stadio mitico. Anche se, Adorno lo sa bene, il mito non resiste all’illuminismo.
XXVII
Non c’è modo di parlare male della macchina – e la macchia è progetto-idea diventata cosa-strumento, catena di montaggio che domina l’uomo – senza porre uno stadio mitico di immediatezza, in cui il cantare (come per l’uccello), non è mezzo, ma è fine a se stesso. Senza reificazione.
Come definisce Adorno la reificazione?
Il concetto di reificazione appare già nella prime pagine del bellissimo libro di Adorno Terminologia filosofica (Manlio Iofrida, Contro il post-umano).
Il realista, dice Adorno (26), è un uomo che si uniforma alle cose e regola su di esse il proprio comportamento, mentre l’idealista è colui che tiene fermo alla propria determinazione umana e sostiene la sua libertà nei confronti del mondo delle cose. In Fichte, ad esempio, potete trovare qualcosa di simile: il realista (il dogmatico) è colui che non si basa sulla viva produzione degli oggetti, ma sulla loro forma fissa, sulle cose. Questa distinzione terminologica di Fichte potrebbe forse essere intesa come la prima espressione della scoperta di ciò che si può chiamare coscienza reificata. Il realismo è la concezione secondo cui le cose sono quali sono in sé, e la nostra conoscenza raggiunge la verità se si identifica con la percezione ingenua delle cose, nella loro apparenza immediata, mentre nella concezione dell’idealismo il mondo dei fenomeni è un prodotto delle forme della nostra coscienza.
Da un lato, dice Adorno, la filosofia è il tentativo di sottrarsi al pensiero reificato, settoriale, mentre dall’altro lato non può sfuggire alla regola della divisione del lavoro, alla cristallizzazione, e quindi non può fare a meno di creare linguaggio fisso, una terminologia fissa.
Adorno lega la reificazione alla divisione del lavoro e alla specializzazione del sapere positivo. La filosofia, invece, è l’opposto di una specializzazione, o non è una specializzazione, si occupa di tutto o del tutto, di ciò che non è suddiviso in parti, o, anche, di ciò che non è una conseguenza della divisione del lavoro, ma nello stesso tempo la suddivisione del lavoro, come problema, e le sue conseguenze, rientrano senz’altro nel concetto della filosofia. Nemmeno la filosofia è dunque immune alla divisone del lavoro. Buona parte dei suoi temi provengono dalle scienze positive. Anche in filosofia si verifica il fenomeno della cristallizzazione del linguaggio in una terminologia particolare, che porta infine alla reificazione. Non c’è nessun giudizio che dica A è B e che sia vero in senso stretto, poiché A è B significa, propriamente, che un B, che è qualcosa di diverso da un A, cade sotto un concetto generale che chiamiamo A. Prescindendo dal fatto che, dice Adorno, questo B cade sotto questo A, ad esempio che il cavallo è un animale, il cavallo ha molte altre determinazioni che non sono contenute nel concetto di animale. A sua volta il concetto di animale ha tutta una serie di note relative ad altri concetti, per esempio quello di uomo, che non sono contenute nella specie cavallo, e dunque nella stessa formazione concettuale che è il mezzo della verità. Senza concetti non c’è verità, ma nella verità c’è un momento di falsità. Non c’è una parola che dica veramente quello che vuole dire. Il reificato del linguaggio filosofico può trovarsi ovunque. Si potrebbe suggerire alla filosofia il compito di sanare il torto che fa alla cosa – al cavallo che viene ridotto ad animale e assimilato alla capra. Ma questo compito appare subito disperato, come il tentativo del barone di Münchhausen di tirarsi fuori dalla palude per il codino. La filosofia, dice Adorno, è lo sforzo del concetto di guarire le ferite che il concetto necessariamente produce.
Si tratta di una sfida impossibile.
Quando ero giovane, dice Adorno, pensavo che con la filosofia potevo essere in grado di esprimere le mie intuizioni ed esperienze più essenziali intorno al mondo – senza preoccuparmi di trovare una formula per la verità assoluta. Ho sempre diffidato di ogni formula. Una persona che accede per cosi dire incorrotta alla filosofia, e cioè che non ha già dei concetti prefabbricati, abbia, come l’ebbi io, la sensazione che essa gli insegni a esprimere ciò che ha veramente intuito o le vere esperienze che ha fatto intorno al mondo, più che non creda di entrare in possesso di un sistema o una formula o qualcos’altro. In questo senso, dice Adorno (78), la filosofia è legata assai profondamente al momento dell’espressione, al momento che nella Dialettica dell’illuminismo Horkheimer ed io abbiamo definito come mimetico. Se la filosofia cerca una verità, questa non consiste primariamente nell’adeguazione di proposizioni o giudizi o pensieri a stati di fatto dati e precostituiti, ma si tratta assai di più del momento espressivo. A questo pensiero espressivo, che non è un modo dilettantistico di produrre il discorso, ma è un modo che si oppone all’automatismo del pensiero reificato, alla reazione meccanica codificata in formule. Di fronte all’enorme preponderanza del mondo reificato il mezzo con cui possiamo sfuggire all’apparenza che questo mondo sclerotizzato e prefabbricato ci impone consista effettivamente nella capacità esperienze originarie, vorrei quasi dire nel fatto che noi conserviamo un momento di ingenuità che rappresenta nello stesso pensiero ciò che non è concetto, che non è un principio di ordine, di organizzazione logica. In questo senso la filosofia – ed è ciò che la distingue costitutivamente dalla scienza – ha effettivamente una sorta di affinità con l’arte.
Il compito della filosofia è dunque quello di dire l’indicibile. Se essa non vuole fermarsi a questo paradosso, dice Adorno (82), di dire ciò che è a rigore indicibile, essa contiene il momento del movimento, dello sviluppo, del dispiegamento della contraddizione; e questa contraddizione è insita nel suo impulso, in quello che essa stessa vuole – cogliere mediante il concetto il non-concettuale, con il linguaggio ciò che non può essere detto col linguaggio. Nell’impostazione stessa della filosofia, in ciò che essa vuole in quanto movimento, è quindi insito fin dall’inizio e necessariamente ciò che l’espressione dialettica propriamente significa.
Perché io sostenga la dialettica? – chiede Adorno.
La dialettica non è un punto di vista filosofico accanto ad altri ugualmente possibili. L’impostazione dialettica è propriamente contenuta nell’impostazione filosofica, se per filosofia si intende questo terzo comportamento diverso da quelli della scienza e dell’arte.
E tuttavia, avverte Adorno (86), se la filosofia si isola dalla scienza, non sperimenta quell’attrito con la scienza, e si limita invece al momento espressivo, che del resto è abitualmente falsato esso stesso fin dall’inizio, e cioè reificato, essa degenera allora nel proprio opposto, nella Weltanschauung, avversa essa stessa alla filosofia, esattamente nell’identica misura del pensiero reificato. Si potrebbe quasi dire che la scienza e la Weltanschauung sono i due pezzi in cui si frantuma la filosofia, che d’altra parte non può essere ottenuta semplicemente sommando o sovrapponendo questi elementi separati tra loro.
Insomma, la reificazione è legata alla divisione del lavoro, e la divisione del lavoro è legata alla specializzazione, e la specializzazione direttamente al cliché. Ci sarebbe una prima e più generale reificazione che riguarderebbe la divisione tra mano e mente, e una reificazione secondaria e più specifica che riguarderebbe la fissazione di questa specializzazione nel concetto e nella matrice, matrice utilizzata per imprimere nella materia fluida una forma. Dunque, la reificazione rappresenta la divisione tra forma e contenuto, rappresenta i due momenti separati e indipendenti, astratti l’uno dall’altro. In più, questa astrazione viene usata, appunto, per formare ogni contenuto con un identico stampo, privando ogni differente della propria differenza. Inoltre, essendo la differenza visibile solo nella luce del concetto, dire che una differenza viene identificata dal concetto e formata in modo identico a tutte le altre, significa, allo stesso tempo, dire che non c’è differenza. C’è differenza se non c’è differenza, e viceversa. Questo è l’imbroglio con il quale è alle prese la filosofia. Davanti a questo imbroglio la filosofia risponde con la dialettica. La dialettica è l’assunzione che i due momenti, la forma e il contenuto, non sono l’uno separato dall’altro: la loro verità è nel tutto. A differenza della dialettica hegeliana, che si conclude nel momento positivo della sintesi, corrispondendo in ciò al movimento di valorizzazione del capitale, cioè alla riproduzione allargata, la dialettica di Adorno vorrebbe fermarsi al momento della negazione, cioè al momento della circolazione semplice, e al flusso inarrestabile, mosso perpetuamente dalla negazione determinata. Si tratta, per la filosofia – e qui Adorno esprime il suo massimo punto di vicinanza con lo strutturalismo – si tratta di riconoscere il valore di posizione di ogni concetto. Se questo concetto, dice Adorno (Terminologia), scaturisce dalla totalità di un pensiero che si sviluppa, e in cui acquista il suo valore di posizione, è qualcosa di decisamente diverso che se è posto all’inizio del pensiero e all’inizio della riflessione filosofica in modo atomistico e più o meno meccanico.
Meccanico è il concetto astratto – reificato. L’avversione di Adorno per la macchina e lo stampo, per l’industria e il lavoratore industriale, per il lavoro in generale, visto che il lavoro è tutto lavoro industriale, anche il lavoro culturale – in ciò si può leggere un tratto romantico a anti-lavorista presenta nella tradizione romantica, per esempio in Oscar Wilde – questa avversione deve diventare, dice Adorno, una resistenza filosofica intellettuale organizzata, deve diventare opposizione contro le convenzioni e contro i cliché che sono coniati dalla società. Un individuo che non ha mai provato disgusto per quello che tutti pensano e che tutti dicono, un soggetto simile non può giungere alla filosofia. La filosofia è la resistenza contro tutti i cliché.
Questa resistenza, avverte Adorno, non avviene per restaurare un passato che il cliché avrebbe soppiantato. C’è una sorta di superstizione, dice Adorno, peculiare al nostro tempo, secondo cui i pensieri più antichi sarebbero i più veri. Si tratta probabilmente di un fenomeno di reazione all’irremovibile fede nel progresso.
L’obiettivo di questa polemica è ovviamente Heidegger, il contadino di Messkirch, con la sua superstizione dell’origine, e secondo il quale, dice Adorno (143), ciò che viene geneticamente e logicamente prima, proprio per questo deve poter pretendere alla suprema dignità e verità, secondo una concezione nella quale si può avvertire una forte componente di una non risolta mitologia: la convinzione che i vecchi dèi siano quelli veri, che ciò che è esistito per primo debba essere necessariamente migliore, secondo il significato dei miti dell’età dell’oro, che in origine gli uomini possedessero una verità che hanno poi perduta, o per propria colpa, o per un destino ineluttabile.
La filosofia potrebbe dimostrare – in ciò risiede un motivo profondo della filosofia di Adorno – che ciò che si ritiene primo in realtà è in sé mediato, e cioè contiene già in sé i momenti che secondo la fede nel fondamento gli si dovrebbero successivamente sovrapporre. Questo tema della mediazione, sostenuto con forza contro Heidegger, fa a pugni con altri luoghi del testo di Adorno dove viene sostenuta una certa immediatezza. Va da sé che si potrebbe giustificare questa contraddizione dicendo che è un movimento proprio alla dialettica avanzare contraddicendosi, e che essa mostra, in Adorno, l’aspetto vivo del suo pensiero, la sua lotta, che non è lotta con un potere esterno – reificato, dunque ideologico – ma è lotta intestina, lotta del sé con il sé, calvario personale, scissione nell’unità – dialettica, appunto. Ma le cose non sono così facili.
Tutta la filosofia di Hegel, dice Adorno (143), è stata formulata come una protesta contro l’origine, sia che questa origine venga rappresentata come essere, sia che, come è di moda oggi, venga rappresentata come fatto. Hegel ha sempre lottato contro la tesi secondo cui la verità può essere derivata da un principio definitivamente dato. Secondo Hegel la stessa verità è processo, e in questo senso non è solo origine, ma sempre anche qualcosa di originato. È, si potrebbe dire, la costellazione fra l’origine e l’originato, a condizione peraltro di non conservare questi due concetti, soprattutto quello dell’origine, nella loro consueta, tradizionale rigidezza. Ogni volta che i filosofi hanno imboccato la strada dell’origine o dell’originario, dice Adorno (144), i concetti o i principi a cui sono pervenuti si escludevano a vicenda, tanto che ad ogni concetto originario corrisponde sempre un contro-concetto, e che l’approssimarsi all’originario sdoppia sempre la puntualità del concetto.
In Heidegger, dice Adorno, questa ricerca dell’origine e dell’originario, dell’immediatezza del rapporto delle vita con le condizione della sua riproduzione, deriva da un mondo agrario-artigianale, da una vita contadina che Heidegger credeva più prossima alle origini: la vita di campagna, con il suo provincialismo e tutto quello che esso comporta. In realtà, dice Adorno, questa vita di campagna favoleggiata da Heidegger può ancora sopravvivere qua e là nel mondo in cui noi stessi viviamo solo per grazia del processo di industrializzazione che la sopporta, un po’ come gli animali selvaggi in Africa vivono solo per grazia delle compagnie aeree, che per caso non hanno ancora installato le loro grandi piste di atterraggio. Ciò che qui si presenta con questa enorme pretesa di sostanzialità è propriamente villeggiatura – dice Adorno – non solo per i cittadini, ma persino per gli uomini che vivono cosi e la cui forma di vita potrebbe essere senz’altro sostituita da altre, se le forze produttive non fossero incatenate. Questa sproporzione fa sì che nella lode della vita semplice sia obiettivamente presente un momento di mendacia.
Non si tratta, dunque, di ritornare ad un’immediatezza originaria. Si tratta, invece, di uscire dalla macchina infernale (200), dal meccanismo coattivo di un pensiero chiuso in se stesso, senza peraltro abbandonare il pensiero definitorio con un salto, ma spezzando questo pensiero dall’interno – mettendolo di fronte alle esigenze sue proprie, interne. Perché, dice Adorno, se contrapponessi a questo pensiero infernale, dall’esterno, un altro pensiero, quest’altro pensiero scadrebbe nella Weltanschauung, in una sorta di relativismo secondo il quale non ci sarebbe affatto una verità ferma e stabile, ma un pensiero che sarebbe una proiezione relativa ai singoli individui.
La reificazione è il pensiero fissato in routine, in cliché, persino in abitudini, dunque, è il pensiero determinato dalle regolarità logico-meccanica. Si tratta di un pensiero eterodiretto, che trova la propria ragione in un principio fuori di sé. Il pensiero libero non può sopportare di avere fuori di sé alcunché che lo determini, dunque, il pensiero libero non può essere un pensiero meccanico, perché se così fosse risponderebbe a regolarità e leggi che non si è dato da sé.
La macchina è tutto ciò contro cui la critica di Adorno si accanisce. Se c’è una differenza tra Derrida e Adorno riguarda proprio la macchina. Mentre Adorno, tra le altre cose, si sforza di mostrare come sia impossibile per una macchina replicare un uomo, perché l’uomo ha elementi di unicità mentre la macchina invece non li possiede, e ogni volta che tenta di riprodurre l’uomo non può fare a meno di eliminare ciò che è proprio dell’uomo, ovvero la sua unicità; Derrida, al contrario, mostra come l’uomo, ogni volta che tenta di manifestare la sua unicità, non può fare a meno di produrre una macchina – non si dà unicità senza macchina. A tutto ciò aggiunge una complicazione che non si trova in Adorno, ma che si trova in Marx, e cioè che la macchina esiste, è un pezzo empirico del mondo, e dunque cade nelle trame della contraddizione determinata. La macchina che riproduce il concetto (l’ideale) non può riprodurlo senza imprimerlo in un reale meccanico, un reale empiricamente diviso fra unità più grandi o più piccole. Questo fatto di essere impresso e di essere soggetto alla contraddizione determinata, spezza ogni teleologia, se teleologia significa possibilità dell’idea di ritrovare se stessa alla fine di un percorso. Derrida mostra come questo percorso è un percorso accidentato, un percorso empirico, un tragitto effettivo di una cosa effettiva tra cose effettive, e che dunque la possibilità del ritorno non è assicurata.
I calcolatori, dice Adorno (343), hanno esercitato un’influenza enorme. Sono macchine capaci di immagazzinare informazioni; sono in grado di svolgere funzioni che sono perlomeno analoghe a quelle del ricordo e del riconoscimento. Hanno persino la capacità di affrontare delle resistenze che contrastano il riconoscimento e il ricordo, capacità che è del tutto simile a quella che gli uomini pensanti, che i soggetti viventi sperimentano in sé. Sono dunque in grado di superare tali resistenze. Tutto questo è certamente inquietante, e induce alla riflessione. Il problema è ora se questi calcolatori, dice Adorno, hanno anche qualcosa che corrisponde all’unità della coscienza personale, dal momento che dopo tutto svolgono quelle funzioni che vi ho indicato come differenza specifica di una siffatta coscienza personale. Quel momento che ho definito come l’unità della struttura qualitativa, e cioè quel «mio» che caratterizza tutte le esperienze e gli stati di una coscienza individuale, in queste macchine non è presente nella stessa maniera. Penserei che tutti i contenuti di coscienza di una macchina di questo tipo standardizzato potrebbero essere sostituiti da quelli di un’altra, senza che cambi qualcosa di essenziale [Adorno sottrae alla macchina ciò che è proprio della macchina, il suo essere situato, il suo essere unica] mentre il più semplice esame di quelle che chiamo le mie esperienze psichiche mostra che ciò non è possibile [mentre attribuisce all’uomo quello che è impossibile, l’unicità dell’esperienza, quando è evidente che non c’è esperienza senza ripetizione, senza identità, senza concetto].
Non potendo trascurare la replicabilità del concetto, Adorno aggiunge quanto segue. In contrasto con quello che vi ho detto prima, potrei supporre che attraverso la comunicazione i miei contenuti di coscienza diventino quelli di un altro in una misura tale che la famosa egoità si trasformi in un principio estremamente esile e astratto. In questo caso ci sarebbe almeno la possibilità di sostituire i contenuti della stessa coscienza personale. Confrontato con la coscienza vivente che noi abbiamo il modello di quell’unità delle funzioni della coscienza che è presentata da Kant è un’astrazione. A questo punto diventa impossibile in linea teorica distinguere la coscienza trascendentale dal cosiddetto pensiero delle macchine. A partire da Cartesio l’ideale della conoscenza è quello causale-meccanicistico; la conoscenza meccanicistica elabora fondamentalmente delle leggi secondo le quali si possono anche costruire i meccanismi, le macchine. Non per nulla la filosofia cartesiana è stata la filosofia del periodo della manifattura. Se supponiamo, dice Adorno, che la scienza causale-meccanicistica e matematica di Cartesio preformi anche il soggetto, la stessa res cogitans, che quest’ultima sia stata formata secondo il modello della conoscenza meccanicistica, in modo da essere adeguata alla funzione che deve svolgere, in questo caso dovremmo ammettere che lo stesso soggetto trascendentale è stato concepito a priori come una macchina. E in effetti, dice Adorno, non è un caso che Kant parli continuamente dei meccanismi della nostra conoscenza, che la gnoseologia moderna in genere parlando del soggetto si sia servita continuamente di immagini meccaniche, di analogie con le macchine. Se l’ideale del soggetto scientifico e gnoseologico è la macchina, non c’è nulla di assurdo se alla fine sono state inventate delle macchine che è straordinariamente difficile distinguere da un soggetto cosi concepito. Ma in ogni modo, conclude Adorno, anche oggi che queste cose cominciano a diventare un po’ confuse, rimane una differenza essenziale, che vorrei fosse ben chiara. Anche queste macchine presuppongono, come condizione della loro possibilità, un soggetto che conosce logicamente, appunto quel soggetto cognitivo logico, mentre viceversa questo soggetto logico a sua volta non presuppone affatto l’esistenza di tali macchine, come dimostra la storia in modo semplice e inequivocabile. In questa eccedenza che il soggetto ha qui sulla macchina anche se è inteso come puro soggetto logico, si rivela, in ultima istanza, l’eccedenza del soggetto vivente, o l’impossibilità di risolverlo nelle categorie della reificazione, alle quali nella sua storia la coscienza è stata sempre più assoggettata.
In questa conclusione Adorno parte da un soggetto logico – che, sulla scorta di Husserl, non confonde mai con il soggetto psicologico – per concludere con un soggetto storico psicologico. Nessun soggetto storico o psicologico può mostrare, men che meno dimostrare, una precedenza dello storico o dello psicologico sul logico. Dunque, se il logico è meccanico, non sarà certo la storia, la storia che vede apparire (ma questa è una supposizione di Adorno che bisogna ancora dimostrare), che la vita antropologica precede la macchina. Non c’è possibilità di fornire una dimostrazione di questa precedenza, perché ogni dimostrazione presuppone ciò che deve essere dimostrato – cioè la macchina. Non si può attaccare la macchina ipostatizzando un fuori, si attacca la macchina facendola funzionare, perché la macchina, funzionando, si determina, e determinandosi si espone alla morte assoluta – si inceppa, si surriscalda, si brucia, viene attaccata da un malwere.
XXVIII
L’alienazione è il primo momento, il momento della scissione, della costituzione e del rapporto al Non-io: è il momento del no, della negazione determinata. Se questo momento viene completamente meno, dice Adorno (Terminologia, 430), anche nella produzione interiore c’è qualcosa che non va. L’Io non si dispiega se si cura e coltiva come se fosse una pianta, se si innaffia e si rallegra della sua bella fioritura, ma si dispiega solo a condizione di quella che Goethe e Hegel hanno chiamato alienazione. Alienazione qui non significa affatto un adattamento completo al mondo, per cui ci si rende simili ad esso. Al contrario, ciò che esiste in un certo modo, la casualità della propria particolare esistenza, deve essere esposta alla dialettica con il Non-io. Solo ciò che regge alla prova di questa dialettica e in questa stessa dialettica giunge alla propria verità, ha veramente ragione; ma non ciò che difende la propria integrità rifiutando ogni rapporto con quello che potrebbe minacciarla. Quella che si chiama la ricchezza dell’individuo o della persona, e tutto ciò a cui mirano le ideologie della cultura, in verità è sempre anche la ricchezza del mondo che si sperimenta e si forma solo nell’esperienza di questo mondo.
Che cos’è dunque questa alienazione?
Nella Differenza Hegel scrive che Manifestarsi e scindersi è una cosa sola. Manifestarsi non vuol dire uscire dal nascondiglio, uscire all’aperto e farsi vedere. Non si tratta del farsi vedere di un qualcosa che già è costituito e che sarebbe celato in un nascondiglio, e del quale ci si dovrebbe incaricare, magari tramite la scienza o la filosofia, di far venire alla luce, allo scoperto. Non si tratta di scoprire un qualcosa che già c’è. Prima dell’apparizione non c’è alcunché, se non il tutto indistinto o l’assoluto immediato indifferenziato. Affinché qualcosa appaia e sia, bisogna che questo assoluto immediato si scinda. La scissione è un movimento, un’esperienza, un diventare altro e un riconoscersi in questo altro come altro da sé.
Nella Prefazione alla Fenomenologia (Cicero, 91) Hegel dice che ciò che si chiama esperienza è proprio questo movimento in cui l’immediato, il non esperito, cioè l’astratto diviene innanzitutto estraneo a se stesso e poi da questa estraneazione (Entfremdung) ritorna a sé: solo nel momento del ritorno a sé l’immediato, divenuto anche proprietà della coscienza, è presentato ed esposto nella sua realtà (Wirklickeit) e verità.
Dunque, non c’è verità senza alienazione.
Commentando questo passo, Heidegger dice (La Fenomenologia dello spirito di Hegel, 54), che in questo inveramento la coscienza non perde soltanto, ma fa anche un’esperienza, si arricchisce di un’esperienza, acquisisce una verità. L’esperienza, dice Heidegger, dà un duplice risultato, negativo e positivo: nell’esperienza che la coscienza fa con se stessa essa si fa altro; ma proprio questo diventar-altro-da-sé è un venire-a-sé-stessa. Esperienza vien detto appunto (qui cita il passo della fenomenologia) quel movimento in cui l’immediato, il non sperimentato, cioè l’astratto [relativo], si viene alienando, e poi da questa alienazione** torna a se stesso; così soltanto ora, dacché è anche proprietà della coscienza, l’immediato è presentato nella sua effettualità e verità.
Il commento di Heidegger è molto più stringere di quello di Adorno. In primo luogo Heidegger chiarisce che l’esperienza non è un provare o un testare, e nemmeno un mettersi alla prova. Quando si dice, nel linguaggio comune, che ognuno deve fare le proprie esperienze, si vuol dire 1) che l’esperienza non si acquisisce come una conoscenza libresca e 2) che l’esperienza riguarda soltanto chi la fa, e lo riguarda se l’esperienza viene fatta effettivamente; non si può fare esperienza per procura, e non si può imparare da un altro che ha fatto la stessa esperienza – le esperienze non sono mai uguali. In secondo luogo Heidegger chiarisce che l’esperienza non si rapporta ad un dato. L’esperienza costruisce, nell’esperienza stessa, il proprio dato; ma a questo punto il dato, in quanto oggetto astratto dell’esperimento, non è più un dato. L’esperienza non è mai un esperimento e, men che meno, una esperienza scientifica, un sapere tecnico scientifico. L’esperienza deve essere sempre la mia esperienza, eseguita nelle condizione che sono sempre e solo le mie.
In terzo luogo Heidegger chiarisce che siccome l’esperienza non può presupporre né il dato esperito né il soggetto idoneo all’esperienza, in quanto è proprio l’esperienza che produce il soggetto formato all’esperienza, e che dunque l’esperienza è uno stagliarsi e uno sbilanciarsi – un alienarsi e un concedere l’altro e un concedersi all’altro – senza presupposti – l’esperienza è un salto. Tutto deve compiersi nell’assoluto, non si può ritenere che l’esperienza inizi da qualcosa che gli stia fuori, che sia relativa a questo fuori. Non c’è fuori, non c’è rapporto al fuori. Se ci fosse un fuori dell’esperienza che guidasse l’esperienza, o che fosse, per così dire, la causa dell’esperienza, non ci sarebbe esperienza vera e propria, tutt’al più ci sarebbe esperimento scientifico, e il soggetto che sperimenta sarebbe la cavia. Il soggetto dell’esperienza deve scegliere egli stesso l’esperienza, e la deve scegliere in una condizione in cui non è possibile alcuna scelta, perché non c’è ancora né chi possa scegliere né la cosa da scegliere.
L’esperienza è quel movimento in cui l’immediato, il non sperimentato, cioè il relativo, si viene alienando.
Che cos’è il relativo?
Il relativo, chiarisce Heidegger (44), è un sapere relatum, ma non semplicemente in quanto riferito-a, è relatum – riferito – a ciò che sa, e che, condotto aldilà di ciò che sa, resta sapendo presso il saputo, lo sa appunto in modo tale che si lascia trattenere dal saputo – sapendo il saputo, sapendolo si dissolve in esso, si dà ad esso e così – sapendo – in esso si perde. È un sapere irretito e costretto nel suo saputo, là rimasto legato. Quando si scioglie e si distacca dal suo saputo e in quanto distaccato – assoluto – sarebbe tuttavia ancora sapere. Lo svincolarsi dal saputo non è un abbandonare il saputo, ma un superamento che conserva, uno svincolarsi che sa. La coscienza si scioglie dalle cose non appena sa di se stessa – in quanto coscienza, e sapendo se stessa diventa autocoscienza. Rimane aperta la questione di sapere– chiude Heidegger – se in questo sapere si è realmente compiuto questo distacco, oppure se anche questo sapere sia ancora coscienza, seppur autocoscienza.
Insomma, nell’esperienza, l’esperire è un perdersi nell’esperienza stessa, è un darsi completamente all’esperienza, è un esporsi nel quale si rischia sempre di perdersi, o nel quale (sembra suggerire Heidegger) si rimane sempre invischiati. Al mare si fa l’esperienza dell’acqua, ci si tuffa, e nonostante ogni cognizione libresca sulla profondità del fondate, sul principio di Archimede, eccetera, non sappiamo nulla di noi e dell’acqua. La paura che ci coglie prima del salto non è una nostra paura, piuttosto siamo noi – se c’è un noi – ad essere nella mani della paura. Una volta tuffati, la paura ci restituisce il corpo, e sentiamo l’acqua, il fondale, il freddo, ma non lo sentiamo come un nostro sentimento, lo sentiamo con un ritmo e un percuotere, come un mancamento di ossigeno, un battito accelerato, un annegare o uno stare a galla, un muoversi delle leve, uno sprofondare e riemergere, eccetera. Una volta a riva, dell’acqua rimane l’esperienza passata, tolta, vissuta, superata, interiorizzata – l’aufhebung dall’acqua.
Solo ciò che regge alla prova di questa dialettica, dice Adorno, in questa stessa dialettica giunge alla propria verità. Sa se il nuoto è o non è fatto per lui.
La descrizione dell’alienazione fornita da Adorno mostra delle differenze rispetto a quella fornita da Heidegger. Non si può giustificare una certa mancanza di rigore o di precisione adducendo il fatto che Terminologia filosofica riporta il testo orale di lezioni tenute a Francoforte nel 1963, perché anche il testo di Heidegger sulla Fenomenologia è il rapporto di lezioni tenute a Friburgo all’inizio degli anni Trenta.
Solo chi accetta la sfida dell’esperienza, dice Adorno, fa esperienza della verità; chi, invece, difende la propria integrità rifiutando ogni rapporto con quello che potrebbe minacciarla non fa esperienza della verità. È evidente che questa descrizione presuppone ciò che si ritrova alla fine dell’esperienza, cioè il soggetto dell’esperienza.
Come è possibile l’esperienza, senza soggetto dell’esperienza?
Il soggetto dell’esperienza si forma nell’esperienza. Su questo non c’è alcun dubbio. Non c’è, prima dell’esperienza, un soggetto che si mette alla prova.
La prova corrisponde all’esperimento scientifico. L’esperimento scientifico forza l’esperienza entro uno schema. Essa presuppone, da una parte, già bello e formato il soggetto dell’esperienza, e, dall’altra, anch’esso formato, il contenuto dell’esperienza. Per cui si tratta solo di verificare la corrispondenza tra ciò che il soggetto sa e ciò che l’oggetto supposto è. L’oggetto, come dice Adorno, è ipostatizzato, è reificato. Il rapporto che si forma nell’esperienza viene trasformato in una cosa, la cosa dell’esperimento scientifico. Il nuoto non risiede fuori dall’esperienza con l’acqua. Tuffarsi, imparare a nuotare, non consiste in un sapere che viene verificato (sperimentato) tuffandosi in acqua: se si va affondo il sapere è contraddetto dalla realtà; se si rimane a galla il sapere è confermato dalla realtà. La realtà effettiva corrispondente all’esperienza del nuoto, si forma a partire dal tuffo, non esiste una realtà effettiva pre-formata che starebbe lì in attesa di confermare il tuffo. Questo è lo schema reificato della scienza positiva, schema che non corrisponde all’esperienza così come è intesa da Hegel.
Alienazione non significa sperimentare il non-io – il mondo – per appropriarsene, per interiorizzarlo. E nemmeno mettere l’io alla prova del non-io. La manifestazione dell’io e del non-io si produce a partire dalla scissione – dice Hegel. La scissione è l’alienazione mediante la quale l’uno diventa due, l’Assoluto si fa strada nella storia e si perde o si lega all’altro.
L’alienazione non corrisponde a ciò che Adorno chiama reificazione, perché la reificazione presuppone la scissione e dunque l’alienazione. Solo a partire dall’alienazione il soggetto può porre il non-io come un dato, e fare di questo dato l’oggetto che ritorna identico in ogni esperimento, ovvero l’oggetto reificato della scienza positiva.
La reificazione, dice Adorno (Dialettica negativa, 338), è la riduzione a identità, è ciò che avviene nello scambio. Il principio di scambio, ovvero la riduzione del lavoro umano all’astratto concetto universale del tempo di lavoro impiegato mediamente, è l’antenato del principio identificante. Nello scambio il principio di identità ha il suo modello sociale, e lo scambio non ci sarebbe senza di esso. Grazie allo scambio singole entità e prestazioni non identiche divengono commensurabili, identiche. La diffusione di questo principio obbliga il mondo intero all’identico, alla totalità. Tuttavia, se questo principio venisse negato astrattamente; se si annunciasse come ideale che per il più alto onore dell’irriducibilmente qualitativo non si debba più scambiare alla pari, ciò sarebbe un pretesto per la ricaduta nell’antica ingiustizia. Infatti, lo scambio di equivalenti è consistito da sempre nello scambiare in suo nome il diseguale, nell’appropriare il plusvalore del lavoro. Se si annullasse semplicemente la categoria di misura della comparabilità, al posto della razionalità comparirebbero l’appropriazione immediata, la violenza, oggigiorno: il nudo privilegio di monopoli e cliques. La critica al principio di scambio in quanto principio identificante del pensiero vuole che si realizzi l’ideale di uno scambio libero ed equo, sino a oggi solo un pretesto. Solo questo potrebbe trascendere lo scambio. Se la teoria critica lo ha svelato come scambio dell’uguale e tuttavia del diseguale, allora la critica della disuguaglianza nell’uguaglianza mira anche all’uguaglianza, pur con tutto lo scetticismo contro il rancore nell’ideale borghese ugualitario, che non tollera niente di qualitativamente diverso. Se non venisse più sottratta a nessun uomo una parte del suo lavoro vivo, si raggiungerebbe l’identità razionale e la società oltrepasserebbe il pensiero identificante.
Perciò, dice Adorno (142), proprio in quanto non si schiera per l’immediatezza e contro lo scambio, perché significherebbe ricadere nella barbarie, la dialettica negativa è legata, come al suo punto di partenza, alle massime categorie della filosofia dell’identità. Pertanto resta anch’essa falsa, logico-identitaria, lo stesso contro cui viene pensata. Essa deve correggersi nel suo procedere critico che modifica i concetti da essa trattati formalmente come se per lei fossero ancora i primi.
In particolare, la dialettica negativa deve tener conto che il non identico non si può conquistare a sua volta direttamente come un positivo e neanche attraverso la negazione del negativo. Considerare la negazione della negazione uguale alla positività è la quintessenza dell’identificare, il principio formale ridotto alla sua forma più pura. Con esso nel cuore della dialettica prende il sopravvento il principio antidialettico, quella logica tradizionale per la quale more arithmetico meno per meno fa più. Essa venne presa in prestito da quella matematica contro cui Hegel per il resto reagisce idiosincraticamente. Nella dialettica negativa il positivo potrebbe essere solo la negazione determinata.
XXIX
L’Illuminismo è la fuoriuscita dell’uomo dallo stato di minorità. Esso ha avuto da sempre l’obiettivo di togliere agli uomini la paure e di renderli padroni (Dialettica dell’illuminismo, 11 e seguenti). Il suo programma era di liberare il mondo dalla magia e dalla superstizione. Tramite la scienza il mondo doveva essere liberato dal mito. La natura doveva essere conosciuta mediante l’esperienza diretta, doveva rispondere alle domande che l’uomo gli poneva, senza dar prova essa stessa di saper parlare, di sottendere un linguaggio, una sostanza, un mana suoi propri.
All’inizio dell’illuminismo c’è il programma di Bacone di un connubio tra l’intelletto umano e la natura delle cose, ma si tratta di un programma patriarcale. L’intelletto che vince la superstizione deve comandare alla natura disincantata. Ma la conoscenza non tende alla felicità, tende al metodo, e il metodo è lo strumento usato per lo sfruttamento altrui. Tutte le scoperte sono strumenti. Ciò che gli uomini vogliono apprendere è come utilizzare la natura ai fini di un dominio integrale. Tutto conduce all’odierno trionfo dei fatti. La sterile felicità del conoscere è lasciva. Ciò che conta è il procedimento efficace, l’operation. La causa stessa, come ultimo residuo e secolarizzazione del principio creatore, è stata sostituita dalla regola e dalla probabilità statistica, dal campione e dal sondaggio. Nella pretesa degli universali si crede ancora di scorgere la paura dei demoni. Nella materia non deve esservi vista alcuna forza immanente o qualità sottesa o occulta. La regola deve riceverla da fuori, dal calcolo, e ciò che non si piega ad esso deve essere guardato con sospetto. Tuttavia, ciò che non si piega – e questo è il tratto caratteristico dell’illuminismo – non fa che aumentarne la forza. Ciò deriva dal fatto che, si legge nella Dialettica, l’illuminismo riconosce se stesso anche nei miti. Tutto ciò a cui ricorre la resistenza, e ciò a cui ricorre non può che essere un mito, altrimenti sarebbe l’illuminismo, per il solo fatto di diventare in questo conflitto argomento, rende omaggio al principio della razionalità che essa rimprovera all’illuminismo. L’illuminismo è totalitario. Sa trarre profitto anche da ciò che ne contesta apertamente la razionalità, per esempio dagli oroscopi pubblicati sulle riviste patinate. Perché, alla fin fine, tutte le figure mitiche sono riducibili, secondo l’illuminismo, allo stesso denominatore, e cioè il soggetto. Strumento di tutte queste operazioni è la logica formale. Essa offre lo schema della calcolabilità universale. Il numero diviene il canone dell’illuminismo. Le stesse equazioni dominano la giustizia borghese e lo scambio delle merci. La società borghese è dominata dall’equivalente. Essa rende comparabile l’eterogeneo, riducendolo a grandezze astratta. Tutto deve risolversi in numero. L’illuminismo riconosce apriori, come essere ed accadere, solo ciò che si lascia ridurre a unità. Il suo ideale è il sistema, da cui si deduce tutto e ogni cosa. La sua fissa è trovare le contraddizione e risolverle, raddrizzare lo storto. Unità è la parola d’ordine – da Parmenide a Russel. Si continua a esigere la distruzione degli dèi e delle qualità.
Il mito, d’altra parte, voleva raccontare l’origine, e dunque fissarla, nominarla, dominarla. In esso la spiegazione diventa dottrina, e la dottrina rituale. Al posto delle pratiche esoteriche, degli spiriti e dei demoni, subentra il cielo con la sua gerarchia, dove gli dei non si confondono più con la materia e le sostanze, ma le significano. Gli dèi, si legge nella Dialettica (16), si separano dagli elementi come essenze dei medesimi. L’essere si scinde in 1) logos, che si riduce alla monade e al mero punto di riferimento, e 2) nella massa di tutte le cose e creature esterne. Senza riguardo alle differenze, il mondo viene sottomesso all’uomo. In ciò concordano la storia ebraica della creazione e la religione olimpica. Ma questa sottomissioni passa per l’alienazione. L’emergere del soggetto è pagato col riconoscimento del potere come potere di Dio. La somiglianza dell’uomo con Dio consiste nella sovranità sull’esistente, nello sguardo padronale, nel comando.
Siamo ancora all’interno del racconto hegeliano: Manifestarsi e scindersi è una cosa sola.
In uno scritto giovanile – Lo spirito del cristianesimo e il suo destino –, per spiegare il passaggio dall’istinto alla ragione, Hegel usa la figura del diluvio.
All’inizio l’uomo era tutt’uno con la natura. Il diluvio (Noè) rompe questo idillio. La natura sarà ora nemica, un nuovo rapporto dovrà essere instaurato.
Affinché l’uomo potesse tenere testa alle aggressioni della natura ormai ostile – dice Hegel – questa doveva essere dominata, e dal momento che il tutto diviso in due non può essere diviso che in idea e effettività, la più alta unità di dominio è o nell’essere-pensato o nell’essere-effettivo.
Per dominare l’ostilità della natura era necessario pensarla, concepirla, afferrarla. La ragione si ingegna intorno ad una ferita. La scissione fornisce dapprima la manifestazione del logos nell’altro, quest’altro è Dio.
Dio è potenza, l’uomo è fatto a immagine di Dio, dunque l’uomo è potenza. Il potere dell’uomo appare, e non può non apparire, come potere di Dio. Solo in quanto è fatto a immagine di Dio, l’uomo consegue l’identità, e come correlato riceve la natura squalificata a caos
Il mito si converte in illuminismo, il potere dal cielo si trasferisce sulla terra. La teologia si converte in antropologia. Ciò che rimane è la reificazione.
L’uomo paga l’accrescimento del suo potere (Dialettica 17) con l’estraneazione da ciò su cui lo esercita. L’illuminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli uomini. Lo scienziato conosce le cose in quanto è in grado di farle. Nella trasformazione l’essenza delle cose si rivela ogni volta come la stessa: come sostrato del dominio. Questa identità fonda e costituisce l’unità della natura. Nella magia la sostituibilità è specifica. Un fabbro si sostituisce con un fabbro. Un mago con un mago. Un agnello con la vittima sacrificale. Tra il sostituito e ciò che lo sostituisce deve sussistere un minimo di relazione, come tra il simbolo e la cosa simbolizzata.
Il simbolo (Saussure) ha per carattere di non essere mai completamente arbitrario. Non è vuoto, implica un rudimento di legame naturale tra il significante e il significato. Il simbolo della giustizia, la bilancia, non potrebbe essere sostituito da qualsiasi altra cosa, per esempio un carro. Al contrario, il segno (si suppone) essere arbitrario. Per significare la giustizia va bene un segno qualsiasi (Gerechtigkeit, Teisingumas, Justice, eccetera).
Nel sacrificio umano non c’è sostituzione. Nella sostituzione dell’uomo con l’agnello, l’animale doveva ancora avere qualità specifiche, anche se esso rappresentava ormai la specie, aveva già l’accidentalità arbitraria del campione. A ciò mette fine la scienza (Dialettica, 18). Non c’è, in essa, sostituibilità specifica. La sostituibilità si rovescia in fungibilità universale. Nella fabbrica moderna un operaio di carpenteria si sostituisce con un operaio generico. Al lavoro sans phrase corrisponde l’oggetto d’uso sans phrase, entrambi pienamente sostituibili, perché nello scambio capitalista essi mediano estremi (D-M-D’) – e in quanto medio va bene ogni cosa.
Il mondo della magia, si legge in Dialettica, conteneva ancora differenze, le cui tracce sono sparite. Le molteplici affinità fra ciò che è vengono scacciate dall’unico rapporto fra il soggetto datore e l’oggetto privo di senso, fra il significato razionale e il portatore accidentale di esso.
La magia è, come la scienza, rivolta a scopi, ma li persegue mediante la mimesi, non in un crescente distacco dall’oggetto.
Affinché le pratiche localizzate dello stregone cedessero il posto alla tecnica industriale universalmente applicabile, era prima necessario che i pensieri si rendessero indipendenti dagli oggetti, come avviene nell’Io conforme alla realtà.
Questa indipendenza viene prodotta nello scambio. Siccome lo scambio affonda le sue origini nella notte dei tempi, e siccome Adorno identifica il male assoluto con questa separazione, fa arretrare il conflitto borghese alla notte dei tempi, lasciando in secondo piano il conflitto di classe.
La razionalità borghese (anzi, il ragionamento in genere) non essendo più mimetica e simbolica, rendendo superflua ogni corrispondenza tra il significato e il significante/referente, producendo gli strumento e il metodo per una fungibilità universale, rende tutto sostituibile con tutto. Poiché ogni cosa vale come ogni altra, ergo, niente ha più valore in sé, per quello che è, per ciò che di specifico ha. Non conta nulla chi tu sia. La tua storia non vale, il tuo presente non c’entra, la tua formazione neppure, contano i numeri, e tu sei un numero tra gli altri, vali come un altro – qui sta il grande imbroglio, la grande fregatura, la grande ingiustizia, le negazione assoluta della differenza, delle qualità, dell’unicità irripetibile.
Su questo punto la distanza tra Derrida e Adorno è enorme.
Per Adorno si giunge ad un completo distacco dall’oggetto. Per Derrida questo distacco completo è impossibile.
Mentre per entrambi il metafisico – il razionale, il sovrasensibile, l’astratto, eccetera – comporta una riduzione delle differenze qualitative, per Derrida questa riduzione, per via del fatto che l’elemento materico, corporeo, fisico, effettivo, non può mai essere completamente eliminato, questa riduzione non è mai totale; ogni tentativo di totalizzare il corporeo non fa altro che riprodurlo, estendendone l’influenza – ogni riduzione della differenza corrisponde ad una sua estensione. Al contrario, Adorno crede che il razionale possa avere ragione del corporeo, che, addirittura, il razionale possa liberare la sua furia totalitaria, come nel Terrore – hegeliano. Per Derrida in ogni segno rimane sempre un residuo simbolico ineliminabile. E siccome questo resto non può essere eliminato, il totalitarismo non può averla vinta. Ciò non significa che non bisogna difendersi. Anzi. Significa proprio che c’è possibilità di fendersi, che la possibilità è interna, si dà senza uscire dall’assoluto. Mentre Adorno è costretto ad uscire dall’assoluto e suppor una natura, uno stato adamitico, un corpo, eccetera, che si vedrebbero azzerati dalla ragione, ragione alla quale non si può rinunciare, perché ogni difesa di questo stato adamitico ricaccia nella ragione – dunque, si può solo appellarsi a questo stato adamitico, anche se si è stra-convinti che non c’è pezza, non c’è storia, non c’è futuro per questo stato adamitico, perché tutto ciò che viene in contatto col logos, diventa logico, compreso l’adamitico, al quale Adorno stesso si appella – da qui il suo pessimismo. La logica è totalitaria, non c’è modo di uscire dalla logica – ogni tentativo di uscita ricaccia in essa – e appellarsi ad altro, non serve a nulla, perché è sempre irrimediabilmente l’altro del medesimo.
Ciò che potrebbe essere altrimenti viene livellato – Dialettica, 20.
Cosa potrebbe essere altrimenti?, visto che ciò che è altrimenti – il transeunte – per accedere all’essere, non può non essere livellato. Ameno che, come sostiene Derrida, il livellamento non sia così tanto efficace e totalitario come suppone Adorno.
Non solo le qualità vengono dissolte nel pensiero, ma gli uomini sono costretti alla conformità reale – Dialettica, 20.
Non c’è conformità reale che non sia anche difformità.
L’uomo riceve un Sé diverso, ma siccome non si livella perfettamente, il liberalismo ricorre alla costrizione. L’uomo efficiente deve essere conforme allo stampo, non si può pretendere di produrre una società efficiente se non ci si sottomette alle regole e agli standard, se non si è della pezzatura idonea ad entrare nel packaging. Dunque, dice Adorno, il fascismo non è una ricaduta nell’antica barbarie, ma il trionfo dell’uguaglianza repressiva, il dispiegarsi effettivo dell’uguaglianza giuridica.
È questo il corso della civiltà europea. L’astrazione, lo strumento dell’illuminismo, realizza il dominio livellatore dell’astratto, rendendo con l’industria e con l’ingegno tutto ripetibile nella natura.
Il distacco del soggetto dall’oggetto – la scissione hegeliana -, premessa dell’astrazione, è fondato sul distacco dalla cosa, a cui il padrone perviene mediante il servo.
Con la fine del nomadismo – qui inizia la filosofia della storia di Adorno – l’ordine sociale si è costituito sulla base della proprietà stabile. Dominio e lavoro si separano, compaiono il Padrone e il Servo hegeliani.
Il padrone, libero dalla pastoie della vita pratica, può pensare e accedere all’universale, perché l’universale è qualcosa di semplice che si ottiene per via di negazione, e che non è né questo né quello, un non-questo, e che è anche altrettanto indifferente ad essere sia questo che quello. Liberandosi della vita pratica il padrone si libera del questo e del quello, dell’adesso e del dopo, per accedere al qui e ora universali – astratti, cioè tratti fuori dalle beghe della vita pratica transeunte. Intanto il servo (come la donna) rimane invischiato nella cose del mondo, non alza la testa al cielo, non si eleva all’universale. Dunque, l’universale astratto si realizza sulla pelle del servo (e della donna di servizio), si realizza come dominio effettivo.
La scissione tra soggetto e oggetto duplica la scissione tra servo e padrone che duplica, a sua volta, la scissione tra azione (actus) e potenza (potentia), tra animato e inanimato, e se il mana, lo spirito, si trova nell’albero e dalla parte della materia, l’illuminismo l’esorcizza, perché ha paura della materia animata. Non deve esserci più nulla fuori – alienato -, la semplice idea di un fuori è la forma genuina dell’angoscia (Dialettica 23). Il simbolo, partecipe ancora del mondo sensibile e sovrasensibile, deve lasciare il posto al segno. Come segno, il linguaggio deve limitarsi ad essere calcolo. Per conoscere la natura, deve abdicare alla pretesa di somigliarle, e per somigliarne, per esserne copia, deve abdicare alla pretesa di conoscerla.
L’illuminismo è totalitario, ma non per ciò che i romantici gli hanno sempre rimproverato – metodo analitico, riduzione agli elementi, riflessione dissolvente – ma perché decide tutto in anticipo. Nell’operazione matematica il futuro diventa incognita di un’equazione che lo bolla come arcinoto prima ancora che ne venga determinato il valore. Anticipando col calcolo il futuro, l’illuminismo si ritiene al riparo dal ritorno del mito. Formalizzando il processo logico la matematica lo reifica, la macchina diviene il suo sostituto perfetto e infallibile. Ma nella riduzione del pensiero ad apparato matematico si sancisce la riduzione del pensiero a ciò che è dato. Si dà ragione a ciò che è di fatto, la conoscenza si limita alla sua ripetizione, il pensiero si riduce a tautologia, e il mondo ad un gigantesco giudizio analitico. La natura, vista come l’assoluto pericolo, e il comportamento mimetico, mitico e metafisico che dalla natura pretendono un rapporto di continuità e prossimità, devono essere esorcizzati. Il pericolo è di ricadere al livello del terrore naturale dal quale ci si era estraniati con immenso sforzo e enormi mutilazioni. L’umanità ha dovuto sottoporsi a un trattamento spaventoso, perché nascesse e si consolidasse il Sé, il carattere identico, pratico, virile dell’uomo (Dialettica, 41). Ma il canto delle sirene si avverte ancora, e più il suono è forte, più l’irresistibile promessa di piacere si fa sentire, più cresce l’angoscia di perdere il Sé, e di annullare, con il Sé, il confine tra se stessi e il resto della vita, di tornare ad essere tutt’uno nell’indifferenziato. Chi vuol durare e sussistere, non deve porgere ascolto al richiamo dell’irrevocabile, e può farlo solo in quanto non è in grado di ascoltare. A ciò la società ha provveduto da sempre. Freschi e concentratati, i lavoratori devono guardare in avanti, e lasciar stare tutto ciò che è a lato. L’impulso che li indurrebbe a deviare va sublimato – con rabbiosa amarezza – in ulteriore sforzo. Essi diventano pratici, diventano servi. L’altra possibilità è quella che sceglie Ulisse – il Padrone – che fa lavorare gli altri per sé. Egli ascolta, ma impotente, legato all’albero della nave, e più la tentazione è forte, e più strettamente si fa legare, così come, più tardi, anche i borghesi si negheranno più tenacemente la felicità quanto più – crescendo la loro potenza – l’avranno a portata di mano. I servi riproducono, con la propria vita, la vita del Padrone oppressore, che non può più uscire dal suo ruolo sociale. Gli stessi vincoli con cui si è legato alla prassi, tengono le Sirene lontane dalla prassi: la loro tentazione è neutralizzata a puro oggetto di contemplazione, ad arte. L’incatenato assiste a un concerto, immobile come i futuri ascoltatori, e il suo grido appassionato, la sua richiesta di liberazione, muore già in un applauso.
La divisione del lavoro è all’opera e il mondo contrappone lavoro manuale a lavoro intellettuale, servi a padroni. Il liberalismo e lo spirito borghese si inoltrano molto più in là di quanto immagini la concezione storica che data il concetto di borghesia solo dalla fine del feudalesimo medievale (Dialettica, 52).
—
* Terminologia filosofica (I, 62): La stessa espressione «gruppo» non ha carattere rigorosamente logico, ma è un’espressione più o meno occasionale; vale a dire che nel linguaggio parlato e vivo non ha affatto un significato così stabile. Possiamo così parlare di un gruppo di persone che fra le nove e le dieci di sera guardano la televisione, o di un gruppo che dimostra davanti al consolato del Ghana per qualche motivo, o di un qualche altro gruppo, senza che ciò contraddica a questo concetto.
** La citazione della Fenomenologia che appare nel testo di Heidegger (La Fenomenologia dello spirito di Hegel, Guida, p. 54) è tradotta da Eugenio Mazzarella seguendo quasi alla lettera il testo della traduzione di Enrico de Negri (Nuova Italia, I, 29). Le differenze con la traduzione di Cicero (Bompiani, 91), sono notevoli. In particolare, la differenza più rilevante riguarda proprio la parola alienazione. Nel testo tedesco della Fenomenologia appare il termine Entfremdung, che Cicero traduce correttamente (?) con Estraneazione. Nella traduzione inglese del testo di Heidegger (non sono riuscito a reperire una versione tedesca) il passo della fenomenologia è tradotto così: “And experience is precisely the name we give to this movement, in which the immediate, the unexperienced, i.e., the abrtact {relative}, becomes alienated from itsel and then returns to itsel from out of this alienation, is only then revealed for the first time in its actuality and truh, and becomes also a property of consciousness”.
Da notare anche la differenza nella traduzione di Wirklickeit, De Negri sceglie un problematico effettualità, Cicero opta per un più pragmatico realtà (io preferisco sommare i due termini: realtà effettiva). Nella traduzione inglese Wirklickeit viene reso con actuality, termine che rimanda alla distinzione medievale (dunque aristotelica: dynamis – energheia), tra Actus e Potentia, come si legge anche sull’oxforddictionaries.com: Late Middle English (in the sense ‘activity’): from Old French actualite or medieval Latin actualitas, from actualis ‘active, practical’, from actus.
Anche in italiano rimane traccia di questo uso medievale-aristotelico nel termine Attualità, come di ciò che è effettivamente accaduto di recente. Mentre reale – rimandando a res, che include anche il non effettuale – creerebbe, ma solo in ambito specialistico, confusione.
L’alienazione di Adorno