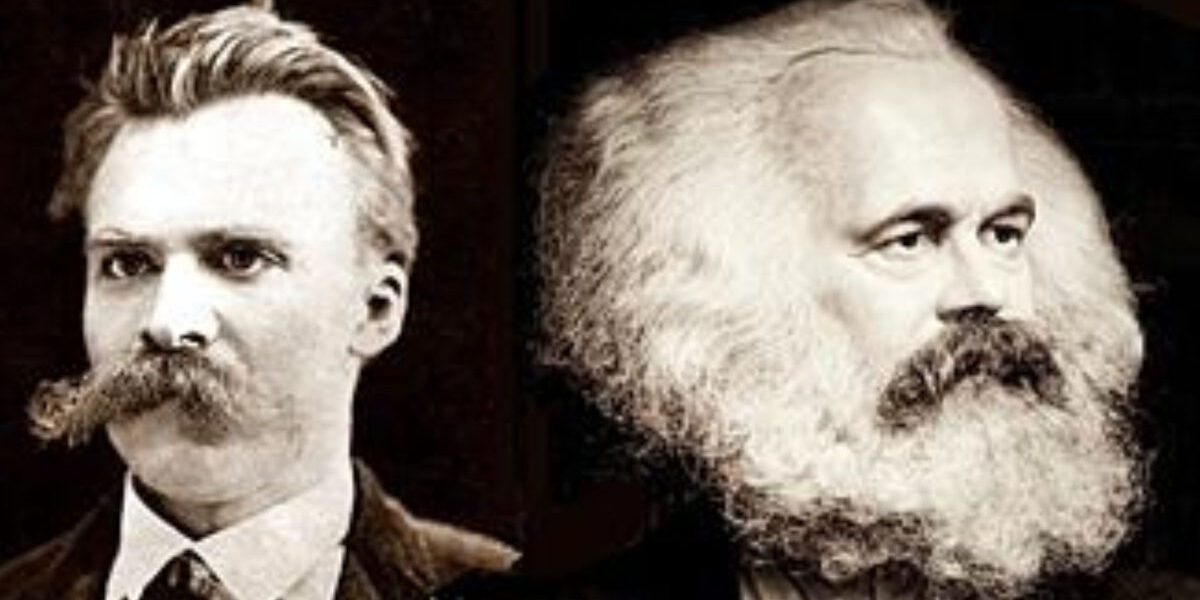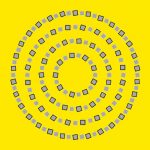I
Nietzsche(1) non è un pensatore della Differenza. Che Nietzsche non parta dalla Differenza tra Forte e Debole, Aristocratico e Plebeo, Piacere e Dispiacere, eccetera, oppure, tra Causa ed Effetto, Libertà e Necessità, etc, è smentito in Al di là del bene e del male – a partire dal titolo.
Il difetto del pensiero della Differenza, dice Nietzsche, sta in ciò: che si finisce per porre Atomi a sostegno dei Differenti – ovvero delle Sostanze – si finisce nella Metafisica.
Un pensiero – scrive in Aldilà, 17 – viene quando è «lui» a volerlo. [E non quando lo vuole un «io penso», in quanto subjectum, sostrato, sostanza].
Un pensiero viene quando è «lui» a volerlo e non quando «io» lo voglio; cosicché è una falsificazione dello stato dei fatti dire: il soggetto «io» è la condizione del predicato «penso». [Le virgolette e i corsivi sono di Nietzsche, e hanno il loro peso, evidenziano la raffinata precauzione di Nietzsche].
Esso pensa [in corsivo. Nemmeno il flebile «esso», l’impersonale «esso» va bene, perché mira sempre a una sostanza, dunque anche «esso» è una falsificazione dello stato dei fatti.
Come cavarsi fuori da questo pasticcio se anche «Esso» rimanda ad una sostanza, falsificando lo stato dei fatti?
[Non ci si cava fuori dall’impaccio in alcun modo, se non segnalando che «Esso» è una falsificazione, e che non si può fare a meno delle falsificazioni se si vuol denunciare la falsificazione, etc – bisogna assumersi la responsabilità, dice Nietzsche, di questa falsificazione. Bisogna imporre il concetto. La Legge morale, dice (Umani I, 40), è una menzogna necessaria per non essere sbranati].
Già con questo «esso pensa» si è fatto anche troppo – scrive: già questo «esso» contiene un’interpretazione» del processo stesso. [Questo «esso pensa» contiene un’interpretazione, ovvero appartiene ai sintomi – è successivo, si apre a partire da qualcosa che lo precede.]
Si conclude a questo punto, secondo la consuetudine grammaticale: «Pensare è un’attività, a ogni attività compete qualcuno che sia attivo, di conseguenza…». Pressappoco secondo uno schema analogo il più antico atomismo cercava, oltre alla «forza» che agisce, anche quel piccolo conglomerato di materia in cui essa risiede, da cui promana la sua azione, l’atomo; cervelli più rigorosi impararono infine a trarsi d’impaccio senza questo «residuo terrestre» e forse un bel giorno ci si abituerà ancora, anche da parte dei logici, a cavarsela senza quel piccolo «esso» (nel quale si è volatilizzato l’onesto, vecchio io).
Pensare non è nemmeno un’attività – attività intesa in questo caso come attività di qualcuno – di una sostanza. A questo livello non ci sono attività e passività. Non ci sono forze e controforze. Le opposizioni – le Differenze – di ogni tipo, sono interpretazioni, sono concetti, anche quando puntano a un residuo terrestre.
Questo qualcosa a cui allude Nietzsche – che non è né una cosa, né un nulla – precede i Differenti o la Differenza. Non c’è «opposizione» tra positivi prima di questa cosa. L’opposizione è un’interpretazione – un sintomo di questa cosa inconscia. Di questo pensiero inconscio.
Qui Nietzsche è più sottile di Freud – e ne anticipa tutto il quadro che si trova, per esempio, in Aldilà del principio di Piacere.
Prendiamo la Volontà. Il Volere, scrive Nietzsche (Aldilà, 19), mi sembra soprattutto qualcosa di complicato, qualcosa che soltanto come parola rappresenta un’unità, – e appunto nell’uso di un’unica parola si nasconde il pregiudizio del volgo, che ha prevalso sulla cautela dei filosofi, in ogni tempo esigua.
La volontà, quando la si consideri come spinta (Trieb), come pulsione o istinto, non è mai un atomo, una sostanza. L’inconscio non è una sostanza – non è l’inconscio di qualcosa o di qualcuno. Qualcosa e qualcuno – i Differenti – sono sintomi dell’inconscio.
La volontà è qualcosa di complicato – dice Nietzsche. Complicato qui non vuol dire intricato, oscuro, enigmatico, da decifrare. La volizione – l’inconscio – è innocente. Ha innocenza dell’avvenire. È un sapere che non sa – una sorta di sapere-no. Per riferirsi a questo inconscio, che precede i Differenti, e precede anche la Volontà come sostanza, Nietzsche parla di enigma e di segreto.
Il segreto non è ciò che, una volta decifrato, rivela un qualcosa, un «che cosa». Segreto è ciò che è piatto, alla luce del sole, positivo, chiaro. È ciò che non ha nulla da nascondere. L’Enigma è che non ci può essere enigma là dove non c’è segreto. E dove non c’è segreto non c’è inconscio, inconscio da decifrare o interpretare. L’interpretazione dell’Inconscio è un sintomo di questo inconscio che è l’inconscio di nessuno, inconscio alla luce del sole, senza segreto. Se ne accorse Freud quando, cercando un linguaggio per decodificare l’inconscio, si rese conto che questo linguaggio doveva essere, di diritto, inconscio.
Non c’è segreto dove non ci sono i Differenti. Ci sono i Differenti dove c’è segreto. Non è una contraddizione. Ci sono due tipi di segreto. Come ci sono due tipi di differenza. Una «precede» l’altra – metto «precedere» tra virgolette, perché non ha alcun senso, in questo caso, parlare di precedenza: la precedenza è prospettica, allude sempre a un prima e a un dopo, dunque a una coppia di Differenti.
In ogni volere (in ogni spinta volitiva) – dice Nietzsche – c’è in primo luogo una molteplicità di sensazioni, vale a dire la sensazione dello stato da cui ci si vorrebbe allontanare, la sensazione dello stato a cui ci si vorrebbe avvicinare, la sensazione di questo stesso «allontanarsi» e «tendere», quindi anche una concomitante sensazione muscolare, la quale, pur senza che si metta in movimento «braccia e gambe», comincia il suo gioco mercé una specie di abitudine, non appena noi «vogliamo».
Ma non siamo noi a Volere. Non c’è alcun Volere. Nessuna meta cui tendere, nessuno scopo. Non c’è Voglia di… Non c’è sensismo che tenga. Il sensismo si dispiega a cose fatte, a partire da un pensiero della Differenza. Anche qui i corsivi e le virgolette sottolineano l’inadeguatezza del linguaggio nel descrivere il segreto e l’inconscio. Non c’è allontanarsi, avvicinarsi, non ci sono braccia e gambe se non a partire dai Differenti, ma qui siamo in un stadio che anticipa (o forse segue) i Differenti, che comunque non ha nulla a che vedere con essi.
In Gaia Scienza (360) Nietzsche aveva già precisato che c’è un quantum di energia accumulata, e che questo quantum può essere attivato attraverso uno scopo, all’interno di un ordine della Differenza. Oppure può essere attivato da qualcosa di interamente irrilevante, se commisurato a questo quantum di energia, perlopiù, dice Nietzsche, una piccola circostanza fortuita, conformemente alla quale quel quantum alla fine si «sprigiona» in un’unica determinata maniera: il fiammifero in rapporto al barile di polvere.
Le virgolette intorno a «sprigionare» sottolineano l’inadeguatezza di ogni linguaggio – linguaggio che si trascina dietro tutta la metafisica – inadeguatezza a descrive questo stato enigmatico chiamato qui quantum energetico.
Il fiammifero non è in mano allo scopo, è in mano al caso. Il quantum energetico è la differenza che precede ogni Differenza. C’è uno stadio della Differenza, in cui accendo il fuoco per una ragione, e c’è uno stadio della differenza dove è il fuoco ad accendere me.
Tra queste piccole circostanze fortuite e tra i fiammiferi, continua Nietzsche, annovero tutti i cosiddetti «scopi», così pure le ancor più cosiddette «vocazioni di vita»: essi sono relativamente gratuiti, arbitrari, quasi indifferenti in rapporto all’enorme quantum di energia che fa pressione per essere in qualche modo consumato.
D’ordinario, dice, [secondo una impostazione teo-teleo-logica] si considera tutto questo diversamente: secondo un secolare errore si è abituati a vedere proprio nell’obiettivo (scopo, vocazione, ecc.) la forza propulsiva – ma esso è soltanto l’energia direttiva, si è scambiato a questo riguardo il pilota della nave col vapore. E nemmeno sempre il pilota, l’energia direttiva… L’«obiettivo», lo «scopo», non sono molto spesso nient’altro che un sotterfugio per mascherare, un auto-accecamento a posteriori della vanità, riluttante ad ammettere che la nave segue la corrente in cui è incappata per caso? Che «vuole» andare verso quel punto, perché è verso quel punto che – deve andare? Che ha sì una direzione, ma – nient’affatto un pilota?
Tutti i corsivi sogno degli allert!, degli avvisi. Attenzione: la grammatica si trascina dietro la metafisica, ogni nome richiama una sostanza, ogni nome è un sostantivo, ogni verbo rimanda a un agente. Ma qui non c’è nessun agente. C’è una necessità, ma non c’è uno scopo.
La destinazione, si legge in Umano I (Prefazione, 7), dispone di noi, anche se non la conosciamo ancora; è il futuro che dà la regola al nostro oggi. C’è una forza che ci trascina verso una destinazione e questa forza non siamo noi. Non c’è Differenza a questo livello. E, a rigore, non si potrebbe parlare né di segreto, né di enigma, né di inconscio. Perché tutti e tre questi termini sono sostantivi e si trascinano dietro la metafisica, dunque la logica binaria che la sostiene.
II
I problemi filosofici, scrive Nietzsche (Umani I, 1), riprendono oggi in tutto e per tutto quasi la stessa forma interrogativa di duemila anni fa: come può qualcosa nascere dal suo opposto, per esempio il razionale dall’irrazionale, ciò che sente da ciò che è morto, la logica dall’illogicità, il contemplare disinteressato dal bramoso volere, il vivere per gli altri dall’egoismo, la verità dagli errori? La filosofia metafisica, scrive, ha potuto finora superare questa difficoltà negando che l’una cosa nasce dall’altra e ammettendo per le cose stimate superiori un’origine miracolosa, che scaturirebbe immediatamente dal nocciolo e dall’essenza della «cosa in sé». Invece la filosofia storica, che non è più affatto pensabile separata dalle scienze naturali ha accertato in singoli casi che quelle cose non sono opposte, tranne che nella consueta esagerazione della concezione popolare o metafisica.
Dunque, a questo livello, in cui si colloca l’inconscio, non ci sono Differenti. Non c’è soggetto e oggetto, sensibile e intelligibile. La partizione è una partizione che appartiene alla Metafisica, ovvero a una struttura che si barcamena su questo inconscio.
Non si può essere nicciani e adoratori di Carl Schmitt. Il polarismo ingenuo che si presenta come geopolitismo, multipolarismo o sovranismo, decisionismo etc; questo polarismo piangione (vedi le pagine di Nomos della terra dove Schmitt piange per Guglielmo II che si avvia a chiedere asilo all’Olanda perché non riconosciuto lo justus hostis); questo polarismo, soprattutto il polarismo nostalgico alla Schmitt, che fa dire che il benessere di un tempo era dovuto alla guerra fredda, alla contrapposizione USA-URSS, o, in Italia, alla contrapposizione DC-PCI – non può appoggiarsi a Nietzsche, cercare in Nietzsche una sponda.
Nietzsche non si oppone o contrappone. Non entra nel gioco – in nessuna teoria dei giochi. Dice chiaramente (Aldilà, 32): L’origine di ogni azione non si trova nell’intenzione – nella decisione. Bisogna convincersi – decidersi – anzi, Nietzsche dice in modo molto preciso, bisogna avere il sospetto – bisogna convivere con il sospetto, dunque avanzare in modo cauto, e non può essere diversamente, pena la ricaduta nel decisionismo – bisogna avanzare zoppicando – bisogna lasciarsi condurre dal sospetto che nell’elemento non intenzionale sia riposto il suo valore decisivo e tutta la sua intenzionalità. Il sospetto – non l’intenzione. L’intenzionalità come continuazione, raffinamento, della non intenzionalità – non il suo contrario, ma la sua continuazione. L’amico: non l’opposto del nemico, ma la sua continuazione, il suo affinamento e sintomo.
Bisogna convincersi che dietro l’azione non c’è un Volere, la Volontà di un io, di un Soggetto, di un Amico o di un Nemico. Noi abbiamo fame, dice Nietzsche (Umano, I, 18), ma originariamente non pensiamo che l’organismo vuole essere conservato, quella sensazione sembra farsi valere senza motivo e scopo, essa si isola e si considera volontaria. Dunque: la credenza nella libertà della Volontà, nella sovranità della decisione, è un errore originario di ogni essere organico, antico come l’epoca da cui esistono in questo moti di logicità; la credenza in sostanze incondizionate e in cose uguali è del pari un errore originario altrettanto antico, di ogni essere organico.
Si prende il numero. La scoperta delle leggi dei numeri, dice Nietzsche (Umani I, 19), è stata fatta in base all’errore già in origine dominante che ci siano più cose uguali (ma in realtà non c’è niente di uguale), o che perlomeno ci siano cose (ma non ci sono «cose»). L’ammissione della molteplicità presuppone sempre già che ci sia qualcosa che si presenta come molteplice; ma proprio qui regna già l’errore, già qui fingiamo esseri e unità che non esistono. In tutte le determinazioni scientifiche noi calcoliamo sempre inevitabilmente con alcune grandezze false: ma, poiché queste grandezze sono perlomeno costanti, come ad esempio la nostra sensazione dello spazio e del tempo, i risultati della scienza acquistano lo stesso perfetto rigore e sicurezza nella loro reciproca connessione. Ci sentiamo ancor sempre costretti ad ammettere una «cosa», o «substrato» materiale che vien mosso, mentre l’intera procedura scientifica ha appunto perseguito il compito di risolvere in movimento tutto ciò che si presenta come una cosa (che è materiale): anche qui noi distinguiamo ancora con la nostra sensazione ciò che muove e ciò che è mosso e non usciamo da questo circolo, perché la fede nelle cose è fin dall’antichità connessa col nostro essere. Sentiamo l’unità, sentiamo il numero come unità. Già sempre il sentimento è riprese dalla metafisica. Sentiamo tornare nel numero la sostanza, l’identico, l’uguale, sentiamo la materia di cui le cose sono costituite come la stessa informe materia. Anche il sentire stesso non viene accolto più come un continuo trepidare, ma come una sensazione, per quanto complessa, ma riconducibile a unità, l’effettualità di ciò che si vive, della vita stessa, viene ricondotta a una causa. La presente causa viene dedotta dall’effetto e rappresentata secondo l’effetto, tutto ciò, dice Nietzsche, con straordinaria rapidità. Là dove ci sono fiumi con cento scaturigini e affluenti, viene vista una unità. Anche qui, dice Nietzsche, l’unità della parola – e del numero – non garantisce nulla per l’unità della cosa. Non c’è una cosa all’origine, non c’è nemmeno una molteplicità di cose. Il dentro e il fuori – la Differenza tra dentro e fuori – è alla base del concetto di molteplicità. Ma nell’immensità del cosmo non c’è alcun dentro e alcun fuori.
E tuttavia – e qui sta la grande distanza tra Nietzsche e il Romanticismo – è vero, dice (Umano I, 9), potrebbe esserci un mondo metafisico; l’assoluta possibilità di esso non può essere contestata, noi vediamo tutte le cose con la testa umana, e non possiamo tagliare questa testa. Anche quando avremo distrutto tutte le partizioni su cui si regge la metafisica, anche quando avremo mandato al macero l’intero mondo della filosofia, con le sue coppie predilette, quando si saranno scoperti i suoi metodi come il fondamento di tutte le religioni e mitologie esistenti, esse sono anche confutate! Dopo di che, dice Nietzsche, cosa resterebbe del mondo una volta tagliata la testa alla metafisica?
Che cosa, dice Nietzsche, ci costringe soprattutto ad ammettere che esiste una sostanziale antitesi di «vero» e «falso»? Anche qui niente opposizione, niente contraddizione – il vero è un sintomo del falso – e viceversa.
L’uomo si libera della religione e della superstizione, e va bene. Poi però, dice Nietzsche (Umano I, 20), è necessario un movimento all’indietro: egli deve capire la giustificazione storica, come pure quella psicologica delle rappresentazioni metafisiche, come pure quella psicologica di tali rappresentazioni, deve riconoscere come sia di là venuto il maggior progresso dell’umanità e come, senza un tale movimento all’indietro, ci si priverebbe dei migliori risultati finora ottenuto dall’umanità. Riguardo alla metafisica filosofica, sempre più numerosi sono quelli che vedo giungere alla meta negativa (che ogni metafisica positiva è un errore). I più illuminati riescono solo a liberarsi della metafisica e a volgersi a guardarla con superiorità: mentre anche qui, come nell’ippodromo, al termine della dirittura è necessario girare. Ed è necessario perché la distruzione della metafisica ha il tratto del no – il tratto metafisico della negazione determinata. Non è una liberazione dalla metafisica, ma l’estrema dipendenza da essa.
III
È un errore che Nietzsche ascrive al suo romanticismo giovanile vedere dietro ogni azione un agente (Gaia, 370, Che cos’è il romanticismo?): E il mio sguardo si acuì sempre di più per quella difficilissima e capziosissima forma della deduzione in cui si commette il maggior numero di errori – quella deduzione per cui si risale dall’opera all’autore, dall’azione all’agente, dall’ideale a colui che lo sente necessario, da ogni maniera di pensare e di valutare al bisogno che dietro a essa impone il suo comando.
Bisognerebbe levare da questo quantum – da questo magma – ogni aggiunta, ogni nome – dirlo, senza nominarlo. Il fatto è che non si può. Hegel lo capì. Noi tedeschi, dice Nietzsche (Gaia, 357), siamo hegeliani, anche se un Hegel non fosse mai esistito.
Il nome non è una parvenza che si applica ad una X – dice Nietzsche (Gaia, 54). Che cos’è ora, per me, «parvenza»! In verità, non l’opposto di una sostanza.
La differenza tra reale e razionale – come in Hegel – viene decostruita.
Che cos’altro posso asserire di una sostanza qualsiasi se non appunto i soli predicati della sua parvenza? In verità, non una maschera inanimata che si potrebbe applicare ad una x sconosciuta e pur anche togliere! Parvenza, dice Nietzsche, è per me proprio ciò che opera e vive, che si spinge tanto lontano nella sia autoderisione da farmi sentire che qui tutto è parvenza e fuoco fatuo e danza di spiriti e niente di più – che tra tutti questi sognatori anch’io, l’«uomo della conoscenza», danzo la mia danza.
Da ciò deriva che ogni realismo, ogni materialismo ingenuo, ogni positivismo, ogni intenzione che si vuole esterna al suo intenzionato è inconsistente. Voi realisti, dice Nietzsche (Gaia, 57), date a intendere che il mondo sia realmente costituito nel modo che appare a voi: davanti a voi solo la realtà sarebbe senza veli e voi stessi ne sareste la parte migliore.
Che cos’è «realtà»? chiede Nietzsche.
Voi realisti, dice, continuate ancora a portarvi appresso le valutazioni delle cose che hanno origine nelle passioni e nei vagheggiamenti dei secoli trascorsi! Continuate ancora a incarnare nella vostra sobrietà un’ebrezza segreta e inestinguibile! Il vostro amore per la «realtà», per esempio – oh, è un antico, antichissimo «amore»! In ogni percezione, in ogni impressione sensibile c’è un frammento di questo vecchio amore: e allo stesso modo vi ha lavorato e intessuto le sue trame una qualche fantasticheria, un pregiudizio, un’irragionevolezza, un’ignoranza e un timore e chissà cos’altro ancora! Ecco laggiù una montagna! Ecco laggiù una nuvola! Ma che cos’è poi «reale»? Tirate via da tutto questo, voi sobri, il fantasma e l’insieme degli ingredienti umani! Si, se lo poteste! Se poteste dimenticare la vostra origine, il vostro passato, la vostra scuola preparatoria – tutta la vostra umanità e animalità! Per noi non ci sono «realtà».
In principio non ci sono le sensazioni – le sensazioni, allo stato puro, non ci sono. Le sensazioni sono sempre aggravate dalla storia – vedi L’uomo dei lupi di Freud. Non c’è un groviglio di sensazioni dal quale emergerebbe la parola e il concetto. Senza concetto non ci sono sensazioni. I concetti e le sensazioni sono l’uno il prolungamento dell’altra, la complicazione dell’altra.
Che cosa sono allora le parole, i concetti?
La fama, il nome, l’aspetto esteriore, la validità, l’usuale misura e peso di una cosa, dice Nietzsche (Gaia, 58) – in origine, per lo più, un errore e una determinazione arbitraria buttati addosso alle cose come un vestito e del tutto estranei all’essenza e perfino all’epidermide della cosa stessa.
Il nome che veste una cosa è venuto fuori per errore. All’origine c’è l’errore, l’arbitrio, il caso. Il vestito gettato addosso alla cosa del tutto estraneo alla cosa.
Non c’è in queste parole solo una teoria dell’arbitrarietà del segno, ma anche una teoria dell’arbitrarietà del valore, del significato. Il significato – il peso e la misura delle cose – è arbitrario. Non calza a pennello. È estraneo all’essenza della cosa. Ma non c’è nessuna essenza prima che si calzi il vestito. L’essenza si esprime in questo errore. La prova del nove di questa aderenza trova sempre un errore di calcolo.
Il nome e la fama, l’aspetto esteriore, la validità e la misura e peso di una cosa si sono affermati mediante la fede che si aveva in tutto questo e il suo progressivo incremento di generazione in generazione, sono gradatamente, per così dire, concresciuti con la cosa e si sono radicati in essa fino a divenire la sua carne stessa: fin dal principio la parvenza (ciò che appare, il fenomeno) ha finito quasi sempre per diventare la sostanza, e come sostanza agisce!
Nietzsche si vuol tenere lontano sia dal sensismo sia dal nominalismo. In merito al primo dice che non ci sono sensazioni. Non si parte della sensazione. Non c’è sensazione senza concetto. Per quanto riguarda il secondo dice che (Gaia, 58) chi pensasse che il rinvio a quest’origine [la parvenza come origine della sostanza] e a questo nebbioso involucro dell’illusione basterebbe ad annientare questo mondo ritenuto sostanziale, questa cosiddetta «realtà», non sarebbe altro che un bel pazzo!
Insieme al concetto deve sempre anche presentarsi la cosa. Più precisamente, solo la cosa può indossare l’abito. Di più: il nome è concresciuto con la cosa e si è radicato in essa fino a divenire la sua carne stessa: fin dal principio la parvenza (ciò che appare, il fenomeno) ha finito quasi sempre per diventare la sostanza, e come sostanza agisce.
In Aldilà (34-36), parlando esplicitamente del nominalismo, Nietzsche dice: Posto che nient’altro sia «dato» come reale, salvo il nostro mondo di bramosie e di passioni, e che non si possa discendere o salire ad alcun’altra «realtà», salvo appunto quella dei nostri istinti – il pensare, infatti, è soltanto un rapportarsi reciproco degli istinti -: non sarebbe allora permesso di fare il tentativo e di porre la questione se questo «dato» non basti a intendere, sulla base di quelli similari, anche il cosiddetto mondo meccanicistico (o «materiale»)? Non già – voglio dire – come un’illusione, un’«apparenza», una «rappresentazione» (nel senso di Berkeley e Schopenhauer), bensì come qualcosa avente lo stesso grado di realtà dei nostri stessi affetti – come una forma primitiva del mondo degli affetti, in cui giace ancora conchiuso in una possente unità tutto ciò che poi si ramifica e si plasma nel processo organico.
Considerare il sensibile e l’intelligibile come sintomi di una possente unità in cui sono conchiusi. Considerare la Differenza tra sensibile e intelligibile come un sintomo, o un affinamento, di una differenza che si differenzia prendendo fuoco, o prendendo il fuoco, arbitrariamente, da un fiammifero.
In definitiva, dice Nietzsche, la questione è se noi riconosciamo la volontà come agente, se noi crediamo alla causalità del volere.
Si tenga a mente che il volere non è il Volere di una sostanza, di un soggetto.
Se ci comportiamo in questo modo, dice, – e in fondo la fede in tutto questo è appunto la nostra fede nella causalità stessa -, siamo costretti a fare il tentativo di porre ipoteticamente la causalità del volere come causalità esclusiva. «Volontà» può agire naturalmente su «volontà» e non su «materia» (non su «nervi», per esempio – ): insomma, occorre osare l’ipotesi se, ovunque vengano riconosciuti «effetti», non agisca il volere sul volere – e se ogni accadimento meccanico, in quanto in esso diventa operante una forza, non sia appunto forza volitiva, effetto del volere. – Posto infine che si riuscisse a spiegare tutta quanta la nostra vita istintiva come la plasmazione e la ramificazione di un’unica forma fondamentale del volere – cioè della volontà di potenza, come è la mia tesi -; posto che si potesse ricondurre tutte le funzioni organiche a questa volontà di potenza e si trovasse in essa la soluzione del problema della generazione e della nutrizione – si tratta di un solo problema -, ci si sarebbe con ciò procurati il diritto di determinare univocamente ogni forza agente come: volontà di potenza. Il mondo veduto dall’interno, il mondo determinato e qualificato secondo il suo «carattere intelligibile» – sarebbe appunto «volontà di potenza» e nient’altro che questa.
Sostituiamo «piacere» a «volontà» e arriviamo dritti a Freud.
Ma Nietzsche è più sottile. Dice che si deve azzardare tutto ciò come ipotesi. Dice che siamo costretti ad azzardare questa ipotesi. Non possiamo non azzardare l’ipotesi della Differenza. E che si tratti di azzardo lo aveva chiarito qualche pagina prima: l’intenzionalità è la continuazione della non-intenzionalità.
IV
Come ci si costringe all’ipotesi?
Il ritmo, dice Nietzsche (Gaia, 84), è una costrizione. Non soltanto il movimento dei piedi [la danza], ma anche l’anima stessa [il canto] segue la cadenza. Cadenza e ritmo si ripetono. Ritornano indietro, avanzano e tornano indietro nel ritornello. Generano un irresistibile desiderio d’assecondare.
Con il canto e la danza – la preghiera – si cercava di assecondare gli dei. Si tentava così di costringerli mediante il ritmo e di esercitare un potere su di essi: si gettava loro la poesia come un laccio magico.
E si danza e si canta – si chiamano gli dei – per costringerli a farsi esprimere delle profezie.
Perché si ha bisogno di profezie?
Ogni passo è diverso dall’altro. Non si potrebbe avanzare senza profezie. La profezia controlla l’autismo
Non esistono azioni uguali, dice Nietzsche (Gaia, 355), né possono esistere – che ogni azione, una volta compiuta, è stata compiuta in un modo assolutamente unico e irripetibile, e che sarà lo stesso per ogni azione futura, che ogni azione, in una considerazione anteriore o posteriore di essa, è e resta una cosa impenetrabile – ogni azione è inconoscibile. Per ogni singolo caso la legge del loro meccanismo è indimostrabile.
Se a ciò si aggiunge che (Gaia, 335) ogni dire è un fare, ogni giudizio è un’azione, perché fa quel che ha riconosciuto come giusto e designato come necessario: anche il giudizio «questo è giusto», è un’azione -; se un giudizio è un’azione, allora esso è impenetrabile – non intelligibile.
Ogni azione [tutte le azioni, senza esclusione, sia azioni locutorie sia azioni motorie] è connessa all’assistenza di spiriti: canto magico ed esorcismo sembra siano stati la forma originaria della poesia. Il ritmo del verso usato dai greci, dice Nietzsche, doveva esercitare una costrizione. Doveva costringere gli dei alla profezia. Doveva farsi esprimere delle profezie – originariamente significa (secondo l’etimo per me probabile della parola greca): farsi destinare qualcosa; si crede di costringere il futuro.
Far venire qualcosa dal futuro significa farlo ripetere, farlo accadere due volte: una volta «adesso» (nel suo passato) e una volta nel suo «presente» (nel futuro). Significa farlo ripetere. Farlo ritornare. Eterno ritorno: non è ripetersi del passato, ma ripetersi del futuro. Eterno ritorno significa: Rendere possibile l’azione, la danza, la poesia, il passo aldilà, l’1+1.
Si crede di costringere il futuro, dice Nietzsche, col conquistarsi Apollo: lui che secondo la rappresentazione più antica è molto più di un dio preveggente. Non appena la formula viene pronunciata, letteralmente e ritmicamente, essa vincola il futuro.
Visto tutto ciò, continua Nietzsche, ci fu in generale per l’antico e superstizioso genere umano qualcosa di più utile del ritmo? Con esso si poteva tutto: dare magnificamente incremento a un lavoro; predisporsi il futuro secondo i propri voleri [Matematica]; sgravarsi l’anima di qualsivoglia eccesso (di paura, follia, di pietà, di spirito vendicativo) e non soltanto l’anima propria, ma anche quella del peggiore demone – senza il verso non si era nulla, col verso si diventava quasi un dio.
Bisognerebbe porre tutta questa discussione tra virgolette. E Nietzsche prontamente lo fa. Dice (Gaia, 109. Stiamo allerta!): guardiamoci bene dal dire che tutto ciò proviene dal caso. Perché soltanto accanto a un mondo di scopi la parola «caso» ha un senso. Guardiamoci dal dire che morte sarebbe quel che si contrappone alla vita. Il vivente è soltanto una varietà dell’inanimato e una varietà alquanto rara. Guardiamoci dal dire che il mondo crei qualcosa di eternamente nuovo. Non esistono sostanze eternamente durature: la materia è un errore.
Bisogna stare in allerta. Quand’anche si dicesse, e lo si deve dire, che tutto viene dal caso e dall’arbitrio, che la mano non è fatta per afferrare, ma è fatta a caso, e l’occhio non è fatto per vedere, perché se fosse fatto allo scopo di vedere, bisognerebbe subito introdurre un creatore (un Dio, un artigiano, un artista, un lavoratore) che ha pensato questo scopo nella sua testa e poi lo ha realizzato nella materia; bisognerebbe introdurre, insieme allo scopo, l’idea, la materia, il bene, eccetera; insomma, bisognerebbe trascinare nell’arena tutta la metafisica.
Quando la finiremo di essere circospetti! aggiunge Nietzsche. Quando sarà che tutte queste ombre di Dio non ci offuscheranno più? Quando avremo del tutto sdivinizzato la natura! Quando potremo iniziare a naturalizzare noi uomini insieme alla pura natura nuovamente ritrovata, nuovamente redenta!
V
Come emergono dal magma i Differenti? Come si passa dalla differenza alla Differenza?
Per errore, dice Nietzsche (Gaia, 110. Origine della conoscenza). Per immensi periodi di tempo, l’intelletto non ha prodotto nient’altro che errori: alcuni di questi si dimostrarono utili e atti alla conservazione della specie: chi si imbatte in essi o li riceve in eredità, combatte con maggiore fortuna la sua battaglia per se stesso e per la sua prole. Questi erronei articoli di fede, che furono sempre ulteriormente tramandati e divennero infine quasi il contenuto specifico e basilare dell’umanità, sono per esempio questi: che esistano cose durevoli [sostanza], che esistano cose uguali [identità], che esistano cose, materie, corpi [essere], che una cosa sia quel che essa appare [fenomeno], che il nostro volere sia liberò [libertà], che quanto è per me bene lo sia anche in sé e per sé [bene].
Questi errori – e già qualificarli come errori è un errore, perché si presuppone il differente rispetto al quale l’errore è ciò che «non-è-giusto». Se questi errori sono alla base dell’emergere di sostanza, identità, materia, essere, causa, effetto, eccetera, vero, falso, giusto, ingiusto, eccetera, non si capisce come possano essere definiti degli errori. A meno che essi non chiedano credito al futuro. Non si protendano verso il futuro, errando, cioè danzando, ricevendo in anticipo il capitale che investono nella riproduzione del medesimo capitale e di un interesse con il quale ripagare il prestito.
Questi errori produssero la partizione tra sensibile e intelligibile, ovvero tra ciò che muta e ciò che è stabile, tra ciò che misura e ciò che è misurato. Questi errori si dimostrarono utili alla vita e atti alla conservazione della vita. Chi li adopera combatte con maggiore fortuna la sua battaglia. L’intelligibile e il sensibile, escono dal magma, e infiammano la vita, si innestano nella vita, rivitalizzano. Cosicché, dice Nietzsche, la forza delle conoscenze non sta nel loro grado di verità, bensì nella loro età, nel loro essere incorporate, nel loro carattere di condizione di vita. Laddove vita e conoscenza sembravano venire in contraddizione l’una con l’altra, non si dette mai seriamente battaglia; a quel punto negazione e dubbio erano ritenuti assurdità. L’intelligibile è una complicazione, un affinamento, una protesi del sensibile. Si credette dunque possibile vivere questa opposizione: così si inventò il saggio (il cristo), l’uomo dell’intuizione immutabile, impersonale, universale, uno e tutto al tempo stesso, uomo e dio. Non soltanto utilità e piacere, ma istinti d’ogni specie si schierarono nella battaglia per «le verità» – dice Nietzsche; la battaglia intellettuale divenne un’occupazione, un’attrattiva, una vocazione, un dovere, un merito – la conoscenza e l’aspirazione al vero trovarono finalmente il loro posto nel sistema, come un bisogno tra gli altri bisogni. Da quel momento, dice, non solo la credenza e il convincimento, ma anche l’esperimento, la negazione, la diffidenza, la contraddizione furono una potenza, tutti gli istinti «malvagi» furono subordinati al conoscere e posti al suo servizio e s’ebbero lo splendore di quel che è permesso, onorato, utile e, in definitiva, lo sguardo e l’innocenza del bene. La conoscenza, dice, divenne dunque un frammento della vita stessa, e come vita si trasformò in una potenza continuamente crescente.
Attenzione però a considerare la verità come sorpassata dalla vita! Innumerevoli esseri, dice Nietzsche (Gaia, 111. Origine del logico), che argomentavano in maniera diversa da come noi argomentiamo oggi perirono. Chi, per esempio, non riusciva a trovare abbastanza spesso l’«uguale», relativamente alla nutrizione o agli animali a loro ostili, colui che quindi procedeva troppo lento, troppo cauto nella sussunzione, aveva più scarsa probabilità di sopravvivere di chi invece, in tutto quanto era simile, azzeccava subito l’uguaglianza. Ma l’inclinazione prevalente a trattare il simile come uguale, un’inclinazione illogica – dato che in sé nulla di uguale esiste -, ha creato in principio tutti i fondamenti della logica. Similmente, perché nascesse il concetto di sostanza – che è indispensabile per la logica, anche se ad esso, a rigor di termini, non corrisponde nulla di reale -, non si dovette per lungo tempo né vedere né sentire il permutarsi delle cose; gli esseri che non vedevano con precisione avevano un vantaggio rispetto a coloro che vedevano tutto «allo stato fluido». In sé e per sé, già ogni grado elevato di cautela nell’argomentazione, ogni inclinazione scettica è un grande pericolo per la vita. Non si sarebbe conservato alcun essere vivente, se non fosse stata coltivata, in modo estremamente vigoroso, l’opposta inclinazione, diretta ad affermare piuttosto che a sospendere il giudizio, a errare e a immaginare piuttosto che a restare in posizione d’attesa, ad assentire invece che a negare, a esprimere la propria opinione invece che a essere giusti.
Anche in questo caso il logico emerge come un prolungamento e un affinamento dell’illogico. Prolungamento che si ripiega sull’illogico (sulla vita) aiutandolo a sopravvivere. Guai a rinunciare alla forza della logica! Guai a ricadere nello scetticismo, nell’irrazionalismo! Lo scetticismo è un lusso che ci si deve concedere a dosi omeopatiche.
Posto che nelle condizioni che rendono possibile la vita ci potrebbe essere l’errore, bisogna riconoscere che, dice Nietzsche (Gaia, 121), ci siamo sistemati un mondo in cui poter vivere – con l’ammettere corpi, linee, superfici, cause e effetti, movimento e quiete, forma e contenuto; senza questi articoli di fede – senza questa metafisica – nessuno, oggi, sopporterebbe la vita! Si prenda la matematica, dice Nietzsche (Gaia, 246), vogliamo introdurre in tutte le scienze la sottigliezza e il rigore della matematica, almeno quel tanto che è possibile. E lo vogliamo introdurre non nella convinzione che per questa strada si possa conoscere le cose, ma per stabilire con ciò la nostra relazione umana con le cose. Nessuna relazione con le cose senza matematica. Perdita del contatto senza matematica. Mero autismo.
VI
Anche in Genealogia della morale Nietzsche ribadisce il punto capitale della volontà di potenza. Siamo alle soglie di un’adesione piena al nominalismo, all’idealismo, di un’adesione alla metafisica. Il diritto signorile di imporre nomi, dice (Gen,I-2), si estende così lontano che ci potrebbe permettere di concepire l’origine stessa del linguaggio come un’estrinsecazione di potenza da parte di coloro che esercitano il dominio: costoro dicono «questo è questo e questo», costoro impongono con una parola il suggello definitivo a ogni cosa e a ogni evento e in tal modo, per così dire, se ne appropriano. Il fatto nuovo in Nietzsche è che questo nominalismo è storico, interamente storico. I nomi sono una forzatura, un ripiegamento della forza su se stessa.
In secondo luogo, e qui le cose si complicano ulteriormente, bisogna pensare questa forza, dunque questo nominalismo, questa metafisica, se si vuole, non fuori o aldilà del mondo, ma come qualcosa di interamente terrestre. Metafisica come promanazione della volontà di potenza significa questo: puntare alla terra, puntare al corpo.
Infine, terza complicazione, bisogna evitare di pensare la volontà di potenza come sostanza.
La volontà di potenza, dice Nietzsche (Genealogia, I-13), è un quantum di forza, è esattamente un quantum di istinti, di volontà, d’attività – anzi essa non è precisamente null’altro che questi istinti, questa volontà, quest’attività stessa, e può apparire diversamente soltanto sotto la seduzione della lingua (e degli errori capitali in essa pietrificati, della ragione) che intende e fraintende ogni agire come condizionato da un agente, da un «soggetto». Allo stesso modo in cui, dice, il volgo separa il fulmine dal suo bagliore e ritiene quest’ultimo un fare, una produzione di un soggetto, che viene chiamato fulmine, così la morale del volgo tiene anche la forza distinta dalle estrinsecazioni della forza, come se dietro al forte esistesse un sostrato indifferente, al quale sarebbe consentito estrinsecare forza oppure no. Ma un tale sostrato, dice Nietzsche, non esiste: non esiste alcun «essere» al di sotto del fare, dell’agire, del divenire; «colui che fa» non è che fittiziamente aggiunto al fare – il fare è tutto. Il volgo, in fondo, duplica il fare; allorché vede il fulmine mandare un barbaglio, questo è un fare; pone lo stesso evento prima come causa, e poi ancora una volta come effetto di essa. I naturalisti non agiscono in modo migliore quando dicono: «La forza motrice muove, la forza cagiona» e simili – la nostra intera scienza, a onta di tutta la sua freddezza, della sua estraneità a moti affettivi, sta ancora sotto la seduzione della lingua e non si è sbarazzata di questi falsi infanti supposti, il «soggetto» (l’atomo è, per esempio, un siffatto infante supposto, così come la kantiana «cosa in sé»).
Bisogna intendere bene quello che Nietzsche dice in questo passo. Non c’è nessuna Differenza tra il soggetto e l’azione compiuta. Se non c’è Differenza, non c’è rapporto di causa ed effetto. Non ci sono soggetto in quanto causa, e azione in quanto effetto. In secondo luogo, dice Nietzsche, non c’è nessuna riserva. Non c’è nessun capitale in dotazione del soggetto. La forza non è una riserva. Non è un capitale. Non è una dotazione. Se fosse una dotazione, sarebbe la dotazione di un soggetto – il che non è. In terzo luogo Nietzsche dice che il soggetto è una supposizione. Si suppone un soggetto come causa. Lo stesso evento – l’enigma – prima viene inteso come causa, e poi ancora una volta come effetto. Si tratta di un passaggio molto complesso. Non c’è Differenza. A questo stato ci sono solo istinti: e guai a considerare questi istinti come Differenti! Anche per gli istinti bisogna parlare di eventi – di enigmi. Considerarli come Differenti, dunque come questo e quest’altro istinto implica la dotazione di «infanti supposti» che ancora non abbiamo. Bisogna pensare la volontà di potenza come UNO – come un uno che arretra e si pensa come causa, si protende e si pensa come effetto. Il Tempo, la Differenza e la Metafisica si producono in questo ritmo di ritrazione e protensione dello stesso. Quando Nietzsche dice che l’origine del linguaggio deve essere ricondotta alla volontà di potenza bisogna leggere questa affermazione con tutte queste riserve. La volontà di potenza non è il soggetto (il signore, l’uomo) che una mattina si sveglia e, in sette giorni, crea le cose e gli animali e inventa i relativi nomi. Sarebbe ridicolo attribuire a Nietzsche una tale concezione.
VII
Il compito del filosofo, dice Nietzsche (Genealogia I-17), è risolvere il problema del valore. Come si genera il valore? Chi crea ciò che vale? Come si crea il valore? Non si ha alcun diritto di dire che il valore è Creato dalla volontà di potenza, e intendere quest’ultima come soggetto – come sostanza, come dio. La questione del valore è interamente terrestre. Deve tornare ad essere una questione interamente terrestre. Bisogna raccontarne la genealogia partendo dalla terra. Dalle forze di lavoro terrestri.
Bisogna seguire la faglia che dalla promessa e dal debito porta alla memoria e all’oblio e confutare le sciocchezze dell’utilitarismo inglese: scrivere una genealogia del valore-(lavoro). Ed è quello che Nietzsche fa in Genealogia della morale.
Quel pensiero – utilitarismo – che oggi è molto a buon mercato e apparentemente così naturale, così inevitabile, il quale è sempre chiamato in causa per spiegare il modo con cui si è venuto a determinare sulla terra il sentimento del giusto (dell’equivalente) è una forma tardiva, anzi raffinata del giudicare e dell’inferire umano; chi lo trasferisce alle origini, commette un madornale errore.
L’idea di valore (Gen, II-4) – di equivalenza, per esempio, tra danno e dolore –, così profondamente radicata, oggi forse non più estirpabile, deriva dal rapporto contrattuale tra creditore e debitore, e rimanda ancora una volta, dal canto suo, alle forme fondamentali della compera, della vendita, dello scambio, del commercio.
La raffigurazione di questi rapporti contrattuali, dice Nietzsche (Gen. II-5), risveglia contro la più antica umanità che li ha creati o permessi ogni genere di sospetti e d’opposizione. Qui precisamente vengono fatte promesse; qui precisamente si tratta di fabbricare una memoria a colui che promette; qui precisamente, dice, è lecito sospettarlo, si troverà una base per scoprire cose dure, crudeli, penose.
Per promettere bisogna avere memoria. La promessa è interamente basata sulla memoria. Memoria di restituire in futuro ciò che si è ricevuto in passato. Fabbricare la memoria significa fabbricare il tempo storico: fabbricare il presente.
Nessun presente, dice Nietzsche (Gen. II-1), potrebbe esistere senza capacità di dimenticare. Non si arriva a capo di nulla, se non si ha il potere di dimenticare.
Che potere è questo potere di dimenticare?
Bisogna dimenticare per avere tempo (presente) – per ricordare. Il ricordo è una trasformazione dell’oblio, un suo prolungamento, e non il suo opposto. Bisogna mettere da parte tutti i luoghi comuni e le stronzate che oppongono oblio e memoria. Questa opposizione, per apparire, ha bisogno che si fabbrichi dapprima il presente, ovvero il tempo storico in cui dispiegarsi. Ogni partizione binaria è preceduta, di diritto, dalla costituzione (fabbricazione) del tempo.
Che ci sia bisogno di dimenticare per ricorda è comprensibile. Se il tempo del ricordo fosse un flusso continuo, un insieme di eventi di memoria gli uni attaccati agli altri, un continuum, senza posa, riposo, ripasso, senza una casella vuota, eccetera, non ci sarebbe presente storico.
Dimenticare è la condizione per ricordare. Non è la causa – come potrebbe esserlo? – nemmeno la possibilità : è la continuazione.
Dimenticare, dice Nietzsche (Gen. II-1), rappresenta una forza, una forma di vigorosa salute. Ricordare, dice, è un continuare ancora a volere. A voler ricordare è la stessa volontà che vuole dimenticare. Si è plasmato con la forza e l’educazione una facoltà antitetica, una memoria, mediante la quale in determinati casi l’oblio viene sospeso – in quei casi cioè in cui si tratta di fare una promessa.
Alla base della catena del valore-(lavoro) – scambio, contratto, promessa, fede, tempo – c’è l’altalena del ricordare e del dimenticare, il va e viene del tempo, il saliscendi della ritenzione e del rilascio, l’andirivieni della medesima forza – nessuna opposizione, nessuna contrapposizione, nessun «no» – il «si» all’andata e il «si» al ritorno. Soprattutto, nessuna opposizione tra chi ricorda e il ricordo; tra una tabula e un soggetto della scrittura: tutto inconscio, segreto, enigmatico. Le opposizioni sono posticce.
Ricordare, dice Nietzsche, è un continuare ancora a volere quel che si è voluto una volta. Questo volere ciò che si è voluto implica il movimento del dimenticare. Dimentico quello che mi succede – stacco il flusso autistico – dimentico quello che accade, faccio forza su questa casella dell’oblio, la rimarco, la ri-timbro. Cosicché, dice Nietzsche, tra l’originario «io voglio», «io farò», e il caratteristico scaricarsi della volontà, il suo atto, può essere agevolmente interposto un mondo di nuove cose sconosciute, di circostanze e persino di atti volitivi, senza che questa lunga catena del volere abbia a incrinarsi. Ma che cosa non presuppone tutto ciò! Quanto deve aver prima imparato l’uomo, per disporre anticipatamente del futuro in tal modo, quanto deve avere prima imparato a separare l’accadimento necessario dal quello casuale, a pensare secondo causalità, a vedere e ad anticipare il lontano come presente, a saper stabilire con sicurezza e calcolare e valutare in generale quel che è scopo e quel che è mezzo in tal senso – quanto, a questo fine, deve prima essere divenuto, l’uomo stesso, calcolabile, regolare, necessario, facendo altresì di se stesso la sua propria rappresentazione, per potere alla fine rispondere di sé come avvenire, allo stesso modo di uno che fa promessa!
Si tratta di una storia crudele, dice Nietzsche.
VIII
«Non ledere nessuno, quando puoi, aiuta tutti»: è questa la proposizione, a cui tutti i maestri si sforzano di dare un fondamento, il fondamento effettivo che da millenni si va cercando come la pietra filosofale – dice Nietzsche (Aldilà, 186). Essere giusti, applicare la giusta misura, è questo che non si riesce a fondare.
«Agisci secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge universale», dice l’imperativo (il «tu devi») di Kant. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa è la formula della giustizia. Ma questa formula, dice Nietzsche, non è stata fondata, e se si prova a fondarla, scavando, si scopre un abisso tempestato dalla violenza. La giustizia, al contrario di ciò che pensa l’utilitarismo inglese, che abbina utile e felicità e che ritiene che la ricerca della giustizia sia validata dalla presenza di piacere e dall’assenza di dolore; la giustizia, dice Nietzsche, deve fare i conti con la «selvaggia fiera crudele», con la paura che essa suscita e con la superbia che ha provato a signoreggiarla.
Dobbiamo modificare le nostre opinioni sulla crudeltà e aprire gli occhi, dice Nietzsche (Aldilà, 229). quasi tutto ciò che noi chiamiamo «civiltà superiore» trova nell’intellettualizzazione della crudeltà le sue basi – è questa la mia tesi: quella «fiera selvaggia» non è stata affatto uccisa, essa vive e prospera, soltanto che si è – divinizzata. Quel che costituisce la tormentosa voluttà della tragedia è la crudeltà; quel che, dice, nella cosiddetta compassione tragica, e persino, in ultima analisi, in ogni moto sublime, sino ai più alti e delicati brividi della metafisica, determina un’impressione gradevole, riceve la sua dolcezza soltanto dall’ingrediente della crudeltà che vi è commisto. Quel che il romano assapora nell’arena, il cristiano nell’estasi della croce, lo spagnolo alla vista dei roghi e delle corride, il giapponese di oggi, quando fa ressa per assistere alla tragedia, l’operaio dei sobborghi parigini, con la sua nostalgia di sanguinose rivoluzioni, la wagneriana, che nella sospensione della sua volontà «soggiace» al Tristano e Isotta – ciò che tutti costoro assaporano e cercano con misteriosa avidità di suggere nei loro stessi visceri sono i filtri aromatici della grande Circe «crudeltà». A questo proposito, dice, occorre sbarazzarsi senz’altro della balorda psicologia di una volta, che intorno alla crudeltà null’altro sapeva insegnare se non che essa nasce alla vista delle sofferenze altrui.
Bisogna sbarazzarsi dell’idea che la crudeltà sia legata al male, al male che si cagiona agli altri, e, attraverso gli altri, a se stessi. Bisogna invece convincersi che la crudeltà – il male – produce il piacere, che il male è parte integrante del bene, che il bene è una continuazione, una trasformazione del male – e se il male è l’ingiustizia stessa, che la giustizia è una continuazione dell’ingiustizia.
Esiste un copioso, esorbitante piacere anche dei propri dolori, del proprio farsi-soffrire – dice Nietzsche, – e tutte le volte che l’uomo si lascia persuadere all’auto-negazione in senso religioso o all’automutilazione , come accadde tra i Fenici e gli asceti, o in generale a fuggire i sensi, a disincarnarsi, alla contrizione, alle convulsioni penitenziali dei puritani, alla vivisezione della coscienza e al pascaliano sacrificio dell’intelletto, è la sua crudeltà ad attirarlo e a incalzarvelo segretamente, è quel pericoloso brivido di una crudeltà rivolta contro se stesso. Si consideri, infine, che anche l’uomo della conoscenza, allorché costringe la sua mente a conoscere in contrasto con l’inclinazione della mente e abbastanza di frequente anche contro i desideri del suo cuore, – cioè a pronunciare un no, laddove vorrebbe affermare, amare, adorare -, esercita il suo potere come artista e come trasfiguratore della crudeltà; già ogni prendere le cose in profondità e alle radici è un atto di violenza, una volontà di far soffrire diretti contro quel fondamentale volere dello spirito che mira incessantemente all’apparenza e alla superficie – già in ogni volontà di conoscenza c’è una goccia di crudeltà.
La memoria si istruisce per un impulso in avanti – piacere – e un impulso di ritorno – dispiacere. La forza che spinge in avanti e si afferma, deve essere (da chi? dalla forza stessa!) trattenuta, costretta a ritornare indietro per essere rilanciata in avanti. Il masochismo – subire il dispiacere – prepara la casella vuota dove il piacere rimarca la sua azione e produce come effetto la memoria. Perciò Nietzsche può affermare che in ogni volontà di conoscenza c’è una goccia di crudeltà, e, affinando la riflessione, dire che la metafisica, l’universale, Dio stesso, il Bene sommo, la Giustizia, sono una divinizzazione della crudeltà.
Anche in questo caso bisogna prestare la massima attenzione a non trasformare questo andirivieni della forza in azione di una sostanza, di un soggetto – la Volontà, la Volontà di far male (o far[si] male), la Volontà di sapere, eccetera. Fare attenzione a non leggere tutto ciò come frutto di una Differenza, della differenza tra il bene e il male. Non c’è alcuna partizione, siamo aldilà del bene e del male, aldilà della partizione entro cui essi si muovono. Il movimento è il movimento dell’UNO -e attenzione a non trasformare quest’uno in un universale. L’universale universalizza a partire dall’andirivieni, e non viceversa, come si è portati a credere.
IX
In Aurora 126, a proposito dell’oblio – dunque della forza che costringe a dimenticare – Nietzsche aveva precisato quanto segue. NON abbiamo alcun poter sull’oblio. Questo NON è collocabile nel vuoto della potenza. Non è un contro-potere. Se dimenticare fosse in nostro potere, ricorderemmo di avere dimenticato. E invece dimentichiamo se non ricordiamo nulla, nemmeno di avere dimenticato. L’oblio è in mano al caso – è un enigma. La storia è in mano al caso.
Il NON di questo non potere è un SI – non è reattivo.
Blanchot – forse commentando proprio questo non-potere (non-potere che soverchia la tematica del potere e del contro-potere) – dice che non si può smettere di soffrire, eccetera. La volontà di fare del male non è una volontà di in-potenza – è sempre potenza, potenza che arretra e ritorna sui propri passi. Ma è una potenza, come quella dell’oblio con cui è imparentate, sulla quale non esercitiamo alcun potere, perché ciò che comunemente chiamiamo Potere, Potere della memoria, per esempio, deriva proprio da questa potenza.
Le cautele di Nietzsche in Aurora 126 – cautele nel parlare di ciò di cui non si sa niente, non si sa nemmeno che non si sa niente – sono d’obbligo. Dice che «non è dimostrato», dice «Provvisoriamente», dice «come se», eccetera. Avanza depotenziando il linguaggio stesso e l’immagine di ciò che dice – collocando tutto all’estremità – verrebbe da dire aldilà – dell’esperibile e dell’intelligibile.
Nel dolore, dice Nietzsche (Gaia, 318), c’è la saggezza. C’è una saggezza del dolore. Nel dolore c’è tanta saggezza quanta nel piacere: al pari di quest’ultimo, esso appartiene alle energie di prim’ordine che conservano la specie: che faccia male non costituisce un argomento contro di esso, è la sua natura. Ascolto nel dolore il grido di comando del capitano della nave: «Ammainate le vele!». Dobbiamo saper vivere anche con energia ridotta: non appena il dolore dà il suo segnale d’allarme, è giunto il tempo di ridurla – un qualche grosso pericolo, una burrasca sta avanzando, e facciamo bene a «gonfiarci» il meno possibile.
Gonfiare a sgonfiare rendono ancora possibile avanzare. La saggezza del dolore sta in ciò, nel rendere possibile la vita arretrando, sgonfiando, arrischiando una ritirata.
La volontà di soffrire (Gaia, 338), non appartiene all’«uomo». Non è qualcosa di cui si possa disporre. Ciò di cui soffriamo – il carico di dolore cui ci costringiamo (masochismo) – nel modo più profondo e personale è incomprensibile e inaccessibile. In ciò restiamo nascosti al prossimo anche se questi mangia con noi allo stesso piatto. Ma ovunque venga notata la nostra condizione di sofferenti, dice, il nostro dolore è superficialmente interpretato; conviene all’essenza dello stato affettivo pietoso spogliare la sofferenza altrui di quel che essa ha di veramente personale: i nostri «benefattori» sono, più dei nostri nemici, coloro che deprezzano il nostro valore e la nostra volontà.
La volontà di soffrire e il dolore stesso sono inaccessibili, sono inconsci. Il consocio, la conoscenza – l’intelligibile, l’universale – è un effetto del dolore. E il dolore è legato alla vita – alla volontà di vivere – tanto quanto il piacere – e forse di più. Per conservarsi (Zarathustra, Dei mille e uno scopo), l’uomo fu il primo a porre dei valori nelle cose – per primo egli creò un senso alle cose, una senso umano! Perciò si chiama «uomo», cioè: colui che valuta. Valutare è creare: udite, creatori! Valutare è di per sé il tesoro e il gioiello di tutte le cose valutare. Mutamento dei valori, dice, è mutamento dei creatori. Sempre distrugge chi è costretto a creare.
Anche queste pensieri di Zarathustra vanno inquadrati nel Ritmo di piacere e dolore e considerati inconsci. Sarebbe un errore grave leggere questo creazionismo come attributo di una creatura o di un creatore – di un artista, di un genio, di un artigiano, di un lavoratore. Il valore non è una sostanza, non è la sostanza del lavoro. Il valore – a meno che non lo si voglia presupporre – deve essere inteso a partire dalla struttura di andirivieni di dolore e piacere in cui la forza avanza e arretra anticipandosi il capitale che andrà a spendere.
Credete dunque voi che, dice Nietzsche (Gaia, 300 – Preludi della scienza), le scienze sarebbero nate e progredite, se non le avessero precedute maghi, alchimisti, astrologi e streghe, in quanto furono proprio questi a creare per la prima volta, con le loro promesse e millanterie, la sete, la fame e il gusto delle potenze occulte e proibite?
La massima potenza occulta è la sostanza, e quella proibita è l’assoluto. Senza sostanza e assoluto non ci sarebbe scienza possibile. Proibito e nascosto è il feticcio che muove i tavolini di Marx. Tabù e mana sono nell’ordine dei divieti e della legge. Sono i preludi della scienza. E lo sono non in una prospettiva storicista. Non precedono la scienza in senso storiografico – la precedenza riguarda i principi. La scienza, ogni volta che principia a manifestarsi, si manifesta a partire dalla magia, ovvero dall’impossibile. La scienza vera e propria – che altro è la scienza se non una divinizzazione? – è annunciata da buffoni: da maghi, streghe, astrologi, alchimisti. Senza buffonate nessuna divinizzazione potrebbe cominciare.
Senza questa scuola e questa preistoria buffonesca [la storia principia a partire da queste buffonate] l’uomo non avrebbe imparato a sentire fame e sete di se stesso e a saziarsi e colmarsi di sé. Non dovette Prometeo, dice Nietzsche, in un primo momento supporre erroneamente d’aver rubato la luce e pagare il fio – per giungere infine a scoprire che era stato lui nella sua brama di luce a creare la luce, e che non soltanto l’uomo, ma anche il dio era stato opera delle sue mani e argilla nelle sue mani?
Ecco la teoria della creazione – teoria eminentemente terrestre – proposta da Nietzsche. Niente teleologia. Niente scopo, niente fine. Solo errore.
Perché errore? Perché la natura, dice Nietzsche (Gaia, 301), è sempre priva di valore. E l’uomo, in quanto essere naturale, in quanto bestia terrestre, è anch’egli privo di valore: è fatto a immagine della natura. È privo di scopo, come la natura. Indebitamente diciamo che la mano è fatta per afferrare – fatta allo scopo di afferrare, eccetera – ma in verità, piaccia o no, la mano è venuta fuori per errore. Anche il valore, se si vogliono tenere i piedi a terra, viene per errore. Prometeo suppone – e la supposizione è possibile solo dove è già attiva la struttura della memoria, supporre significa, in questa circostanza terrestre, divinare, supporre significa anticipare il futuro, rubarne il segreto. Ma questo stesso furto – questa anticipazione – innesca la struttura della ripetizione e la produzione del medesimo. Richiamandolo anzitempo fa avvenire l’avvenire – il richiamo è arbitrario (folle) e il futuro è dunque innocente (no teleologia).
In Aurora 13 Nietzsche dice che quasi ovunque è la follia che ha aperto la strada al nuovo pensiero, che ha infranto il potere di una venerabile consuetudine e di una superstizione.
Anche in questo caso, attenzione a interpretare la follia in termini romantici, in quanto libertà di azione, in quanto essere al di sopra della legge o al disopra degli schemi – attenzione a credere che la follia possa parlare e attenzione a voler far parlare la follia. Folle qui vuol dire inconscio. Il pensiero qui aperto è la continuazione del non-pensiero. Non c’è opposizione tra follia e ragione.
Ma come fa il non-pensiero ad aprire al pensiero?
X
Per quanto uno faccia progredire la sua conoscenza di sé, dice Nietzsche (Aurora, 119), nessuna cosa potrà mai essere più incompleta del quadro di tutti quanti gli istinti che costituiscono la sua natura. Difficilmente potrà dare un nome ai più grossolani di essi: il loro numero e la loro forza, il loro flusso e riflusso, il gioco alterno dell’uno con l’altro e soprattutto le leggi del loro nutrimento gli resteranno del tutto sconosciuti. Questo nutrimento diventa dunque un’opera del caso; i nostri intimi eventi di ogni giorno gettano ora a questo, ora a quell’istinto, una preda che viene subito avidamente afferrata, ma l’intero andirivieni di queste vicende sta al di fuori di ogni nesso razionale con le esigenze nutritive di questi istinti. Le nostre esperienze sono tutte, in questo senso, mezzi d’alimentazione, ma sparsi con mano cieca, senza sapere chi è che ha fame e chi è già sazio. E in conseguenza di questo casuale nutrimento delle parti, anche l’uomo interamente sviluppato sarà qualcosa di interamente casuale, come lo è il suo divenire.
Il divenire conserva la sua innocenza. Gli istinti non hanno potere su di esso. Barcamenandosi in un andirivieni inconscio non possono allungare i tentacoli oltre il pezzo che gli viene offerto dal caso.
Per parlare più chiaramente, dice Nietzsche: posto che un istinto si trovi al punto con cui brama appagarsi – o esercitare la sua forza, o sgravarsi di essa, o colmare un vuoto (questo, dice, è tutto un discorso metaforico), esso considererà ogni avvenimento della giornata in vista del modo con cui potrà servirsene ai suoi fini: sia che l’uomo cammini o riposi, sia che vada in collera, o legga, o parli, o combatta o tripudi, l’istinto, della sua sete, palpa, per così dire, ogni condizione in cui l’uomo si venga a trovare, e nella media dei casi non trova in questa nulla per sé, deve aspettare e avere sete ancora. Ancora un po’ e illanguidisce, ancora un paio di giorni e di mesi di inappagamento, e allora esso inaridisce come una pianta senza pioggia. Forse questa crudeltà del caso salterebbe agli occhi in maniera ancora più lampante, se tutti gli istinti volessero andare fino in fondo coma va la fame, la quale non si appaga di vivande sognate; ma la maggior parte degli istinti, specialmente i cosiddetti istinti morali, si appagano proprio di questo, se è lecita la mia supposizione, che il significato e il valore dei nostri sogni è proprio quello di compensare – fino a un certo grado – quella casuale mancanza di «nutrimento» durante il giorno. Perché il sogno di ieri, continua Nietzsche, fu pieno di dolcezza e di lacrime, quello dell’alto ieri scherzoso e tracotante, quello prima ancora fu tutto un’avventura e una continua cupa ricerca? Perché godo, in questo, le inenarrabili bellezze della musica, perché mi libro lassù a volo, in quest’altro, con l’estasi dell’aquila, verso lontani vertici di monti? Queste poetiche immaginazione, dice, che danno libero campo e sfogo ai nostri impulsi di dolcezza o di scherzo o di fantasticheria, o al nostro desiderio di musica e di montagne – e ognuno avrà sottomano i suoi esempi più calzanti – sono interpretazioni dei nostri stimoli nervosi durante il sono, interpretazioni assai libere, assai arbitrarie, dei movimenti del sangue e dei visceri, dell’oppressione del braccio e della coperta, dei suoni dei campanili, delle banderuole, dei nottambuli e di altre cose del genere. Che questo testo il quale, in generale, per una notte come per l’altra, resta molto simile, venga commentato in maniera così diversa; che la ragione poetica si rappresenti, ieri come oggi, cause tanto diverse in ordine alle medesime eccitazioni nervose: tutto ciò trova il suo fondamento nella circostanza che il suggeritore di questa ragione è stato oggi diverso da quello di ieri, – un altro istinto voleva appagarsi, attivizzarsi, esercitarsi, ristorarsi, sfogarsi, – appunto esso era alla sommità del suo flutto, e ieri ce n’era un altro. La vita allo stato di veglia non ha questa libertà d’interpretazione come quella del sogno, è meno poetica e sfrenata – tuttavia non dovrò forse concludere col dire che i nostri istinti nella veglia non fanno ugualmente nient’altro che interpretare le eccitazioni nervose e disporre le «cause» di queste sulla base della loro esigenza? che tra veglia e sogno non vi è sostanzialmente alcuna differenza?che anche i nostri giudizi e le nostre valutazioni sono soltanto immagini e fantasie di un processo fisiologico a noi ignoto, una specie di linguaggio per designare certe eccitazioni nervose? che tutta la nostra cosiddetta coscienza è un più o meno fantastico commento di un testo inconscio, forse inconoscibile, e tuttavia sentito? Si prenda una piccola esperienza vissuta. Posto che un bel giorno si noti qualcuno ridere di noi al mercato dove stiamo passando; a seconda che questo o quell’istinto sia in noi precisamente al suo culmine, tale fatto avrà questo o quel significato – e, a seconda del tipo di uomini che noi siamo, sarà un fatto alquanto diverso. Chi lo prenderà come una goccia di pioggia, chi se lo scuoterà di dosso come un insetto, chi ne prenderà lo spunto per attaccar lite, chi accerterà se sia il vestito a dar motivo di riso, chi mediterà, a causa di questo episodio, sul ridicolo in sé, e chi avrà un senso di benessere per aver dato, senza volere, un raggio di sole alla serenità e allo splendore del mondo; in ogni caso un istinto vi troverà il suo appagamento, sia esso quello dell’ira o della litigiosità, o della riflessione, o della benevolenza. Questo istinto ha afferrato l’episodio come fosse la sua preda: perché proprio questo? Poiché se ne stava in agguato carico di brame e affamato.
Questa lunga riflessione di Aurora merita di essere citata tutta, integralmente. Non solo perché anticipa Freud, ed è più sottile di Freud, ma anche perché smentisce il luogo comune che vede in Nietzsche il sommo Ermeneuta per il quale non ci sono fatti ma solo interpretazioni. I fatti sono sempre in agguato, afferrano gli eventi come prede e ne fanno quello che vogliono. Persino delle interpretazioni fanno quello che vogliono. La volontà di vivere – lo spessore fisiologico, terrestre, dell’animale uomo – piega la vita stessa e le fa credere che 1+1 = 2, che ciò che segue è un effetto di ciò che precede, che ogni cosa ha una sostanza, eccetera.
XI
Come è venuta, dunque, la ragione nel mondo? (Aurora, 123) Come è giusto che arrivasse, in modo irrazionale, attraverso il caso.
Non c’è discontinuità – contraddizione, opposizione, quello che volete! – tra ragione e sragione. La ragione galleggia su un grande mare inconscio.
Si dovrà indovinare questo caso, come un enigma.
Ci siamo abituati a credere a due regni, al regno dei fini della volontà, e al regno dei casi (Aurora 130); in quest’ultimo ci sono accadimenti assurdi, qui le cose vanno, ristanno e cadono senza che nessuno possa dire: perché? a che scopo? Abbiamo timore di questo possente reame della grande stupidità cosmica, poiché il più delle volte facciamo la sua conoscenza mentre piomba nell’altro mondo, quello dei fini e dei propositi, come una tegola dal tetto, accoppandoci una qualche bella finalità. Questa credenza nei due regni, dice Nietzsche, è un romanticismo e una favola che sono quanto mai vecchi: noi nani accorti, con il nostro volere e i nostri scopi, veniamo molestati da giganti stupidi, stupidissimi, i casi, veniamo rovesciati a terra dalla loro corsa, spesso calpestati a morte – ma, nonostante tutto, non vorremmo restare senza la terribile poesia della loro vicinanza, poiché quei mostri spesso vengono quando la vita nella tela di ragno degli scopi è divenuta troppo noiosa o troppo piena di timori, e procurano un sublime diversivo grazie al fatto che una volta tanto la loro mano lacera tutta quanta la ragnatela. Non che l’abbiamo voluto, questi irrazionali!
Intanto, dice Nietzsche, i tempi sono maturi per capire che nel nostro presunto regno particolare dei fini e della ragione domina parimenti il caso. E le nostre proprie ragnatele vengono lacerate altrettanto spesso e con altrettanto poco garbo da noi stessi, come dalla tegola! E non è tutto un fine, quel che così è chiamato, e meno ancora è tutto volere, quel che volere si chiama! E se vi piacesse concludere: «C’è forse soltanto un regno, quello dei casi e della stupidità?», bisognerebbe aggiungere: sì, forse c’è soltanto un regno, forse non esistono né volontà, né fini, e siamo stati noi ad esserceli immaginati. Quelle mani d’acciaio della necessità, che scuotono il bossolo dei casi, giocano per un tempo infinito il loro gioco: dovranno allora capitare getti di dadi, che assomiglino perfettamente al finalismo e alla razionalità di ogni grado. Forse i nostri atti volontari, i nostri scopi, non sono null’altro appunto che tali getti di dadi – e noi siamo soltanto troppo limitati e troppo vanitosi per renderci conto della nostra estrema limitatezza: quella, cioè, espressa dal fatto che siamo noi stessi a scuotere con mani d’acciaio il bossolo dei dai, che siamo noi stessi, nelle nostre azioni maggiormente premeditate, a non far niente di più che il gioco della necessità. Forse! Per poter venire a capo di questo forse, si dovrebbe già essere stati ospiti nell’oltretomba e dall’altro lato di tutte le superfici, e aver giocato al tavolo di Persefone e scommesso ai dadi con lei stessa.
Su questo oceano inconscio galleggiano i nostri propositi. E filiamo liscio, un passo dopo l’altro, un’impressione dopo l’altra. E se vogliamo ricordare, dobbiamo dimenticare, fare il vuoto, lasciare una casella vuota dove il presente si ripete, si rimarca. Dimenticanza attiva, la chiama Nietzsche. Dove questo meccanismo è compromesso non si arriva a capo di nulla. I casi si succedono ai casi, senza presa – autismo.
Disporre anticipatamente del futuro, dice. Rispondere di sé come avvenire, come uno che promette, implica questa dimenticanza attiva. Allevare un animale che possa far promesse, dice, implica rendere l’uomo necessario, uniforme, uguale tra gli uguali, coerente alla regola e conseguenza calcolabile.
La capacità di promettere – dunque di calcolare – produce quell’individuo sovrano in grado di impegnare se stesso, libero di volere. Quando promette Segna una Distinzione: dà la sua parola come qualcosa su cui fare affidamento («Alla scadenza pagherò l’equivalente»), perché si sa abbastanza forte da mantenerla persino contro casi avversi, persino «contro il destino» – con queste stesse necessità terrà pronte le sue pedate per chi promette senza averne facoltà. E la sua verga per il mentitore che viene meno alla sua parola. Accanto alla legge deve sempre risuonare il tintinnio delle manette.
La cognizione di questi privilegi, dice Nietzsche, è scesa nell’intimo fondo fino a essere sentita come un istinto, istinto dominante. Se dovessimo darle un nome la chiameremmo Coscienza.
Tutta questa struttura permette di disporre anticipatamente del futuro. Di questa struttura fa parte la colpa.
XII
La colpa, dice Nietzsche (Genealogia II-5,6), consiste in un mandato alla crudeltà. Inversione e passaggio dal masochismo al sadismo. Attraverso il sadismo si istituisce il colpevole e si commina la sanzione.
Il sovrano realizza la sua sovranità, dice Nietzsche, senza rivalsa sui beni di chi è venuto meno alla promessa, ma cagionando al fedifrago una sofferenza riparatrice.
In che senso, chiede Nietzsche, può essere la sofferenza una compensazione di «debiti»?
Far soffrire, risponde, arreca soddisfazione in sommo grado. Far soffrire è una vera e propria festa, un qualcosa che è tanto più tenuto in pregio quando maggiore è il contrasto con il rango e la posizione sociale del creditore.
Non si tratta di vendetta, dice Nietzsche. Perché la vendetta ripropone la stessa questione: Come può il far soffrire essere una riparazione? un equivalente?
L’equivalenza, dice Nietzsche, è data dal fatto che al posto di un vantaggio in diretto equilibrio con il danno (al posto dunque di una compensazione in denaro, terra, possessi di qualsivoglia specie) viene concessa al creditore a titolo di rimborso e di compensazione una sorta di compensazione intima – la soddisfazione di poter scatenare senza alcuno scrupolo la propria potenza su un essere impotente, la voluttà di fare il male per il picare di farlo, il piacere di far violenza: picare che come tale risulta apprezzato in misura tanto più alta quanta più bassa e umile è la condizione del creditore. Nell’ordinamento della società, e che può facilmente apparirgli come un boccone prelibato, anzi come pregustazione di un rango più alto.
Mediante la «pena» del debitore, il creditore partecipa di un diritto signorile. Perfino nel vecchio Kant, dice Nietzsche, l’imperativo categorico puzza di crudeltà.
Il sadismo è la strada per la costituzione di un universale. Da te non voglio niente, nessun bene, nessuna tua proprietà. Non voglio niente. Non ti voglio. Per me non sei niente. Ti cerco per trovare l’universalità astratta, il nulla, il vuoto di individualità.
Nietzsche cerca e trova nella fisiologia l’origine della metafisica. E, in una inversione che non piacerà ai filosofi, trova nell’economia politica l’origine degli universali. Non è l’economia (l’economia marxista, per esempio) che cede e si appoggia sulla Metafisica, come dice il neo-classicismo (Böhm-Bawerk, tra gli altri), è la Metafisica che poggia le scarpe sul terreno dell’economia politica.
Cercate un fondamento all’«io penso», cercatelo nell’economia degli istinti e nell’economia politica. Il sentimento della colpa – lo schema generale della giustizia distributiva ha avuto la sua origine nel più antico e originario rapporto tra persona che esiste, nel rapporto tra compratore e venditore, creditore e debitore: qua, per la prima volta, si fece innanzi persona a persona, qui per la prima volta si misurò persona a persona (Genealogia, II-8).
Stabilire prezzi, misure di valori, escogitare equivalenti, barattare, dice Nietzsche – ciò ha preoccupato il primissimo pensiero dell’uomo in una tale misura, che in un certo senso pensare è tutto questo.
Forse, dice, le nostre parole «mensch» (manus) esprimono ancora qualcosa appunto di questo senso di sé: l’uomo si caratterizzava come la creatura che misura valori, detta valori e stabilisce misure in quanto «animale apprezzante in sé». Compera e vendita, unitamente ai loro accessori psicologici, sono più antiche degli stessi cominciamenti di qualsiasi forma di organizzazione sociale e di qualsivoglia consociazione, il germogliante sentimento di scambio, contratto, debito, diritto, dovere, compensazione, si è invece in primo luogo trasferito dalle forme più rudimentali del diritto personale ai più grezzi e primitivi complessi comunitari (nei loro rapporti con complessi simili), assieme alle consuetudini di confrontare potenza e potenza, di stabilire la misura e farne il computo.
XIII
Bisogna prestare molta attenzione a non far derivare la misura da un rapporto, dal rapporto di scambio. Non c’è rapporto prima della misura. Non si può ricavare la misura dal rapporto. L’estenuante ricerca di una misura giusta a partire dal rapporto di scambio, ricerca disperata della scuola neo-classica, è votata al fallimento. Nietzsche chiama e bolla questo tentativo come risentimento, pensiero del risentimento, pensiero reazionario. Cercare nel confitto amico-nemico l’origine della giustizia distributivo è l’azione disperata di un uomo risentito, reazionario.
Dalla reazione, dice Nietzsche, non può derivare la legge. La sovranità non si acquisisce per reazione, ovvero rispondendo a un danno subito. La reazione si innesta nel cattivo infinito, non giunge mai alla legge.
La legge – la crudeltà –, come il sadico, deve sopprimere ogni dipendenza. Il sadico, scrive Blanchot, mira a non dipendere dall’oggetto di desiderio. Sade, dice Blanchot, aveva scoperto che la negazione era potenza. Sade ha preteso di fondare l’avvenire dell’uomo sulla negazione spinta sino all’estremo. Per raggiungere un tale scopo, Sade ha immaginato un principio che, per la sua ambiguità, costituisce una scelta molto ingegnosa. Questo principio è l’energia: una nozione, in realtà, estremamente equivoca, in quanto rappresenta in pari tempo una riserva di forze e un consumo di forze, un’affermazione che si realizza solo attraverso la negazione, potenza che è distruzione. Inoltre, dice Blanchot, è insieme fatto e legge, dato e valore. Colpisce il fatto che, dice, Sade, in questo universo della effervescenza e della passione, lungi dal mettere al primo posto il desiderio [l’utile], l’abbia considerato subordinato e giudicato sospetto, in quanto il desiderio nega la solitudine, e conduce a un pericoloso riconoscimento del mondo altrui. La distruzione, invece, appare sinonimo di potenza, pur senza che l’oggetto distrutto tragga da questa operazione il minimo riconoscimento di valore. Sade, dice Blanchot, si è proposto di annichilire la morale del Bene, ma senza sostituirlo con un Vangelo del Male. Sade aveva scoperto che nell’uomo la negazione era potenza e ha preteso fondare l’avvenire dell’uomo sulla negazione spinta sino all’estremo. Ha scoperto che l’apatia – la rinuncia al piacere e all’utile – è lo spirito di negazione applicato all’uomo che ha deciso di essere sovrano.
Si tratta di una accesso alla legge che rimarrà sempre precluso all’utilitarismo, in tutte le sue varianti – neo-classicismo economico, keynesismo, marginalismo, sintesi-neoclassica, microeconomia, eccetera, circuitismo, mmt.
Nella maggior parte dei casi – questo è l’argomento di Sade – l’individuo odierno fonda la propria condotta sulla debolezza, giacché se si spende per gli altri è perché ritiene di aver bisogno di appoggiarsi ad essi. Fatale debolezza: si indebolisce consumando vanamente le proprie forze.
L’originalità di Sade, dice Blanchot, ci sembra consistere nel fatto che egli pretende di fondare la sovranità dell’uomo in un potere trascendente di negazione, potere che non dipende affatto dagli oggetti che egli distrugge, giacché, nel momento in cui li distrugge, li ha già sempre, precedentemente, considerati come un nulla. Nella misura in cui l’uomo sadico appare sbalorditivamente libero nei confronti delle sue vittime, ciò accade perché la violenza contro di esse ha di mira qualcosa che va al di là di loro e non fa altro che verificare all’infinito, in ogni caso particolare, l’atto generale di distruzione mediante il quale ha ridotto Dio e il mondo a un nulla.
Il libertino di Sade che, dice Blanchot, immolando la propria vittima, non avverte che il bisogno di sacrificarne mille altre, sembra stranamente liberato da ogni legame con questa. Ai suoi occhi, la vittima non esiste di per se stessa, non è un essere differenziato, ma un semplice elemento, infinitamente sostituibile, in una immensa equazione erotica. Si comprende, dice Blanchot, come l’idea dell’eguaglianza sia alla base di tanti ragionamenti di Sade. Tutti gli uomini sono eguali, e ciò significa che, poiché nessuna creatura vale più di un’altra, tutte sono intercambiabili, e ognuna significa unicamente una unità in una enumerazione infinita. Di fronte all’Unico tutti gli essere sono eguali nella loro nullità.
XIV
Non è difficile trovare in questo argomenti di Sade la catena delle equazioni del capitalismo, l’indifferenza verso il valore d’uso, l’indifferenza verso il ramo dove il capitale è impiegato, la nullità e la sostituibilità della forza-lavoro, ridotta e elemento intercambiabile in una macchina per estrarre plusvalore. Come non è difficile leggervi le equazioni del terzo libro del Capitale, o tutta la sociologia inconcludente che ha lucrato per anni nascondendo dietro il passpartout dell’alienazione questa costituzione dell’universalità.
La differenza con la sociologia è che in Sade questo annullamento conduce alla formazione del senso, alla formazione del valore, alla formazione della legge degli equivalenti – alla formazione di una legge distributiva, di circolazione semplice e di circolazione allargata delle cose utili. L’utile si ripartisce a partire da questo principio sadico dell’annullamento. D’altronde, cos’altro è, in Hegel, l’identità di Essere e Nulla; o in Heidegger (Che cos’è metafisica?), anche qui, ma su un piano più prossimo a Sade, l’identità di Essere e Nulla?
Come possiamo noi, esseri finiti, rendere accessibile in sé, e soprattutto per noi, la totalità dell’ente nella sua universalità? (Heidegger, Che cos’è metafisica). Al massimo, dice, noi possiamo pensare la totalità dell’ente nell’«idea», e poi negare nel pensiero e «pensare» come negato ciò che così abbiamo immaginato. Certo, dice, per questa strada acquisiamo il concetto formale del niente così come immaginato, ma mai il niente stesso.
Come sormontare il fatto di essere perduti nell’ente, di essere una parte del tutto? Come cogliere ciò di cui si è una parte?
Proprio quando non siamo particolarmente occupati dalle cose e da noi stessi, dice Heidegger, ci soprassale questo «tutto», per esempio nella noia autentica. Nell’apatia, nel non desiderare più niente, nel considerare privo di utilità ogni cosa, pensare, anzi, sentire aldilà del desiderio e dell’utile.
La noia profonda, che sento come un sentimento che mi prende e mi coinvolge, dice Heidegger, accomuna tutte le cose, tutti gli uomini, e con loro noi stessi in una strana indifferenza. Questa noia rivela l’ente nella sua totalità. Questo stato d’animo accade assai di rado, dura un attimo, e quell’attimo è in grado di portarci dinanzi al niente stesso. Questo stato d’animo è l’angoscia (Angst).
L’angoscia, precisa Heidegger, è fondamentalmente diversa dalla paura. Non deve dipendere da nessuna persona e da nessuna cosa.
Come per per Sade, l’universale, l’assoluto, il sovrano, deve essere libero, assoluto, sciolto da ogni dipendenza da qualsivoglia ente particolare – deve slegarsi dalla sequenza degli eventi storici – deve guardarsi dalle tentazioni del cattivo infinito.
Noi, dice Heidegger, abbiamo paura sempre di questo o di quell’ente determinato, che in questo o in quel determinato riguardo ci minaccia. La paura di… è sempre paura anche per qualcosa di determinato. E poiché è propria della paura la limitatezza del suo oggetto e del suo motivo, chi ha paura ed è pauroso è prigioniero di ciò in cui si trova. Nel tendere a salvarsi da questo qualcosa di determinato, egli diventa insicuro nei confronti di ogni altra cosa, cioè, nell’insieme, dice Heidegger, «perde la testa». Perde il capo, perdere il controllo, perde la sovranità – la libertà.
L’angoscia non fa più insorgere un simile perturbamento. È attraversata piuttosto da una quiete singolare. L’angoscia di… è sempre angoscia per…, ma non per questo o per quello. L’angoscia rivela il niente.
Ecco trovata la pietra filosofale! La porticina che dal finito conduce all’infinito.
Ancora Heidegger precisa che questo no alla determinazione non è un no a qualcosa di determinato. Nell’angoscia, dice, non ha luogo un annientamento di tutto l’ente in sé, né, tanto meno, una negazione da parte nostra dell’ente nella sua totalità, per guadagnare alla fine il niente.
Non ci sono da una parte l’angosciato e dall’altra tutto il resto dell’ente che, davanti all’angoscia, si presenterebbe come l’insieme di ciò che non si vuole o non si desidera. Il nulla non deriva dalla differenza tra noi e il mondo. Semmai è il contrario: è la differenza che deriva dal nulla.
Anche prescindendo dal fatto che all’angoscia come tale è estranea l’attuazione esplicita di un’asserzione negativa, noi, con una simile negazione che dovrebbe produrre il niente, arriveremmo sempre troppo tardi. Il niente ci viene incontro già prima – il niente precede la differenza.
La nientificazione (non il nichilismo, attenzione!) non è un annientamento dell’ente, e neppure scaturisce da una negazione. La negazione proviene dal niente. La negazione come contrapposizione, opposizione, lotta, eccetera, proviene dal niente. È il niente che apre l’ente come tale, dice Heidegger. È anzitutto il niente che porta l’esser-ci davanti all’ente come tale. Se l’esserci non si tenesse immerso fin dall’inizio nel niente, non potrebbe mai comportarsi in rapporto all’ente, e perciò neanche a se stesso. La stessa misura tra sé e l’ente, la distanza, la separazione, la differenza, il valore e il senso, la storia, eccetera, senza l’evidenza del niente, senza questa trascendenza, non emergerebbero, non emergerebbe l’esser-se-stesso, né la libertà.
Heidegger ribadisce ulteriormente questo argomento. La negazione, dice, non aggiunge affatto da sé il «non» come mezzo di differenziazione e di opposizione al dato, quasi intercalandolo ad esso. Il «non» non nasce dalla negazione, ma la negazione si fonda sul «non» che scaturisce dal niente. Qui, dice Heidegger, si infrange il primato della logica. Più profonda della semplice adeguatezza alla negazione logica è la durezza dell’agire ostile e l’asprezza del detestare. Nemmeno una decisione o la nostra volontà sono capaci di portarci inanzi al niente – dato che il niente sopravanza qualsiasi decisione e volontà. Emergiamo su un oceano inconscio – direbbe Nietzsche.
XV
È sullo spirito del ressentiment, dice Nietzsche (Gen, II, 11), che si sviluppa questa nuova nuance di scientifica rettitudine che si schiera a favore dell’odio, dell’invidia, del livore, del sospetto, del rancore, della vendetta.
Se c’è una scuola del sospetto, Nietzsche non ne fa parte. Se c’è una scuola del complotto, Nietzsche non ne fa parte.
L’uomo attivo, aggressivo, prevaricante, dice, è pur sempre cento passi più vicino alla giustizia dell’uomo che reagisce.
L’uomo attivo è sovrano. Il reattivo è ripreso nella serie delle condizioni che scatenano la sua sua azione, agisce sotto l’effetto di una spinta particolare. Il sovrano agisce per liberarsi da ogni condizione e relazione particolare.
Non ci può essere giustizia nella reazione, non ci può essere fine nella vendetta, non ci può essere via d’uscita dal complotto.
L’uomo aggressivo, in quanto più forte, più coraggioso, più nobile, dice Nietzsche, ha avuto in ogni tempo a proprio vantaggio anche lo sguardo più libero, la migliore coscienza.
L’elemento decisivo nell’uomo attivo e aggressivo, quel che la suprema (sovrana) potenza fa e attua contro la strapotenza dei sentimenti avversi e pervicaci è la statuizione della legge, la chiarificazione imperativa di quel che deve in generale valere ai suoi occhi come permesso e legittimo, e di quel che invece deve valere come proibito e illegittimo.
La legge è cieca. Deve sempre mostrare il suo tratto di assoluto distacco dalle vicende dell’uomo singolo. Il singolo deve sentirne il peso come il peso di qualcosa di incommensurabile, inaccessibile, segreto. Nessuna ermeneutica, nessuna semiosi. Quando ci si riferisce ad una situazione kafkiana, ci si riferisce all’assenza di complotto, all’impossibilità di farneticare sulle cause o le ragioni, eccetera.
Il diritto – l’esigenza di giustizia, il valore e la misura stessi -, da un punto di vista storico, rappresenta sulla Terra la lotta contro i sentimenti di reazione, la guerra con essi da parte di potenze attive e aggressive, che usavano in parte la loro forza nell’imporre freno e misura al disfrenarsi del pathos reattivo e nel costringere a un accordo.
Non siamo molto lontani da Hegel. Anche Hegel cerca (e trova) l’assoluto aldilà della reazione (del cattivo infinito); per Hegel l’esperienza (terrestre) è tutto. È una strada terrestre che conduce all’infinito. La differenza con Nietzsche sta in ciò: Nietzsche pone l’inizio in Terra, e in particolare su quel lago inconscio degli istinti.
L’utilità – il bene – non fonda niente. Non può essere il fondamento di una legge – né tanto meno di una legge del valore.
L’immagine classica della Legge, scrive Deleuze (Il freddo e il crudele), fissata da Platone, si impone nel mondo cristiano e arriva siano alla modernità. È l’immagine di una Legge che è sottomessa a un principio superiore. La Legge è un rappresentante del Bene. La Legge deve realizzare il Bene. Una buona Legge è una legge che tende al Bene.
In questo passaggio verticale verso l’alto, dice Deleuze, c’è qualcosa di ironico. C’è molta ironia nel processo che sale dalle leggi a un Bene assoluto come a un principio necessario per la loro fondazione. È come ammettere che la nozione di Legge non si sostiene di per se stessa, ma con la forza, e che ha idealmente bisogno di un più alto principio come di una più lontana conseguenza.
La Legge è, e deve essere, sovrana – libera da ogni condizione. Se ciò non fosse, non sarebbe la Legge.
Questa immagine classica della Legge, dice Deleuze, immagine che da Platone giunge sino all’illuminismo, e che non smette di esercitare la sua influenza, subisce una stoccata decisiva per mano di Kant.
Se, dice Deleuze, ci chiediamo sotto quali influssi l’immagine classica della legge viene rovesciata e distrutta, è certo che questo non accade per la scoperta di una relatività, di una mutevolezza delle leggi. Questa relatività era infatti pienamente conosciuta e compresa nell’immagine classica; ne faceva necessariamente parte. Il vero motivo è un altro. Se ne troverà l’enunciazione più rigorosa nella Critica della ragione pratica di Kant. Lo tesso Kant dice che la novità del suo metodo consiste nel fatto che la legge non dipende più dal Bene, ma che al contrario è il Bene a dipendere dalla Legge. Questo, dice Deleuze, significa che la Legge non deve più fondarsi, non può più fondarsi su un principio superiore da cui trarrebbe il proprio diritto. Questo significa che la legge deve valere per se stessa e fondarsi su se stessa, che non ha dunque altra risorsa che non sia la propria forma. È dunque per la prima volta che si può, che si deve parlare DELLA LEGGE, senza altra specificazione, senza indicare un oggetto. L’immagine classica non conosce che le leggi, specificate in base all’ambito del Bene e alle circostanze del Meglio.
Dopo Kant la Legge (che conquista la sovranità della lettera maiuscola) la Legge morale è la rappresentazione di una pura forma, indipendente dal contenuto e da un oggetto, da un ambito e dalle circostanze. La legge morale significa LA LEGGE, la forma della legge, escludente ogni principio superiore capace di fondarla. In questo senso, dice Deleuze, Kant è uno dei primi a rompere con l’immagine classica di legge, ad aprirci un’immagine propriamente moderna. La rivoluzione copernicana di Kant nella Critica della Ragion pura consiste nel far ruotare gli oggetti della conoscenza intorno a un soggetto; ma la rivoluzione della Ragion pratica, che consiste nel far ruotare il Bene intorno alla Legge, è senza dubbio più importante.
L’empirismo della scuola economica austriaca vorrà recuperare, e di fatto rimetterà al suo posto il Bene (sotto forma delle preferenze del consumatore, della teoria dei bisogni o della domanda effettiva) quale ultima ratio nella determinazione del prezzo o dell’equilibrio economico generale. Le leggi economiche devono ruotare intorno alle preferenze del consumatore, così come devono ruotare intorno al consumatore i prezzi, l’offerta di moneta, l’equilibrio economico, il livello degli investimenti, eccetera. Si fa arretrare il dibattito economico a prima della rivoluzione di Kant.
Senza dubbio, dice Deleuze, la rivoluzione di Kant era espressione di importanti cambiamenti nel mondo. E senza dubbio esprimeva le estreme conseguenze di un ritorno al di là del mondo cristiano, alla legge giudaica; forse annunciava anche il ritorno a una concezione presocratica (edipica) della legge, al di là del mondo platonico. E in ogni caso, rendendo LA legge un fondamento ultimo, Kant dotava il pensiero moderno di una delle su principali dimensioni: l’oggetto della legge si sottrae in modo essenziale.
Quel che è più chiaro, dice Deleuze, è che LA LEGGE, definita dalla sua pura forma, senza materia e senza oggetto, senza specificazione, è tale che non si sa che cosa sia, e che neppure si può saperlo. Essa agisce senza essere conosciuta. Aldilà anche di ogni teologia negativa, perché la legge è trasparente, di essa si sa tutto. Non c’è segreto. Essa definisce un ambito di erranza in cui si è già colpevoli, vale a dire in cui si sono già trasgrediti i limiti prima di sapere cosa essa sia: così Edipo. E neppure la colpa e il castigo ci fanno conoscere cosa sia la legge, lasciandola in quella stessa indeterminazione che, come tale, corrisponde all’estrema precisione del castigo. Kafka, dice Deleuze, ha saputo descrivere tale mondo. Non si tratta di porre Kant accanto a Kafka, ma soltanto di far emergere i due poli che formano il pensiero moderno della legge.
Se la legge non si fonda più sul Bene preliminare e superiore, se essa vale per la sua propria forma che ne lascia totalmente indeterminato il contenuto, diventa impossibile, dice Deleuze, sostenere che il giusto obbedisce alla legge per il meglio. O piuttosto: colui che obbedisce alla legge non è e dunque non si sente un giusto. Si sente colpevole, è preliminarmente colpevole e tanto più colpevole quanto più rigidamente obbedisce alla legge. È con la stessa operazione che la legge si manifesta in quanto legge pura, e ci costituisce come colpevoli. Le due proposizioni che formavano l’immagine classica, quella del principio e quella delle conseguenze, quella della fondazione da parte del Bene e quella della sanzione da parte del giusto, crollano contemporaneamente.
Spetta a Freud, dice Deleuze, l’aver fatto emergere il fantastico paradosso della coscienza morale: ben lungi dal sentirsi più giusti nella misura in cui ci si sottomette alla legge, è la legge che «si comporta con tanta maggiore severità e manifesta tanta maggiore diffidenza quanto più virtuoso è il soggetto… Rigore straordinario della coscienza morale nella creatura migliore e più docile…»(Disagio della civiltà).
XVI
Se volessimo tradurre questo discorso di Nietzsche sui valori e sulla pena e applicarlo al valore d’uso e chiederci quel è il valore del valore d’uso, come diventa un Bene economico, eccetera, dovremmo innanzitutto dire che tra la Legge (del valore) e il Bene non c’è alcuna relazione, che, comunque la si veda, è il Bene a ruotare intorno alla legge, e mai viceversa; che il significato del valore d’uso (il suo valore) non è definibile – non ha una definizione stabile, fissa, eccetera, perché, dice Nietzsche, solo ciò che non ha storia ha un significato.
Ora, è evidente che quando ci si riferisce al valore d’uso, non solo si suppone un significato, ma ci si comporta come se questo significato fosse perfettamente trasparente. Tutto ciò non è in discussione. Che venga tirato in ballo un significato, qui, adesso, in questa storia, è fuori di dubbio. Anzi, dice Nietzsche, di significati ce ne son fin troppi. Per dare almeno un’idea di come sia incerto, SUPPLETIVO, accidentale il «significato» della pena e di quanto una sola e identica procedura possa essere utilizzata, interpretata, riassettata in vista di propositi radicalmente diversi: ecco qui, scrive Nietzsche (Gen. II, 13), lo schema che mi si è venuto determinando sulla base stessa di un materiale relativamente esiguo e causale. Pena come neutralizzazione di pericolosità, come impedimento di un ulteriore danno. Pena come risarcimento del danno al danneggiato, in qualsivoglia forma (anche in quella di una compensazione d’affetti). Pena come isolamento di un’alterazione d’equilibrio, per prevenire un propagarsi di tale alterazione. Pena come instillazione di timore di fronte a coloro che determinano e dànno esecuzione alla pena. Pena come una sorta di compensazione per i vantaggi che il delinquente ha goduto fino a quel momento (per esempio, ove venga utilizzato come schiavo di miniera). Pena come segregazione di un elemento in via di degenerazione. Pena come festa, vale a dire come soverchiamento e derisione di un nemico finalmente abbattuto. Pena come scolpire nella memoria, sia per colui che subisce il castigo – il cosiddetto «miglioramento» – sia per i testimoni dell’esecuzione. Pena come corresponsione di una retribuzione, riservata dalla potenza che tutela il malfattore dagli eccessi della vendetta. Pena come compromesso. Pena come dichiarazione di guerra. Eccetera.
Il significato, dice Nietzsche, è Suppletivo (nachträglich), tardivo, posticcio, si attacca come una parrucca. C’è significato – come potrebbe essere altrimenti! Ma questo significato arriva in ritardo, oppure arriva in anticipo e supplisce chi deve ancora arrivare – la sostanza: è il supplente della sostanza.
Come avanza questo supplente, come arriva ad occupare il posto di un titolare che può intitolare la seduta o la cattedra solo a partire da questo supplemento di sostanza?
Come si è arrivati a dare un valore al valore d’uso?
Seguo passo passo Nietzsche, Genealogia II,12.
Come hanno proceduto, dice Nietzsche, i genealogisti della morale (i genealogisti inglesi) sino a oggi? Ingenuamente, come sempre hanno fatto -: scoprono nel valore d’uso (nel bene) un qualsivoglia «scopo» e quindi, ingenuamente, collocano questo scopo all’origine, come causa fiendi del bene, e – la cosa è fatta. Ma «il fine nell’economia» è tra tutti l’ultimo elemento utilizzabile per la storia genetica dell’economia: anzi per ogni specie di storia non esiste alcun principio più importante di quello che a prezzo di tanta fatica è stato conquistato, e che altresì doveva essere conquistato – il principio, cioè, che la causa genetica di una cosa e la sua finale utilità, nonché la sua effettiva utilizzazione e inserimento in un sistema di fini, sono fatti toto cælo disgiunti l’uno dall’altro; che qualche cosa d’esistente, venuta in qualche modo a realizzarsi, è sempre nuovamente interpretata da una potenza a essa superiore in vista di nuovi propositi, nuovamente sequestrata, rimanipolata e adattata a nuove utilità: che ogni accadimento nel mondo organico è un sormontare, un signoreggiare e che a sua volta ogni sormontare e signoreggiare è un reinterpretate, un riassettare, in cui necessariamente il «valore» o lo «scopo» esistiti sino a quel momento devono offuscarsi o del tutto estinguersi. Per bene che si sia compresa l’utilità di un qualsiasi organo fisiologico (o anche di una istituzione giuridica, di un costume sociale, di un uso politico, di una determinata forma nelle arti o nel culto religioso), non si è perciò stesso ancora compreso nulla relativamente alla sua origine: comunque ciò possa suonare molesto e sgradevole a orecchie più vecchie – da tempo immemorabile, infatti, dice Nietzsche, si è creduto di comprendere nello scopo comprovabile, nell’utilità di una cosa, di una forma, di un’istituzione, anche il suo fondamento d’origine, e così l’occhio sarebbe fatto per vedere, la mano per afferrare, la zappa per zappare, il pane per mangiare, la macchina per viaggiare. Così ci si è figurata la pena come fosse stata inventata per castigare. Ma tutti gli scopi, tutte le utilità, dice Nietzsche, sono unicamente indizi del fatto che una volontà di potenza [inconscio] ha imposto la sua signoria su qualcosa di meno potente e gli ha impresso, sulla base del proprio arbitrio, il senso di una funzione; e l’intera storia di una «cosa», di un organo, di un uso può essere in tal modo un’ininterrotta catena di segni che accenna a sempre nuove interpretazioni e riassestamenti, le cui cause non hanno neppure bisogno di essere connesse tra loro, anzi talvolta si susseguono e si alternano in guisa meramente casuale. «Evoluzione» di una «cosa», di un uso, di un organo, quindi, è tutt’altro che il suo progressus verso una meta, e ancor meno un progressus logico e di brevissima durata, raggiunto con il minimo dispendio di forza e di beni – bensì il susseguirsi di processi d’assoggettamento svolgentisi in tale cosa, più o meno spinti in profondità, più o meno indipendenti l’uno dall’altro, con l’aggiunta delle resistenze che continuamente si muovono contro, delle tentate metamorfosi di forma a scopo di difesa e di reazione, nonché degli esisti di fortunate controazioni. La forma è fluida, dice Nietzsche, ma il «senso» lo è ancora di più… Anche all’interno di ogni singolo organismo le cose non stanno diversamente: a ogni sostanziale sviluppo del tutto, si sposta anche il «senso» dei singoli organi – talora il loro parziale andare in rovina, la loro diminuzione numerica (per esempio attraverso l’annientamento delle parti intermedie) può essere un segno di crescente forza e perfezione. Anche il parziale divenire inutile, l’intristirsi e il degenerare, lo smarrirsi di senso e conformità al fine, la morte, insomma, rientrano nelle condizioni del progressus reale: il quale compare come tale sempre in figura di volontà e cammino inteso a una più grande potenza e sempre si attua a spese di innumerevoli potenze più piccole. La grandezza di un «progresso» si misura persino alla stregua di tutto ciò che ha dovuto essergli sacrificato; l’umanità, in quanto massa sacrificata al rigoglio di una singola più forte specie umana – questo sarebbe progresso.
Tutta questa elaborata e sottile semiologia di Nietzsche va letta, se possibile, aldilà di ogni umanismo, di ogni soggettivismo. Non bisogna fare l’errore di credere che sotto – in quanto sostrato – che sotto la volontà di potenza ci sia un soggetto del volere. Qui risiede tutta la differenza tra Nietzsche e Hegel. Se l’inizio è inconscio, come si salta nel conscio? Come si passa dal sensibile all’intelligibile?
XVII
In Aldilà 2 Nietzsche pone esplicitamente questa domanda.
«Come potrebbe qualcosa nascere dal suo contrario? Per esempio la verità dall’errore? O la volontà di verità dalla volontà di illusione? O l’azione disinteressata dal proprio tornaconto? O la pura solare contemplazione dei saggi dalla concupiscenza? Una tale origine è impossibile; chi sogna una cosa del genere è un folle, anzi qualcosa di peggio; le cose di valore supremo devono avere un’origine divina, un’origine loro propria – non possono essere derivate da questo mondo effimero, seduttore, ingannatore, irrilevante, da questo guazzabuglio di delirio e bramosia! Piuttosto la loro origine deve essere in seno all’essere, nel non transeunte, nel nascosto Iddio, nella «cosa in sé» – la è in nessun altro luogo!». Questa maniera di giudicare, dice Nietzsche, sta alla base del modo di argomentare dei metafisici di ogni tempo. In fondo a tutti i loro apprezzamenti logici ci sono questo tipo di giudizi, dai quali ottengono qualcosa che essi chiamano «verità». La credenza fondamentale dei metafisici, dice Nietzsche, è la credenza nelle antitesi dei valori. A nessuno di essi, dice, è venuto in mente di dubitare di questa antitesi, di questa Differenza, dove dubitare era quanto mai necessario. È infatti lecito dubitare, in primo luogo, se esistano in generale antitesi, e in secondo luogo, se quei popolari apprezzamenti e antitesi di valori, sui quali i metafisici hanno stampato il loro suggello, non siano forse che apprezzamenti pregiudiziali, prospettive provvisorie, ricavate, per di più, forse da un angolo, forse dal basso in alto, prospettive-di-batrace per così dire, per prendere in prestito un’espressione che ricorre frequentemente nei pittori?
Si tratta di un passaggio molto difficile. Nietzsche sta contestando il primato della Differenza. Della Differenza tra Sensibile e Intelligibile, tra Universale e Singolare, tra Legge e Fattispecie, tra Valore (di scambio) e Valore d’uso. Non dice che questa differenza non vale niente. Dice che tutta la metafisica ha costruito la sua fortuna su questa Differenza, sulla differenza tra Cielo e Terra. E non può dirlo con certezza, gli viene il dubbio che, forse (il passo è pieno di «forse»), non possa dirlo senza far leva su questa Differenza. E tuttavia il dubbio che forse questa Differenza sia seconda, postuma, protesica, che supplisca un’altra differenza che, in quanto tale, non può presentarsi, questo dubbio, forse, è giusto che venga espresso.
Nonostante il dubbio che può essere attribuito al vero, al verace, al disinteressato, dice, c’è la possibilità [ma è solo una possibilità] che debba ascriversi all’apparenza, alla volontà di illusione, all’interesse personale e alla cupidità un valore superiore e più fondamentale per ogni vita. Sarebbe inoltre persino possibile [non certo, ma possibile] che quanto costituisce il valore di quelle buone e venerate cose consista proprio nel fatto che esse sono capziosamente, apparentemente antitetiche, e forse anzi sono a queste essenzialmente simili. Forse! – Ma chi mai vorrà preoccuparsi di siffatti pericolosi «forse»! Per questo occorre aspettare l’arrivo di un nuovo genere di filosofi, tali che abbiano gusti e inclinazioni diverse e opposte rispetto a quelle fino a oggi esistite – filosofi del pericoloso «forse» in ogni senso.
Può essere che Verità e Menzogna non siano l’una l’antitesi dell’altra, che l’intelligibile sia una continuazione del sensibile, che il valore sia una continuazione del valore d’uso, eccetera. Forse. Già solo il dubbio immette su una nuova strada. Fa parte di una nuova filosofia.
Questa riflessione conduce fuori da ogni ermeneutica, da ogni nominalismo, da ogni retoricizzazione del pensiero, eccetera. Non è possibile lasciarsi andare a considerazione come questa: Non ci sono fatti, solo interpretazioni. Si tratta qui di un materialismo nuovo – aldilà della Differenza tra materialismo e idealismo – e anche della loro dialettica. Non c’è dialettica. Al livello del Forse non c’è dialettica.
L’«essere cosciente», dice Nietzsche (Aldilà, 3), non può essere contrapposto, in qualche maniera decisiva, all’istintivo [all’inconscio] – il pensiero cosciente di un filosofo è per lo più segretamente diretto dai suoi istinti e costretto in determinati binari. Anche qui, lo ripeto, attenzione a non considerare gli istinti come istinti dell’uomo e il segreto come verità celata oppure l’inconscio come l’inconscio di qualcuno. C’è una linea necessaria – non teleologica, dunque casuale – tra inconscio e coscienza. Nel sonno le orecchie sentono una campana, la mente ricorda il sogno di un funerale. Non c’è nessuna connessione tra la campana e il sogno. C’è un legame logico tra il suono e il sogno, ma la connessione tra la campana e il funerale è accidentale. Come è accidentale che abbiamo sognato e che la campana abbia suonato e che l’abbiamo ascoltata, eccetera (vedi Umani I, 13).
Anche dietro ogni logica e la sua apparente sovranità di movimento stanno esigenze fisiologiche. Per esempio, che il determinato abbia più valore dell’indeterminato, che l’apparenza sia meno valida della «verità»: simili apprezzamenti, con tutta la loro importanza regolativa per noi, potrebbero, pur tuttavia, essere soltanto apprezzamenti pregiudiziali, una determinata specie di niaiserie, come può essere appunto necessaria per la conservazione di esseri quali noi siamo.
Per Nietzsche non si tratta di dire, come direbbe un romantico, che la logica è uno strumento di tortura e repressione, eccetera; che dove c’è matematica non c’è differenza, eccetera; che la metafisica distrugge l’uomo, eccetera. Nietzsche dice tutto ciò, dice che queste cose sono terribili, ma, nello stesso tempo, dice che se esse sono indispensabili alla vita, che ben vengano, e che se anche l’errore aiuta la vita, viva l’errore. La falsità di un giudizio, dice, (Aldilà, I-4), non è ancora, per noi, un’obiezione contro di esso; è qui che il nostro linguaggio ha forse un suono quanto mai inusitato. La questione, dice, è fino a che punto questo giudizio promuova e conservi la vita, conservi la specie e forse addirittura concorra al suo sviluppo; e noi siamo fondamentalmente propensi ad affermare che i giudizi più falsi (ai quali appartengono i giudizi sintetici a priori) sono per noi i più indispensabili, e che senza mantenere in vigore le funzioni logiche, senza una misurazione della realtà alla stregua del mondo, puramente inventato, dell’assoluto, dell’eguale-a-se-stesso, senza una costante falsificazione del mondo mediante il numero, l’uomo non potrebbe vivere – che rinunciare ai giudizi falsi sarebbe un rinunciare alla vita, una negazione della vita. Ammettere la non verità come condizione della vita: ciò indubbiamente significa metterci pericolosamente in contrasto con i consueti sentimenti di valore.
Il valore che attribuiamo a una cosa – il significato – è errato. Non c’è alcuna corrispondenza tra il valore e la cosa valorizzata. Il loro rapporto è casuale, arbitrario. Il valore è unicamente un indizio del fatto che una volontà di potenza – l’inconscio – ha imposto la sua signoria – si è mosso spinto in avanti – su qualcosa di meno potente – che spingeva nella direzione opposta – e gli ha impresso – segnato, intaccato –, sulla base del proprio arbitrio, il senso di una funzione; e l’intera storia di una «cosa», di un organo, di un uso – o valore d’uso – può essere in tal modo un’ininterrotta catena di segni che accenna a sempre nuove interpretazioni – impressioni, marchi – riassestamenti, le cui cause non hanno neppure bisogno di essere connesse tra loro, anzi talvolta si susseguono e si alternano in guisa meramente casuale. «Cosa» – giustamente tra virgolette: non c’è alcuna cosa (senza virgolette) aldilà del processo, che non è – lo ripeto – un mero processo semiologico in cui un soggetto interpreta il segreto della cosa e lo porta alla luce. Non c’è cosa, non c’è segreto, non c’è punto luce in questo processo – non c’è Differenza nell’inconscio. Sormontando ciò che l’inconscio produce come indizi, supplendo un sapere che ancora non arriva, si può Forse dire che nell’inconscio c’è differenza ma non c’è Differenza, e tutto ciò, lo si dice, forse, a partire da un supplemento di Differenza, ovvero, a partire da quella credenza nelle antitesi dei valori senza la quale non ci sarebbe numero, assoluto, sostanza e sostantivo, libertà, Legge, valore e valore di scambio.
Non c’è cinismo o nichilismo in questa posizione di Nietzsche. Siccome la verità vale come una bugia, allora soppesiamola e usiamola a nostro vantaggio; siccome i numeri non numerano nulla, e il risultato è aleatorio, allora usiamo la matematica per registrare il nostro tornaconto. Niente di tutto ciò. Nietzsche dice qualcosa di più ragionevole. Non c’è alcuna sostanza – dice. Ma senza sostanza non possiamo dire che non c’è alcuna sostanza. Se vogliamo continuare a dire qualcosa dobbiamo supporre (credere) in una sostanza. E anche se sappiamo che questa credenza si basa su una menzogna, dobbiamo comportarci come se essa dicesse la verità – se vogliamo continuare a vivere. In più, è il concetto stesso di sostanza che, una volta tirato in ballo, impone il suo andazzo. Il concetto di sostanza non si libra aldilà della Terra – della volontà di potenza – ma trova in essa la spinta che lo fa sollevare. Una volta trovata e lanciata in aria questa pietra filosofale, una volta mollato il filo della deduzione e provato a indovinare, questa pietra scagliata deve cadere, e caderci addosso lapidandoci (Zarathustra, Visione e enigma, 1). È questo l’andirivieni del concetto, che parte da una mano singolare e ricade, alla cieca, potenzialmente su chiunque, su tutti, lapidandoli, giustiziandoli. Attenzione!, se parte come menzogna, non vuol dire che ricade come menzogna. Parte come menzogna e ricade come mannaia, come numero, precisamente come numero, con la selettività a zero del numero.
Il concetto si alza e torna indietro come una mannaia. Non lo si domina, ha un residuo inconscio. Se poi è più comodo – ragionevole – vedere solo la ricaduta (e non la salita), e dire che il concetto è freddo, immobile, immutabile, asettico, identico a se stesso, assoluto, eccetera; se è più utile credere in un concetto puro, bene, allora vada per un concetto depurato, per una legge cieca, eccetera. Se preferite agonizzare su un sicuro nulla piuttosto che su un intero qualcosa, bene! – dice Nietzsche (Aldilà, I-10). Ma questo è nichilismo e indice di un’anima disperante, mortalmente esausta: per quanto gli atteggiamenti di una tale virtù possano apparire prodi.
Prendete Kant, prendete i suoi giudizi sintetici a priori. È tempo, dice Nietzsche (Aldilà, I-11), di sostituire la domanda kantiana «come sono possibili giudizi sintetici a priori?», con un’altra domanda: «Perché è necessaria la fede in siffatti giudizi?» – cioè è tempo di renderci conto che tali giudizi devono essere creduti come veri al fine della conservazione di esseri della nostra specie; ragion per cui, naturalmente, potrebbero anche essere giudizi falsi! Ovvero, per parlare più chiaro, rudemente e radicalmente: giudizi sintetici a priori non dovrebbero affatto «essere possibili»: non abbiamo alcun diritto a essi, nella nostra bocca sono giudizi falsi e nulla più. Salvo il fatto che è indubbiamente necessaria la credenza nella loro verità, in quanto credenza pregiudiziale e immediata evidenza che rientra nell’ottica prospettica della vita.
I giudizi sintetici a priori sono parte della vita, sono parte del tutto, e questo tutto si chiama natura. Provate a immaginare, dice Nietzsche (Aldilà, I-9), un essere come la natura, dissipatrice senza misura, indifferente senza misura, senza propositi e riguardi, senza pietà e giustizia, feconda e squallida e al tempo stesso insicura, immaginatevi l’indifferenza stessa come potenza, immaginate il suo passo di danza, il suo ritmo, e immaginate questo ritmo come un espediente della potenza, un espediente saltato fuori per lo scuotimento del bossolo dei casi, e immaginate che questo ritmo e questa danza, due passi avanti e uno indietro, produca, sempre a caso, qualcosa come i giudizi sintetici a priori, e producendoli si accorga che la danza fila liscia, più liscia. Ecco, avrete immaginato non (non) come si crea un concetto – non c’è creazione in natura, non c’è creatore e creatura -, ma come una danza e un ritmo inconsci si affermano in quanto ripetizione dello stesso.