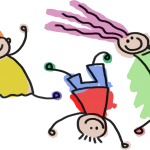Secondo la legge del valore-lavoro, il valore delle merci si fonda sul lavoro speso nella loro produzione. Le merci devono essere scambiate in proporzione al lavoro in esse incorporato.
Se l’operaio fannullone della fabbrica A produce un frigorifero in 12 ore, mentre l’operaio diligente della fabbrica B produce lo stesso modello di frigorifero in 6 ore, il frigorifero A avrà un valore di 12 unità, mentre il frigorifero B avrà un valore di 6 unità. Se la legge del valore incorporato regolasse sul mercato lo scambio dei beni in modo necessario e universale, il lavoratore fannullone (oppure il capitalista al suo posto) incasserebbe il doppio del lavoratore diligente. Ma ciò contrasta con ogni fatto empiricamente osservabile. Le scelte individuali dei consumatori – le loro motivazioni psicologiche, ridotte al mero calcolo di convenienza – indirizzerebbero le domande verso l’offerta della fabbrica B, costringendo la Fabbrica A a chiudere e a licenziare il fannullone e a spostare i capitali verso la fabbrica B.
Il prodotto quotidiano di un ingegnere meccanico non ha un valore uguale, ma di gran lunga superiore a quello di un semplice operaio industriale, quantunque in entrambi sia incorporato lo stesso tempo di lavoro. Come equiparare i due lavori?
Il lavoro definisce la quantità pura nella quale si esprimono i valori di grandezza. La quantità pura misurata da una bilancia è la pesantezza, mentre i chilogrammi esprimono la grandezza (il Quanto) della pesantezza di un oggetto determinato. Allo stesso modo, il lavoro esprime la quantità pura del valore, mentre i minuti e le ore ne esprimono la grandezza. Pertanto, per commisurare il lavoro dell’ingegnere a quello dell’operaio occorre trovare la quantità pura per esprimere la grandezza nella quale il primo lavoro sta in rapporto al secondo.
Questa grandezza pura, dice Böhm-Bawerk, è, secondo Marx (Capitale, I), dispendio di semplice forza-lavoro che ogni individuo possiede in media nel suo organismo fisico. La grandezza pura è lavoro medio semplice. Un lavoro complesso (come quello dell’ingegnere) vale come lavoro semplice (operaio) potenziato o piuttosto moltiplicato, cosicché una minor quantità di lavoro complesso è uguale ad una maggiore quantità di lavoro semplice.
Tuttavia, obietta Böhm-Bawerk, data la quantità pura (lavoro), e data l’unità di misura (tempo), rimane da definire la proporzione nella quale lavori effettivi qualitativamente differenti tra loro si equiparano gli uni con gli altri. Quante unità di lavoro semplice vale il lavoro di un ingegnere? e quello di un carpentiere, di un medico, di un farmacista, di un direttore di orchestra, di un dentista, di un macellaio, di un bidello, di un insegnante, di un becchino, di un manovale, di un bracciante agricolo, di un amministratore delegato?
Le varie proporzioni nelle quali differenti generi di lavori sono ridotti a lavoro semplice come loro quantità pura, dice Marx, vengono stabilite mediante un processo sociale estraneo ai produttori e quindi appaiono a questi ultimi date dalla tradizione.
Ora, dice Böhm-Bawerk, al lettore frettoloso questa spiegazione può anche apparire plausibile, ma in verità non lo è affatto. Intanto, dice, se si guarda il dato empirico, il lavoro dell’ingegnere è di qualità totalmente differente da quello dell’operaio. Se si considerano i prodotti dei due lavoratori, in essi non si trova una sostanza comune – lavoro-semplice – ma si trovano generi diversi di lavoro, e in quantità differenti. È vero, continua Böhm-Bawerk, che Marx dice che il lavoro complesso «vale» come lavoro semplice moltiplicato. Ma «valere» non è «essere», e la teoria di Marx mira alle cose stesse. Questo «valore» di cui parla Marx non è «dispendio fisico di mente e muscoli». Ogni dispendio ha una storia irriducibile. Ogni lavoratore ha caratteristiche del tutto irripetibili e uniche. Neppure due fratelli gemelli, o addirittura due cloni, possono fornire prestazioni identiche, in quanto occupano uno spazio differente. Dunque, il «valore» di cui parla Marx, non può avere, come egli pretende, una natura per così dire ontologica, ma deve avere una natura logica.
È su questa base che Böhm-Bawerk misura le contraddizioni di Marx, contraddizioni che egli interpreta non come esse sono intese da Hegel e da Marx, ovvero come contraddizioni metafisiche, ma, invece, come contraddizioni logico-formali.
Sia come sia, il tema del confronto passò alla storia come problema della «trasformazione dei valori in prezzi» o «determinazione del saggio medio di profitto». Tra il 1885, anno di pubblicazione del secondo volume del Capitale, e il 1894, anno di pubblicazione del Terzo volume, si sviluppò, dice Böhm-Bawerk, una vera gara teorica a premi intorno al tema del «saggio medio di profitto», gara che si trascinò sin quasi alle soglie della prima guerra mondiale, per poi essere totalmente oscurata da una rinascita di interesse per Hegel, soprattutto in Italia, Germania e Francia. Il tema del Plusvalore finì per essere soppiantato dal tema della reificazione. L’interesse si spostò dal Capitale ai Manoscritti del 44. Lo sfruttamento dei produttori lasciò il posto alla cosificazione. Poi la moda cambiò, e finita anche la seconda guerra mondiale, i neo-hegeliani dovettero fare largo ai nicciani. Il positivismo della II Internazionale genuit la Hegel-renaissance, che genuit la Nietzsche-Renaissance. A metà degli anni Settanta, soprattutto in Italia, quando i nicciani avevano ormai egemonizzato la scena antagonista, parlare di plusvalore era considerata un’abitudine stramba di reduci baffuti. Negli anni Ottanta e Novanta nessun nicciano sapeva più ribattere al presentatore TV che legittimava il suo compenso, 100 volte la paga di un operaio, rapportandolo agli introiti pubblicitari, oppure alla casa farmaceutica che vendeva farmaci a prezzi stratosferici, giustificandoli con presunti costi di ricerca, eccetera. Non era sufficiente dire che la ragione del più forte è sempre la migliore, o che l’economia è la continuazione della guerra combattuta con altri mezzi, perché questi motti, lo si capì troppo tardi, erano una traduzione letterale delle formule con le quali Böhm-Bawerk decostruì – questa era la sua convinzione – il Plusvalore di Marx.
Böhm-Bawerk, in un articolo del 1896, espone il suo argomento in modo elegante. Marx, dice, propone due teorie del valore, una nel Primo e una nel Terzo libro del Capitale. Queste due teorie sono tra di loro contraddittorie.
La dimostrazione di Böhm-Bawerk si misura con il tema del saggio medio del profitto.
Il capitale totale è diviso da Marx in due porzioni: capitale Costante e capitale Variabile. La Composizione organica del capitale è la proporzione nella quale le due porzioni di capitale formano il totale. Alla formazione del Plusvalore concorre la sola parte variabile del capitale, ovvero la porzione investita nell’acquisto della forza-lavoro. Dato un medesimo saggio di plusvalore*, una medesima velocità di rotazione e una medesima quantità di capitale totale investita, nelle diverse sfere industriali il saggio di profitto varierà a seconda della composizione organica del capitale.
La teoria del valore di Marx, dice Böhm-Bawerk, esige che capitali totali di pari grandezza, ma di differente composizione organica, producano profitti differenti. Ma nel mondo reale domina con tutta evidenza la legge secondo cui capitali di pari grandezza, qualunque sia la loro composizione organica, generano profitti uguali. Evidenza riconosciuta dallo stesso Marx nel Libro Terzo, cap. 10, dove dice che i capitalisti non traggono il plusvalore, e dunque anche il profitto, dalla loro propria sfera industriale, ma dal capitale complessivo sociale detenuto in un determinato periodo di tempo dal complesso di tutte le sfere industriali. Ogni capitale anticipato, qualunque sia la sua composizione organica, trae la percentuale di profitto che è in esso prodotta da un’aliquota 100 del capitale sociale complessivo. Tutti i capitali, dice, qualsiasi sia la loro composizione, tendono, sotto la pressione della concorrenza, ad eguagliarsi a quelli di composizione media. Il profitto incassato in una sfera industriale non coincide con il plusvalore estorto nella stessa sfera. La legge del valore non spiega più nulla. Il Capitale crolla sotto il suo peso.
A questo punto appare evidente, dice Böhm-Bawerk, che il rapporto di scambio delle singole merci non viene determinato più dai loro valori, ma dai loro prezzi di produzione. I valori si trasformano in prezzi di produzione. Valore e prezzo coincidono solo in via eccezionale, in tutti gli altri casi divergono. Dunque, conclude, o i prodotti vengono scambiati secondo il lavoro in essi incorporato, e allora il livellamento dei guadagni di capitali è impossibile, oppure il livellamento dei guadagni di capitale si verifica, e allora è impossibile che i prodotti vengano scambiati in proporzione al lavoro in essi incorporato. Nel Primo libro viene detto che le merci si scambiano in base al lavoro incorporato, nel Terzo viene detto che ciò non accade e non può accedere, e non può accadere non per caso o saltuariamente, ma in modo necessario e permanente. Le singole merci si scambiano secondo una proporzione differente da quella del lavoro in esse incorporato. Il Terzo libro smentisce il Primo. La teoria del saggio medio del profitto e dei prezzi di produzione non si concilia con la teoria del valore.
Se, alla fine, per spiegare il profitto devo tornare ai costi di produzione, chiede Böhm-Bawerk, a che serve tutto il complicato apparato della teoria del valore e del plusvalore? Non serve a nulla.
Da una parte, dice Böhm-Bawerk, nel Terzo libero, basandosi sull’esperienza empirica, Marx riconosce che è proprio la concorrenza a creare il saggio medio del profitto e la trasformazione dei puri valori del lavoro in prezzi di produzione. D’altra parte, nel Primo libro, getta questa esperienza alle ortiche, e, dice Böhm-Bawerk, sceglie una dimostrazione puramente logica, una «deduzione dialettica dell’essenza dello scambio». Marx immagina lo scambio di merci sotto la forma di un’equazione, e deduce che nelle due cose scambiate, e dunque equiparate, esista qualcosa di eguale, una sostanza comune. I prodotti reali che abbiamo tra le mani e sotto gli occhi, le differenze che li rendono unici e irripetibili, vengono così svalutate e annichilite, a favore di una sostanza comune, sostanza che non contiene nemmeno un grammo della loro effettività empiricamente tangibile; sostanza che non si può toccare e non si può apprezzare. Questo procedimento, dice Böhm-Bawerk, mi pare poco moderno.
Le risposte dei marxisti non si fecero attendere, anche se quasi tutte si trascinarono dietro la tara positivista di Böhm-Bawerk, il quale, lo si vede in modo chiaro in questa confutazione di Marx, confondeva allegramente la logica di Hegel, che è, a tutti gli effetti, una metafisica, con la logica formale. Anche quando le risposte contenevano spunti interessanti, come in Hilferding, si finì per deprecare la teoria del Plusvalore. Gli stessi Baran e Sweezy non si servirono più del concetto di Plusvalore, ma di quello di surplus. E Dobb, nella Prefazione alla riedizione del Capitale, disse che era tutto OK, escluso un piccolo difetto, e cioè il modo in cui Marx trasforma i valori in prezzi nel Terzo libro del Capitale.
Per fortuna l’errore venne corretto da Sraffa, e il marxismo riportato sul giusto binario. Senonché, sbottò giustamente Colletti, tutta la discussione iniziata da Bortkiewicz e conclusa da Sraffa è appesa al vuoto. Si voleva far credere che si possono asportare le fondamenta su cui poggia la costruzione teorica di Marx e al tempo stesso mantenere in piedi l’edificio.
Nel 1902, Hilferding, a soli 25 anni, replicò al più stimato e illustre rappresentante della scuola viennese, con un articolo – Böhm-Bawerks Marx-Kritik – pubblicato a Vienna nel 1904.
In Böhm, dice Hilferding, il rapporto tra domanda e offerta determina il prezzo, ma la grandezza del prezzo determina il rapporto tra domanda e offerta. Non esiste dunque nessun punto fermo in tutto questo disordine?
Nei fatti spiccioli non esiste alcun punto fermo, a meno che non vi venga introdotto. Ma introdotto da dove, se non esiste alcun aldilà, e tutto è un aldiqua?
L’empirismo moderno, sul quale poggia la scuola austriaca, era nato dall’esigenza di cercare il Vero a partire dall’esperienza. Ciò che è vero è necessariamente nella realtà effettiva, nel mondo che si offre alla percezione. Tale principio è contrapposto al Dover-essere con cui la riflessione si pavoneggia e disprezza il mondo effettivo in nome di un Aldilà. Tuttavia, l’empirismo scientifico, dice Hegel (Enciclopedia § 38), non si rende minimamente conto che, per conoscere la realtà effettiva, realtà che altrimenti apparirebbe ai suoi occhi come un grande disordine, adopera, sin da subito, le categorie metafisiche di Materia, Forza, Uno, Molteplice, eccetera, e io aggiungerei di Valore.
Che cos’è, dunque, questo valore, se non è, come pretende Marx in alcuni luoghi della sua opera – Manifesto, Per la critica, Lineamenti, Capitale – se non è la realtà effettiva stessa appiattita, omologata e ridotta ad Uno; e se, parimenti, non è, come pretende Marx in altri luoghi della sua opera – Manifesto, Per la critica, Lineamenti, Capitale – un aldilà del mondo effettivo?
Negli anni Sessanta la risposta era sotto gli occhi, bastava allungare la mano, ma ci si fece distrarre da una critica sterile al Diamat, o da una integrazione farraginosa di Freud e Marx, o di Keynes e Marx, o di Nietzsche e Marx, o di computisteria e Marx, o, addirittura, di Lacan e Marx, o di Schmitt e Marx.
Poi su tutti piombò la sentenza di Marcuse, rinvenuta in un foglio dei Grundrisse. Il lavoratore non è più produttore di valore, è un sorvegliante, e il mondo è diventato un penitenziario. Si tratta del famoso frammento sulle macchine, dove si dice che la creazione di ricchezza reale dipende meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro erogata che dalla potenza delle macchine messe in moto durante il tempo di lavoro. Il lavoro umano allora non appare più racchiuso nel processo di produzione; l’uomo si collega al processo di produzione come sorvegliante e regolatore. Il fondamento della produzione e della ricchezza non è più il lavoro compiuto dall’uomo, né il suo tempo di lavoro. Da questo momento il lavoro apparirà come una misera base a confronto della nuova base che la grande industria ha creato. Non appena il lavoro dell’uomo cessa di essere la fonte della ricchezza, il tempo di lavoro casserà di essere la sua misura.
L’archiviazione della questione del Plusvalore, e dunque dello sfruttamento, poteva considerarsi portata a termine. Poi arrivò l’anno 1967, col suo trionfo del politico, anzi, dell’autonomia del politico.
—-
* Saggio del plusvalore: è il rapporto nel quale il plusvalore sta alla parte anticipata di capitale variabile. È identico al rapporto in cui il tempo di plus-lavoro sta al tempo di lavoro necessario. Rapporto tra lavoro retribuito e lavoro non retribuito. Il saggio del plusvalore esprime la misura dello sfruttamento.
* Lavoro necessario: la parte del tempo di lavoro che remunera i costi di riproduzione del lavoratore.
* Saggio del profitto: è il rapporto nel quale il plusvalore sta alla parte anticipata di capitale variabile + capitale costante.
* Prezzo di costo: è uguale ai mezzi di produzione consumati (capitale Costante) + la forza-lavoro impiegata (capitale variabile).
* Prezzo di produzione: è uguale al prezzo di costo + la parte di profitto medio annuo sul capitale impiegato (e non solo consumato) nella produzione della merce, che tocca alla merce stessa proporzionalmente alle sue condizioni di rotazione. Coincide con il prezzo della merce.
Eugen von Böhm-Bawerk, La conclusione del sistema marxiano, 1896
Rudolf Hilferding, La critica di Böhm-Bawerk a Marx, 1904
Lucio Colletti, Marxismo e dialettica, in Intervista, 1975