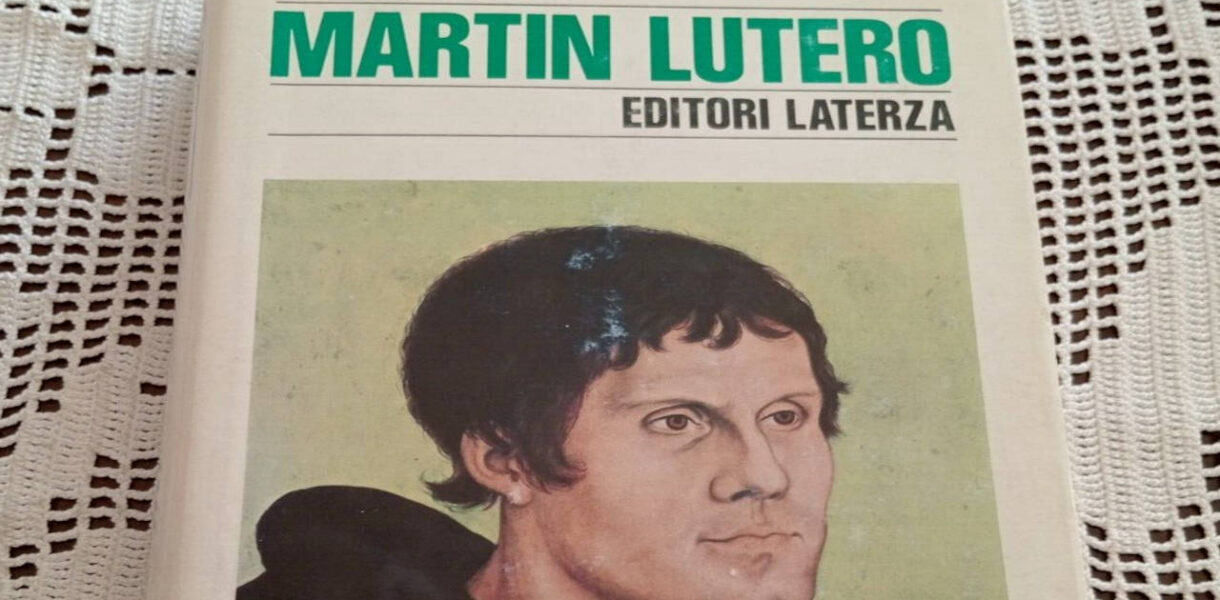Lutero ha un problema, e questo problema si chiama Peccato. Ciò che cerca è la Salvezza, una via che lo porti verso una vita giusta.
Secondo i più è stato il viaggio di Lutero nella Città Eterna, compiuto nel 1510, che condusse allo scisma dalla chiesa di Roma.
Cosa vide Lutero a Roma? Vide Babilonia maledetta, le sue cortigiane, i suoi sgherri, i suoi ruffiani, il suo clero simoniaco, i suoi cardinali senza fede e senza moralità. Vide che la via della pace prevedeva il pagamento di un pedaggio.
Quando ritornò in Germania, portò in cuore l’odio inestinguibile verso la grande prostituta. Gli eccessi, quegli eccessi che la cristianità unanimemente bollava d’infamia, egli li aveva visti, incarnati, vivere e prosperare insolentemente sotto il cielo romano. Soprattutto, lo aveva colpito lo scandalo dei soldi raccolti attraverso la politica delle indulgenze e spesi per alimentare la corruzione delle anime e delle menti.
Era la spaventosa miseria morale della Chiesa che gli si era mostrata nella sua nudità e che lo aveva turbato. Abusi materiali: commercio di beni sacri, traffico di benefici in urgenze, vita licenziosa del clero, rapida dissoluzione dell’istituto monastico; e, dall’altra parte, dissolutezza nel campo morale: decadenze, miserie di una teologia che riduceva la fede viva a un sistema di pratiche morte.
Questo è quello che si racconta di Lutero, dice Lucien Febvre (Martin Lutero). Ma le cose non andarono in questo modo. I problemi di Lutero non erano la lussuria della Chiesa e la vendita delle indulgenze, non erano la decadenza di Roma e la perdita di una purezza primitiva. Per Lutero non c’era un’origine intatta da ripristinare, un’unità con Dio prima della caduta di Roma. Per Lutero c’era il Peccato, e il tormento di non riuscire a trovare la via dal peccato alla salvezza.
Come posso, con le mie gambe, con le mie mani, con questo mio misero corpo, tendermi verso Dio e toccarlo, partecipare della sua grazia? Come posso io, misero peccatore, piccolo verme strisciante, ammasso finito di pelle o ossa, cloaca di peccati e miserie pretendere di innalzarmi a Lui, il puro, il vero, l’infinito?
Queste sono le domande che Lutero si pone. Non gli interessa Roma, dice Febvre. Il suo cruccio è il Peccato: non una semplice mancanza cui l’uomo rimedia con l’impiego di mezzi esteriori, ma la potenza maledetta, infinita, che separa per sempre l’uomo dal suo creatore. Come liberarsi allora dal dubbio, dalla disperazione e del terrore?
Lutero, dice Febvre, intravede la risposta in un lampo improvviso che illumina una folla di pensieri e di meditazioni interiori, e non lo dimentica più.
In quale momento della sua vita ha luogo, esattamente, questa rivelazione?, si chiede Febvre. Alla fine del 1512? Oppure nel 1513? Certamente, dice, prima della metà del 1514, nel convento di Wittenberg, nella torre.
Si trattava di una Rivoluzione radicale, dice Febvre, di singolare audacia. Non la forza del gladiatore combattivo, dice, ciò che ci si aspetta da un rivoluzionario vero, ciò che in genere ci si aspetta dalla Rivoluzione. Ma la passività completa e benedetta del rassegnato che, dice, dichiarandosi vinto prima della lotta, non ripone la propria speranza altrimenti che nell’eccesso stesso della sua sconfitta.
Il peccatore, dice, questa è la scoperta di Lutero, il peccatore che, disperando di sé e delle proprie opere, che si esaurisse nello sforzo di fuggire all’inferno, come meritato mille volte, si rifugia sotto le ali della chioccia chiedendo alla plenitudine divina il dono di quanto gli manca: costui non potrebbe conoscere la pace e la consolazione? No. La risposta sorprendente di Lutero è no. La questione deve essere ribaltata. La soluzione del problema per eccellenza, quello della giustizia, esige il capovolgimento dei termini del problema stesso.
La Chiesa cattolica, e Lutero ci credeva, diceva che per piacere a Dio è assolutamente necessario che l’uomo sia giusto, e che l’ingiusto può emendare i suoi peccati e diventare come Dio. Ma che l’uomo diventasse giusto, pensava Lutero, era impossibile: tra la santità di Dio e l’abiezione della creatura l’abisso è tale che, nel tentativo di alzare il più possibile con le sue braccia ridicolmente corte quelle piccole e derisorie scale che sono le buone azioni, l’uomo diventa grottesco, tanto da far dimenticare il suo fallo e la sua bestemmia.
Solo Dio è capace di sopprimere l’abisso accostandosi all’uomo, avvolgendolo di un amore efficace, di un amore che, penetrando la creatura, la rigenera, l’innalza al creatore. Non è l’uomo che emendato dal peccato può alzarsi sino a Dio, ma solo Dio, nella sua grazia, come Gesù, può scendere all’uomo, penetrarlo, riempiendogli il cuore di amore. A questo punto le opere scompaiono tutte, scompaiono le penitenze, le preghiere, le orazioni, scompaiono soprattutto tutti gli intermediari che si erano frapposti fra l’uomo e Dio e che si facevano pagare o pregare per aiutarlo nella remissione dei peccati in vista della della vita eterna, dell’assoluzione definitiva, della giustizia, della verità.
La salvezza? Che cos’è ora la salvezza? La salvezza non consiste più nell’elevazione a Dio, consiste nella propria differenza rispetto a Dio, nella propria imperfezione: non il perfetto, ma l’imperfetto, non il santo, ma il peccatore.
Ho tracciato sin qui l’evoluzione spirituale di Lutero dice Febvre, da 1505 a 1515, senza neppure accennare al famoso viaggio a Roma che tutti gli storici, sulla parola di Lutero, hanno per tanto tempo considerato l’origine, come la fonte stessa, dell’attività riformatrice dell’agostiniano. Per quale ragione? Per la ragione che, dice, del contatto con gli uffici della Santa sede, con i cardinali, Lutero riportò un’impressione molto favorevole che espresse diverse volte. Certo, durante le quattro precise settimane trascorse nella città eterna, dalla fine di dicembre, alla fine di gennaio, che Lutero sia stato più o meno toccato in qualcuno dei suoi pregiudizi, urtato in alcuni suoi sentimenti da abitudini, da espressioni e comportamenti che gli erano profondamente estranei (c’è una certa distanza tra Wittenberg e il Vaticano) sono cose che ci interessano poco, e ancor meno interessano la storia della Riforma.
Quello che importa Lutero dal 1505 al 1515, dice Febvre, non è la riforma della Chiesa: è Lutero; l’anima di Lutero, la salvezza di Lutero, questo solo. E, del resto, non è appunto questa la sua grande vera originalità? A una religione che poneva il fedele validamente circondato e inquadrato in un’ampia e magnifica costruzione nella quale i materiali della Giudea erano uniti a quelli provenienti dall’Ellade: a pianterreno, la solida massa dell’aristotelismo, al primo piano, ben saldo sulle robuste colonne del liceo, un vangelo mutato in teologia, sostituire una religione del tutto personale che ponesse la creatura, direttamente senza intermediari, in faccia del suo Dio, sola, senza seguito di meriti o di opere, senza mediazione parassitaria né di preti né di santi mediatori né di indulgenze acquisite in questo mondo e valide nell’altro o di assoluzioni liberatorie nei confronti dello stesso Dio: è a questo che doveva tendere anzitutto lo sforzo del riformatore.
Lutero pretendeva una Chiesa che fosse all’altezza dell’uomo nuovo che in lui si stava manifestando. Chi era quest’uomo, verso cosa mirava?
Ci si agitò senza dubbio, intorno a Leone X, quando giunsero le allarmanti notizie da Wittenberg e da Magonza. Mazzolini e Miltiz, dice Febvre, ne fecero subito una questione politica – geopolitica (si direbbe oggi). Non erano in gioco i destini dell’Italia e della Germania, i destini del Sacro Romano Impero e della Santa Sede, gli interessi congiunti del papato e dell’impero? Interessi economici forti – certamente! Minacciati dalle potenze regionali nascenti degli Stati monolitici.
Lutero, dice Febvre, rappresentava nella fragile Germania, il pericolo di una demolizione; si poteva permettere che guastasse tutto? Tutto? Ma che cosa? Le basi di una devozione tradizionale? Una costruzione dogmatica? Non questo; ma le posizioni della Santa Sede nel mondo tedesco. La politica anzitutto!
Che si schiacci quel bruto, senza perdere un istante; si discuterà poi. Ed ecco come, nel giugno del 1518, Ghinucci e Mazzolini, giudici costituiti, il fior fiore della diplomazia romana, dunque universale, citarono Lutero a Roma. Ecco come la Chiesa, dice Febvre, una volta ancora, dovette pagare le spese della grande politica Italo-europea degli Alessandri VI, dei Giuli II e dei Leoni X. E se Massimiliano aiutò, si trattò ancora di politica: doveva aiutare la curia perché questa, in cambio, accettasse la candidatura di Carlo all’Impero.
Innanzitutto bisognava considerare la politica, le alleanze, e la disposizione delle forze nello scacchiere internazionale, senza cianciare e perdere tempo e distrarsi con questioni secondarie (sovrastrutturali), addirittura sentimentali – filosofiche -, che hanno a che fare con la posizione dell’uomo nel mondo, e non il suo rapporto con altri uomini, ma il rapporto suo rispetto al proprio cuore, alle proprie emozioni, alla propria persona, al proprio dolore, quel ramo dell’interesse umano, che se proprio gli si vuol trovare una collocazione mondana si potrebbe chiamare politica del cuore, a tutto ciò l’alta diplomazia Cattolica, la migliore al mondo, la più astuta, la più sveglia, la più dotata, non diede seguito. Se con tanta prontezza quegli uomini gridarono all’eresia, dice Febvre, domandarono sanzioni, andarono subito agli estremi, questo avvenne perché i diplomatici calcolatori che dirigevano la Chiesa erano diventati incapaci di comprendere e di ammettere lo sforzo, anche brutale, di un credente appassionato per ritrovare in fondo al cuore le origini profonde della vita religiosa. Dell’insegnamento di Lutero, della sua predicazione, dice, essi videro anzitutto i frutti temporali, e furono totalmente ciechi a quella rivoluzione che stava avvenendo un po’ dappertutto in Europa e che riguardava appunto la nascita di un uomo nuovo, troppo presi dalla politica, dalla giustizia politica, lisciarono ciò che di più importante stava avvenendo in quel momento nel mondo: la nascita della persona borghese.
Certo, dice Febvre, Lutero non agì nel vuoto, tutto lo sconquasso che provocò, e lo provocò senza programmarlo, addirittura senza volerlo esplicitamente, tutto quello sconquasso aveva bisogno di un aiuto, di un quadro generale pronto ad esplodere. Quel quadro, in quegli anni, in Germania e in Europa, era pronto. C’erano Erasmo e il suo umanesimo, c’erano Thomas Müntzer e i contadini insoddisfatti, c’era, soprattutto, una nascente borghesia, fatta di piccoli e grandi commercianti alleggeriti da pedaggi e balzelli, di artigiani stretti nelle corporazioni, di banchieri e prestatori a interesse tenuti per appestati, di gente comune che aspirava a vivere come meglio credeva, liberandosi dal giogo del servizio e della signoria, dall’intermediazione del giurista e del monaco per leggere e per scrivere, per mandare una missiva o intendere il ciclo della luna e il ciclo del sole, le ore di lavoro e le ore di preghiera, fatta di villani tenuti a rendicontare il tempo di digiuno e il tempo di festa, quando potevano parlare e quando dovevano tacere, cosa dovevano produrre e in che quantità, e chi poteva comprare e quanto doveva pagare. La nascente borghesia, con un mercato che varcava gli angusti confini della signoria, voleva produrre in libertà. Voleva che ognuno, per conto proprio, decidesse cosa produrre e in che quantità, decidesse a chi vendere e a quale prezzo. Una borghesia che aspirava a quella cosa che diventerà in Europa il mercato libero delle merci e delle persone e dei capitali.
Saranno le voci di una Germania inquieta che si uniranno a quella di Lutero, frementi di passioni mal contenute, dice Febvre, che non aspettavano altro che un uomo, per rivelare pubblicamente i desideri segreti. Istante decisivo in cui, di fronte a Martin Lutero, avanza sulla scena l’uomo tedesco del 1517, pieno di energie contrastanti: collaboratore anonimo, ma la cui parte nel corso dell’opera diventerà sempre più importante. È lui che, di colpo, farà nascere e abortire l’opera originale, l’opera che in un solo getto un Monaco portava in sé e di cui dinanzi alla storia non ha firmato che una copia contraffatta.
Che cos’era la Germania nel 1517?, si chiede Febvre. Terreni fertili, potenti risorse materiali, città splendide, orgogliose; lavoro dappertutto, iniziative, ricchezze, ma nessuna unità, né morale né politica: anarchia. Infiniti e confusi desideri, spesso contraddittori; amarezza per una situazione torbida e, spesso, umiliante; e, dall’altro canto, impossibilità assoluta di portarvi rimedio. E poi c’erano gli italiani, dice Febvre. Quegli italiani che si burlavano dei buoni e leali tedeschi, quegli italiani vivaci, motteggiatori, disinvolti, senza scrupoli né fede, senza serietà né profondità che, con il pretesto di servire i grandi interessi della cristianità non servivano che i loro appetiti, spillando alla Germania tanti bei Ducati. Furore si aggiungeva a furore.
Lutero, dice Febvre, una volta saltato il fosso, lo proverà sempre, in fondo al suo cuore di tedesco, di popolano.
Non c’è nazione più disprezzata della Germania! pensava Lutero. L’Italia ci chiama bestie, la Francia e l’Inghilterra si burlano di noi, e così tutti gli altri.
Quali erano questi interessi tedeschi? Innanzitutto, dice Febvre, erano gli interessi degli uomini delle città, la massa compatta relativamente omogenea, seria, istruita, dei borghesi. Uomini votati agli affari, che volevano guadagnare denaro, che avevano dedicato la propria vita al guadagno, che fissavano il profitto come scopo della propria attività.
Il borghese che riesce negli affari raggiunge la ricchezza, la vera ricchezza, dice Febvre, e non solo l’onesta agiatezza, la ricchezza con tutto quello che essa procura insieme a moneta da serrare nei forzieri e a gioielli e stoffe sontuose. Insieme a tutto ciò il borghese, dice Febvre, acquista ancora un’altra cosa, un sentimento di importanza sociale del tutto nuovo, di dignità, di indipendenza, di autonomia. Alla borsa di Anversa come allo Stahlof di Londra o sulle banchine di Lisbona ognuno fa da sé, ma ognuno precisamente si abitua a non attendere altro aiuto che da se stesso, a non accettare consiglio che dalla propria prudenza. Finalmente liberi si può sbagliare per proprio conto, rischiare il proprio patrimonio e la propria vita. Perché la vita non appartiene più al padrone, non appartiene al marito o alla moglie, non appartiene alla famiglia, alla corporazione, al signore, eccetera. La vita si appartiene. Ci si appartiene, e tutto ciò che è nostro ci appartiene. Si investe e si rischia in prima persona.
I borghesi tedeschi all’inizio del XVI secolo, i commercianti, soprattutto, cominciano a guadagnare denaro, molto denaro. Le tradizioni di una società che non consente un posto onorevole, dice Febvre, i princìpi di una morale per meschini, a questi uomini, cui la fortuna sorrideva, sembravano importuni e ostili. Essi, dice, scuotono il gioco, impazienti; ne discutono la legittimità solo col guadagnare denaro. Mettono in discussione tutta la vecchia mentalità artigiana del medioevo. Contro di essa, dice, gli uomini nuovi, i primi rappresentanti di uno spirito veramente capitalistico, lanciano un’accusa di falso, violentemente. Le vecchie proibizioni pesano intollerabili su tutto. Essi non amano la Chiesa che li infastidisce, li impastoia, li indica come ribelli, nemici pubblici. La rivoluzione morale che si annuncia, dice, e che da parte loro compiono di già, comincia appena negli spiriti e nelle coscienze.
Ognuno per sé, nella lotta economica, davanti agli occhi del concorrente, davanti agli occhi della fortuna e davanti a Dio. Questo è il nuovo vangelo. Quei preti, quei religiosi che intervengono tra l’uomo e la divinità, quei monaci e quelle monache che si ritirano dal mondo e si votano a una vita piena di austerità, nella fiducia che Dio devolverà ad altri i benefici e i meriti del loro sacrificio, costoro, ebbene, non sono più capiti dal commerciante arricchito di Amburgo o Norimberga. Perché tanto zelo? Che cosa vogliono da lui quegli inetti che sembrano prendersi beffa, con la loro calma, delle sue agitazioni, che pretendono interporsi tra la creatura e il creatore? Sono degli indiscreti, degli inutili, dei parassiti. Credono forse che uno non possa e non sappia fare a meno di loro? Ognuno per sé. Che lavorino, invece di percepire la decima da chi stenta e si affatica. Rimbocchino le maniche, si facciano animo, partecipano alla bisogna comune, e la smettono di offrire una mediazione che nessuno chiede più. Diritto davanti a Dio, sarà l’uomo a rispondere dei suoi atti. E se le genti di chiesa invocano l’oscurità dei dogmi, la difficoltà dell’interpretazione di una religione che solo il prete è in grado di insegnare, il fatto è che essi l’hanno complicata al loro talento per rendersi indispensabili. Dio che parla all’uomo e l’uomo che parla con Dio è un linguaggio chiaro, diretto, comprensibile a tutti, questa è la vera religione.
Così, dice Febvre, pensavano e sentivano, ancora confusamente ma con una chiarezza e una forza sempre più grandi, non i tedeschi negli anni intorno al 1520, ma una parte di loro, una parte della borghesia cittadina. Una parte importante, non tutta la Germania, dice Febvre. Tuttavia, in virtù della sua massa, della sua superiorità culturale, del suo credito morale, la borghesia predominava su tutto il resto.
Affiggendo le sue tesi a Wittenberg, Lutero metteva il piede fuori dal suo piccolo mondo chiuso di monaci e teorici, faceva un passo, dice Febvre, un primo ma decisivo passo, verso la Germania che ho descritto. Una Germania composta di venti Germanie diverse.
La voce di Lutero, la voce che si alza su tutte le altre, non è la voce di un logico che avesse limpidamente difeso un sistema di idee coerenti, perfettamente legate, che non ammettesse equivoci, una voce così non sarebbe stata che una voce in più nel clamore inutile e confuso della Germania. Lutero, dice Febvre, non è nemmeno un uomo di buon senso, prudente, che avesse ponderato le sue azioni prima di compierle, che avesse posato il piede soltanto su un terreno fermo e saggiato in precedenza. Un tale uomo, dice, avrebbe fatto e detto quello che faceva e diceva precisamente Erasmo. Lutero non era un logico, un saggio, più di quanto non fosse un uomo di chiesa, desideroso di compiere opere grandi e belle, di condurre una vita devota, virtuosa e sana. Era un istintivo, dice, il quale seguiva i suoi impulsi, senza preoccuparsi di difficoltà, di opposizione o di contraddizioni, e che non scorgeva con l’intelligenza, ma conciliava nell’unità profonda di un sentimento vivo e dominatore. Lutero, dice Febvre, non era un dottore, né un teologo: era un profeta. E poiché era tale, sarebbe riuscito in questa impresa straordinaria: mettersi a capo di una Germania anarchica e darle per un istante l’illusione che essa voleva, unanime, quello che egli voleva, con tutta la sua passione. Per qualche mese, di mille voci diverse egli avrebbe fatto un coro magnifico, che avrebbe lanciato, attraverso il mondo, con una sola anima, un unico canto.
Lutero non è Erasmo. Sebbene anche il suo sia uno slancio ideale, e molti sono i punti di contatto con il grande umanista, ma al fondo, la differenza è enorme.
Erasmo, dice Febvre, era un membro di quella società erudita e colta che in tutta l’Europa cristiana, da anni, sognava una riforma dell’antica società. Si trattava, dice Febvre, di uomini nutriti di greco e di latino, ammiratori di grandi antichi di cui la nascente filologia e l’arte della stampa restaurava e volgarizzava le opere, a quei maestri di un pensiero indipendente dal pensiero cristiano essi non chiedevano soltanto lezioni di eloquenza o soddisfazioni letterarie. Essi ne assorbivano le idee, ne raccoglievano l’ispirazione largamente umana, ne traevano i principi di una morale altruista, indipendente dal dogma, un tesoro di cui pretendevano arricchire, ornare un cristianesimo che essi sognavano umanizzato, ampliato e come alleggerito da questo incomparabile apporto.
Erasmo, dice Febvre, rappresentava tutto ciò: uomo fine, ponderato, ragionevole. Sapeva bene quello che era la Chiesa di Roma con le sue molle potenti e nascoste, la sua influenza diplomatica sui sovrani, le sue infinite risorse materiali e morali. Egli, dice, si guardava bene dal sottovalutarne la potenza; si rendeva conto che per cambiare, nel modo che desiderava, un modo suo, che non era quello di Lutero, le basi tradizionali della vita cristiana, per far trionfare quella filosofia di Cristo vivo che la religione dello spirito che egli esponeva e predicava con una convinzione di cui non bisognava dubitare, con un ardore che non era senza pericoli, la condizione preliminare, assolutamente indispensabili, era quella di rimanere nel giro della Chiesa.
Al confronto di Erasmo, l’intellettuale cosmopolita, Lutero appare come un buzzurro di provincia, un piccolo contadino acculturato, grossolano, rozzo, che, con la stessa energia priva di riguardi, proclama il suo odio per Aristotele, per la sua metafisica, per la sua logica, la sua etica.
La logica, scriveva Lutero, la scienza e la legge, soprattutto la Legge, non può erigersi sopra la grazia, sopra il cuore. Ogni opera guidata della legge ha l’apparenza di una buona azione. Ma considerata da vicino non è che un peccato. Maledetti coloro che adempiono alle opere della legge; benedetti coloro che adempiono alle opere della grazia. La buona legge che fa vivere il cristiano non è la legge del Levitico; non è il Decalogo; è l’amore di Dio, diffuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo.
Lutero, dice Febvre, è, in ogni cosa, della sua razza e del suo paese. Egli è fondamentalmente un tedesco per il suo modo di pensare, di sentire, di agire. Tutto questo, dice Febvre, è stato detto. Anche troppo. Ma bisognerebbe pure ricordarsi che in convento egli pensava non ai tedeschi, ma ai cristiani. Quando, venuto in possesso della sua certezza, si accinse a comunicarne il segreto, si rivolse a tutti gli uomini, e non ai suoi fratelli di razza o di lingua.
Al cospetto di questo monaco tedesco, radicato nella sua terra e nella sua razza, Erasmo spicca come un uomo di mondo, come un pensatore davvero universale, che parla insieme agli italiani e agli inglesi, agli olandesi e ai francesi, ai tedeschi e agli spagnoli, e tutti, insieme, lo cercano e gli parlano, e lo seguono come una stella di prima grandezza. Patria di Erasmo, dice Febvre, era la cristianità colta: per questa egli lavorava, pensava, pubblicava le sue grandi edizioni, i suoi dotti trattati. E quello che sognava none era una riforma della Chiesa condotta per settori, limitata agli stretti confini di questo o di quel paese, ma un rinnovamento, un totale ampliamento del cristianesimo, la diffusione di uno spirito composto di ragione umana e nutrito di cultura antica, che avrebbe visto rinascere quell’unità di civilizzazione spirituale e morale che gli uomini del XIII secolo avevano concepito come il loro ideale, e che gli umanisti del XVI secolo avrebbero realizzato con maggiore ampiezza, libertà e profonda saggezza.
Lutero sa che il richiamo allo splendore classico è il richiamo alla legge. A guidare gli uomini dovrebbe essere allora la legge? No, risponde Lutero. Il cristiano, dice, è libero dalla legge mosaica, non solo dalla legge cerimoniale dell’antica alleanza, ma anche dal Decalogo, da quei dieci comandamenti che Mosè ha dato agli ebrei. Agli ebrei, ribadisce, e non ai cristiani. E Mosè, dice, è un dottore, un grande dottore, senza dubbio, ma non è certo il legislatore nostro, di noi cristiani. La legge? Cosa ne farebbe un cristiano? Cristo non l’ha forse soppressa e vinta? La legge? Cristo ci ha dato il Vangelo, il suo contrario.
La fede non ha bisogno della legge. La fede è la signora di tutti i testi, di tutte le leggi. Essa ha diritto di controllo su di essi, in nome di quella certezza che deriva da se stessa. Bisogna che senta io stesso quello che dice Dio. Ma come sentirlo? Aderendo con la propria ragione a un credo, a una somma dottrinale? Che sciocchezza!, dice Lutero. Si può predicare la Parola, ma Iddio soltanto può imprimerla nel cuore dell’uomo. Cade tutto quanto non è fede, quanto non è contatto intimo dell’anima misera, pienamente cosciente della sua miseria, con la prodigiosa, inimmaginabile santità di Dio: divine nozze di una creatura impura e di un Dio che, rialzandola dalla sua ignominia, si addossa i suoi peccati inespiabili e le dà in cambio i doni della sua saggezza e della sua felicità.
Si tratta di un passaggio importante, che segna la differenza con Erasmo. L’uomo rimane e deve rimanere confinato nella sua finitezza. Deve rimanere nella polvere, orgogliosamente prostrato, peccatore, finito, sopraffatto. Deve rimanere nella sua differenza con Dio. Non deve alzarsi all’altezza della legge. Non può alzarsi all’altezza della legge. Sarebbe non solo sacrilego, ma sarebbe una rinuncia maggiore rispetto a rimanere nel peccato. Riconoscersi nel peccato, riconoscersi colpevoli, è ancora un riconoscersi come creature. Che si sappia, dice Lutero, essere un uomo devoto, eseguire grandi, numerose opere, condurre una vita buona, onorevole e virtuosa, è una cosa, essere un cristiano è un’altra, del tutto diversa. Non si è cristiano perché si è buono, giusto e pio; non si è per nulla cristiano se l’intenzione è innalzarsi nel bene sino a Dio. Si è tale quando, mediante la fede, si fa penetrare Dio nel proprio cuore. Allora non bisogna più preoccuparsi di moralità. La morale non può essere frutto di volontà umana; è un frutto della fede.
Rispetto a questo punto Febvre precisa quanto segue. Bisogna stare attenti a non considerare Lutero come un razionalista, e intendere la sua dottrina come una fondazione della verità sulla certezza della coscienza individuale. Bisogna ripetere di guardarsi dal fare delle parole di Lutero, dice Febvre, la solenne proclamazione, di fronte al vecchio mondo, di quanto in noi chiamiamo libertà di coscienza e libertà di pensiero. Lutero, dice, non fu mai un liberale come lo intendiamo oggi. Egli, dice, non voleva difendere la tesi che ognuno deve liberamente disporre delle proprie facoltà né proclamare i diritti sul dogma della ragione umana. Lutero voleva invece sottomettere ragione e coscienza all’unica autorità che riconoscesse; e non la cercava fuori di sé, come può fare un cattolico con la Chiesa, con la tradizione, con l’autorità, o un razionalista con la legge logica e il raziocinio, che non sono altro che un andare al di là del mondo, del corpo e dell’anima: l’attingeva in sé, quella parola di Dio creatrice in ognuno di noi di necessità più forte di tutte le costrizioni. Non ci si trova davanti a una ragione ragionante, dice Febvre, con una logica chiara e dritta. Si offre a noi una creatura che afferma la sua vita in mezzo a contrarietà e difficoltà. Una povera creatura, che lotta e si dibatte contro le leggi inesorabili del pensiero, e talvolta naufraga alla deriva. Ma c’è questo, che l’anima umana, dice Lutero cento volte, non è impedita da nulla: eterna, essa domina il mondo. Come potrebbe farsi legare dal di fuori, come potrebbe ascoltare voci diverse dalla sua? Papi, concili, dottori, leggi, niente di tutto questo è valido. La stessa lettera del Libro Sacro non conta. Se l’anima cerca la propria verità in lei e in lei sola, la troverà. E la troverà, e nessuno potrà più ergersi come sovrano di fronte ad essa, perché in fondo al cuore c’è l’infinita grazia di Dio, e di fronte all’infinito nessun altro potere resiste.
Le ragioni del cuore e l’uomo borghese